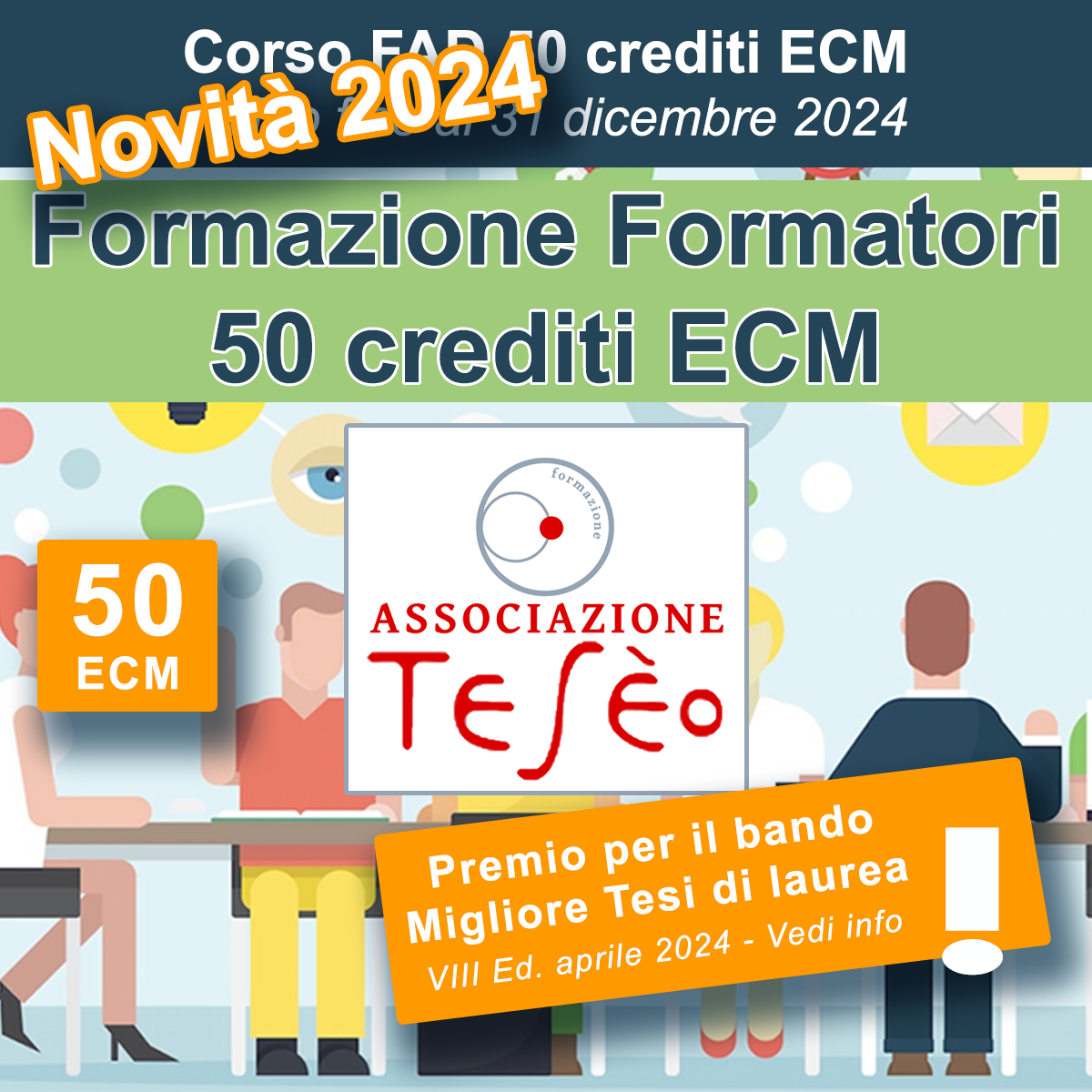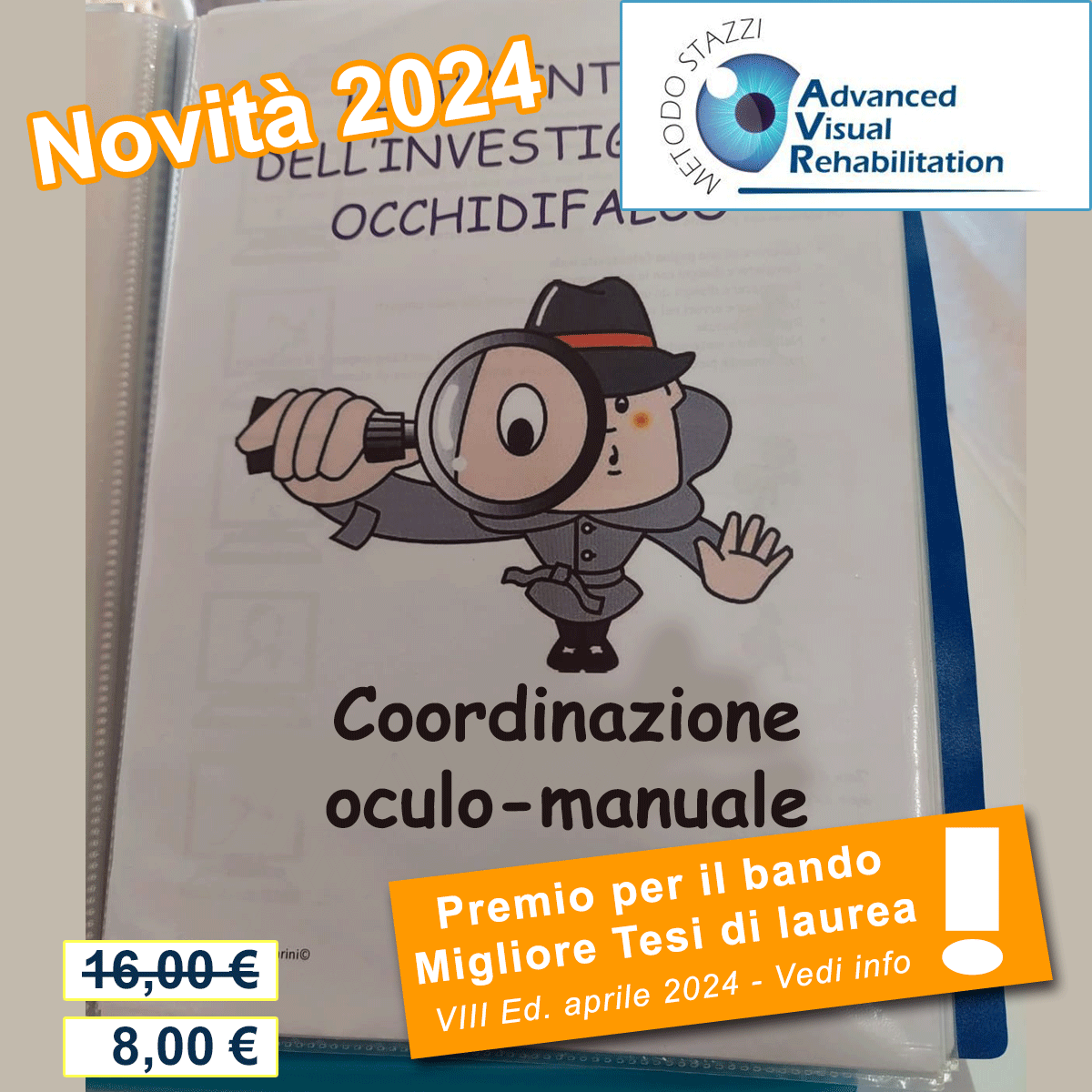La disabilità intellettiva
Alice Friscione
Visite: 27415
- Definizione di disabilità intellettiva
- Eziologia e cenni epidemiologici
- Classificazioni
- Disabilità intellettiva e rappresentazione mentale
- La disabilità intellettiva lieve
Definizione di disabilità intellettiva
La quinta edizione del Manuale Diagnostico e Statistico dei disturbi Mentali (DSM-5, 2013) propone un nuovo approccio al ritardo mentale e utilizza per la prima volta l’espressione “disabilità intellettiva”, disambiguando il termine ritardo che presuppone una normalizzazione che in realtà non avviene. Da un approccio diagnostico di tipo categoriale, fondato sulla misurazione del quoziente intellettivo (QI), si passa in questa edizione a una visione dimensionale, per cui le diverse forme della patologia vengono considerate come un continuum di dimensioni (forme di gravità maggiore o minore) e non sono più separate rigorosamente. La disabilità intellettiva, descritta dai manuali diagnostici precedenti in termini quantitativi, viene ora definita nei suoi aspetti qualitativi. Il concetto di QI perde di importanza, mentre assume un valore maggiore il profilo neuropsicologico del soggetto. La disabilità intellettiva (DI) viene definita come un disturbo che insorge in età evolutiva e che comporta compromissioni del funzionamento intellettivo e del funzionamento adattivo negli ambiti della concettualizzazione, della socializzazione e delle capacità pratiche.
La diagnosi di disabilità intellettiva viene formulata sulla base di tre criteri:
- Criterio A – Presenza di un deficit nelle funzioni intellettive, come il ragionamento, il problem solving, la pianificazione, il pensiero astratto, la capacità di giudizio, l’apprendimento scolastico e l’apprendimento dall’esperienza. Tali deficit devono essere confermati da una valutazione clinica e da test di intelligenza individuali standardizzati.
- Criterio B – Presenza di un deficit in almeno uno dei domini del funzionamento adattivo: concettualizzazione, socializzazione, capacità pratiche. La compromissione è direttamente correlata ai disturbi intellettivi e presenta una gravità tale da limitare in maniera significativa il funzionamento di uno o più ambiti della vita quotidiana, come la comunicazione, la partecipazione sociale e la vita autonoma in molteplici contesti (casa, scuola, lavoro, comunità). Il deficit adattivo necessita quindi di un supporto continuo.
- Criterio C – I deficit intellettivi e adattivi hanno esordio durante il periodo dello sviluppo.
Eziologia e cenni epidemiologici
Le cause della disabilità intellettiva sono molteplici e possono essere suddivise in biologiche ed ambientali. Tra le cause biologiche, le anomalie genetiche (ad esempio, trisomia o delezione) assumono una rilevanza significativa in quanto rappresentano almeno il 50% della casistica (Vianello, 2008). Altre cause biologiche possono essere legate a fattori prenatali (ad esempio, infezioni della madre durante la gravidanza, esposizione a tossine e agenti teratogeni o malformazioni del sistema nervoso centrale) perinatali (ad esempio, prematurità, ipossia, ischemia o emorragie intracerebrali) o postnatali (ad esempio, traumi, tumori del SNC o infezioni del SNC). Le cause ambientali invece consistono in malnutrizione e gravi deprivazioni psicosociali, queste ultime risultano al giorno d’oggi meno frequenti e in progressiva diminuzione in tutto il mondo (Vianello e Mammarella, 2015). Tuttavia in molti casi (30-40%) l’eziologia rimane sconosciuta, in quanto difficile da indagare con i mezzi diagnostici attualmente disponibili (American Psychological Association, APA, 2016).
La disabilità intellettiva è un disturbo molto frequente e presenta una prevalenza che varia, in base alle statistiche, dall’1 al 3%. In Italia si calcola che tra gli allievi certificati, più del 65% presenta una disabilità intellettiva (Vianello e Mammarella, 2015). La prevalenza è maggiore nei maschi con una frequenza di circa una volta e mezza maggiore rispetto alle femmine.
4.3 Classificazioni
Come è stato accennato nel primo paragrafo, la disabilità cognitiva è un continuum dimensionale che comprende diversi livelli di gravità. A seconda della gravità possono essere identificate quattro forme di disabilità intellettiva: lieve, moderata, grave ed estrema. Nel DSM IV la suddivisione è di tipo quantitativo e si basa sui valori di QI, calcolati attraverso test standardizzati (Tab. 1):
|
Grado di disabilità intellettiva
|
Quoziente intellettivo |
|
Lieve
|
da 50-55 a 70 |
|
Moderato
|
da 35-40 a 50-55 |
|
Grave
|
da 20-25 a 35-40 |
|
Estremo
|
< 20-25 |
Tabella 2: classificazione dei livelli di gravità della disabilità intellettiva in base al QI.
Ci sono poi i casi di funzionamento cognitivo borderline, o casi limite, che presentano un QI compreso tra 70 e 85.
Nel DSM-5 la classificazione passa su un piano qualitativo e si slega dal concetto di quoziente intellettivo. I livelli di gravità vengono definiti in base alle capacità adattive del soggetto. Il funzionamento adattivo, che a sua volta dipende dal funzionamento intellettivo, determina il grado di supporto necessario per una qualità di vita accettabile (Fig. 2).

Figura 3: gradi di dipendenza tra funzionamento intellettivo, capacità adattive e supporti necessari nella disabilità intellettiva.
Per determinare la qualità del funzionamento adattivo è necessario indagare le capacità che appartengono ai suoi tre domini:
- Dominio concettuale – linguaggio (recettivo ed espressivo), lettura, scrittura, concetto di denaro, autonomia decisionale.
- Dominio sociale – competenze interpersonali, responsabilità, autostima, raggirabilità, inesperienza, rispetto delle regole e delle leggi.
- Dominio pratico – abilità di vita quotidiana igiene personale, attività strumentali di vita quotidiana, abilità lavorative, mantenimento della sicurezza ambientale.
Il livello di gravità della disabilità intellettiva aumenta in maniera direttamente proporzionale al grado di compromissione in queste tre aree e, di conseguenza, al grado di necessità di supporti e dipendenza dall’altro. Secondo questa prospettiva Il funzionamento dell’individuo con disabilità cognitiva risulta quindi peculiare e atipico piuttosto che “rallentato” e “limitato”.
Come rappresentato in Fig. 3, la disabilità intellettiva lieve è preponderante in termini di frequenza rispetto agli altri livelli di gravità e rappresenta circa l’85% di tutte le disabilità intellettive. Il grado medio costituisce il 10% della casistica, mentre i gradi grave e profondo risultano mento frequenti e sono stimati rispettivamente attorno al 3% e 2%.

Figura 3: frequenza relativa dei diversi gradi di disabilità intellettiva.
Disabilità intellettiva e rappresentazione mentale
La natura funzionale della disabilità intellettiva non risulta ancora del tutto chiara. In passato le diverse teorie facevano riferimento a tre tipi di ipotesi: pre- intellettive, intra-intellettive e post-intellettive (Levi e Musatti, 1988).
- Ipotesi pre-intellettiva: la natura della DI sta nel deficit degli strumenti cognitivi di base (ed esempio, attenzione, percezione, memoria).
- Ipotesi intra-intellettiva: la natura della DI sta nel deficit delle connessioni e relazioni tra le componenti cognitive.
- Ipotesi post-intellettiva: la natura della DI sta nel deficit dei selettori, ovvero dei processi che selezionano le componenti cognitive da attivare.
A partire da tali approcci, sono stati elaborati modelli di tipo integrato, che risultano attualmente più validi. Questi prendono in considerazione sia le funzioni
cognitive specifiche, isolate e nel loro insieme, sia alcuni dei processi che le attivano (Stenberg e Speare, 1985) e attestano l’impossibilità di individuare un deficit settoriale specifico come nucleo della patologia. Il problema non risiederebbe quindi nelle singole componenti cognitive, ma consisterebbe in qualcosa di più ampio.
Facendo riferimento ai modelli rappresentazionali sul funzionamento della mente (descritti nel Cap. 1) questo qualcosa, ovvero il nucleo problematico della disabilità intellettiva, può essere identificato nel deficit delle abilità rappresentative e meta-rappresentative (Ivancich Biaggini, 2006). Secondo tali modelli la rappresentazione è la forma con cui esistono e in cui vengono codificate le informazioni nella mente dell’individuo. Il sistema cognitivo evolve grazie alle progressive rielaborazioni delle informazioni, ovvero ai rimaneggiamenti delle rappresentazioni (ridescrizione rappresentazionale, Karmiloff-Smith). I processi cognitivi più complessi, deficitari nella disabilità intellettiva, dipendono da tale capacità di rimaneggiamento della rappresentazione.
Anche analizzando le caratteristiche cliniche che accomunano gli individui con disabilità intellettiva, si osserva che le difficoltà proprie di questa patologia sono strettamente legate alle competenze rappresentazionali e meta- rappresentazionali. In particolare risultano deficitarie: la flessibilità cognitiva (capacità di adattamento degli schemi cognitivi a contesti diversi e variabili), la generalizzazione (capacità di usufruire delle informazioni apprese in un dato contesto per affrontare altri contesti), la scelta strategica (capacità di programmare e utilizzare la strategia più efficace per la risoluzione di un compito), l’apprendimento implicito (capacità acquisire informazioni attraverso processi di deduzione dall’esperienza) e l’integrazione cognitiva (capacità di mettere in relazione le informazioni apprese da aree di esperienza diverse) (Ivancich Biaggini, 2006).
Il nucleo funzionale della disabilità intellettiva consisterebbe nella difficoltà
dell’individuo a operare sulla conoscenza e, quindi, sulle rappresentazioni mentali.
Viene confermata l’ipotesi della natura qualitativa della disabilità intellettiva: il problema non è legato alla quantità di conoscenza, ma alle difficoltà di operare su tale conoscenza.
La disabilità intellettiva lieve
La disabilità intellettiva lieve è una problematica per certi aspetti ambigua. Il termine “lieve” infatti può risultare fuorviante, in quanto richiama a una situazione di gravità minima, non quantificata, e che potrebbe per questo essere sottovalutata. In realtà si tratta di una condizione estremamente rilevante, sia per le sue proporzioni epidemiologiche, sia perché significativa dal punto di vista clinico, in quanto associata a compromissioni neuropsicologiche, psicologiche e psicopatologiche che comportano una mancata autonomia per tutta la durata della vita.
Rispetto agli altri gradi di severità della disabilità intellettiva, i soggetti con un deficit lieve, presentano in genere maggiori possibilità di evoluzione, se ben supportati. Infatti, un grado lieve di disabilità cognitiva rende comunque possibile l’accesso al piano astratto della rappresentazione mentale e della meta- rappresentazione, aspetti che risultano invece molto più compromessi nelle disabilità maggiori. Per questo motivo i casi clinici scelti per il presente elaborato di tesi rientrano tutti nella fascia lieve della disabilità intellettiva.
| Indice |
| INTRODUZIONE |
|
Prima parte - Riferimenti Teorici
Seconda parte – Contributo Clinico |
| COMPARAZIONE E DISCUSSIONE DEI RISULTATI DELLA VALUTAZIONE |
| CONCLUSIONI |
| BIBLIOGRAFIA |
| Scheda di osservazione delle abilità rappresentative |
| Tesi di Laurea di: Alice FRISCIONE |