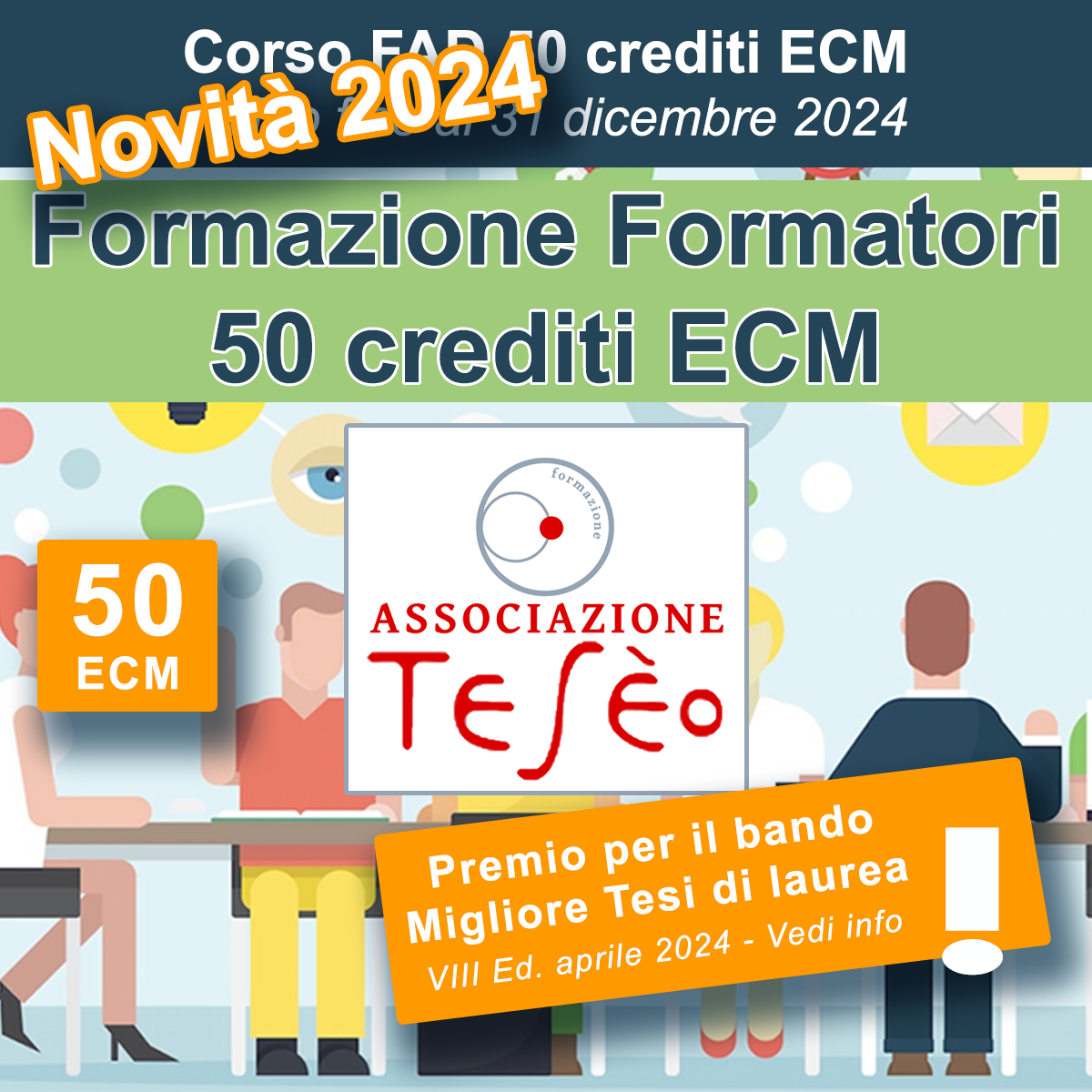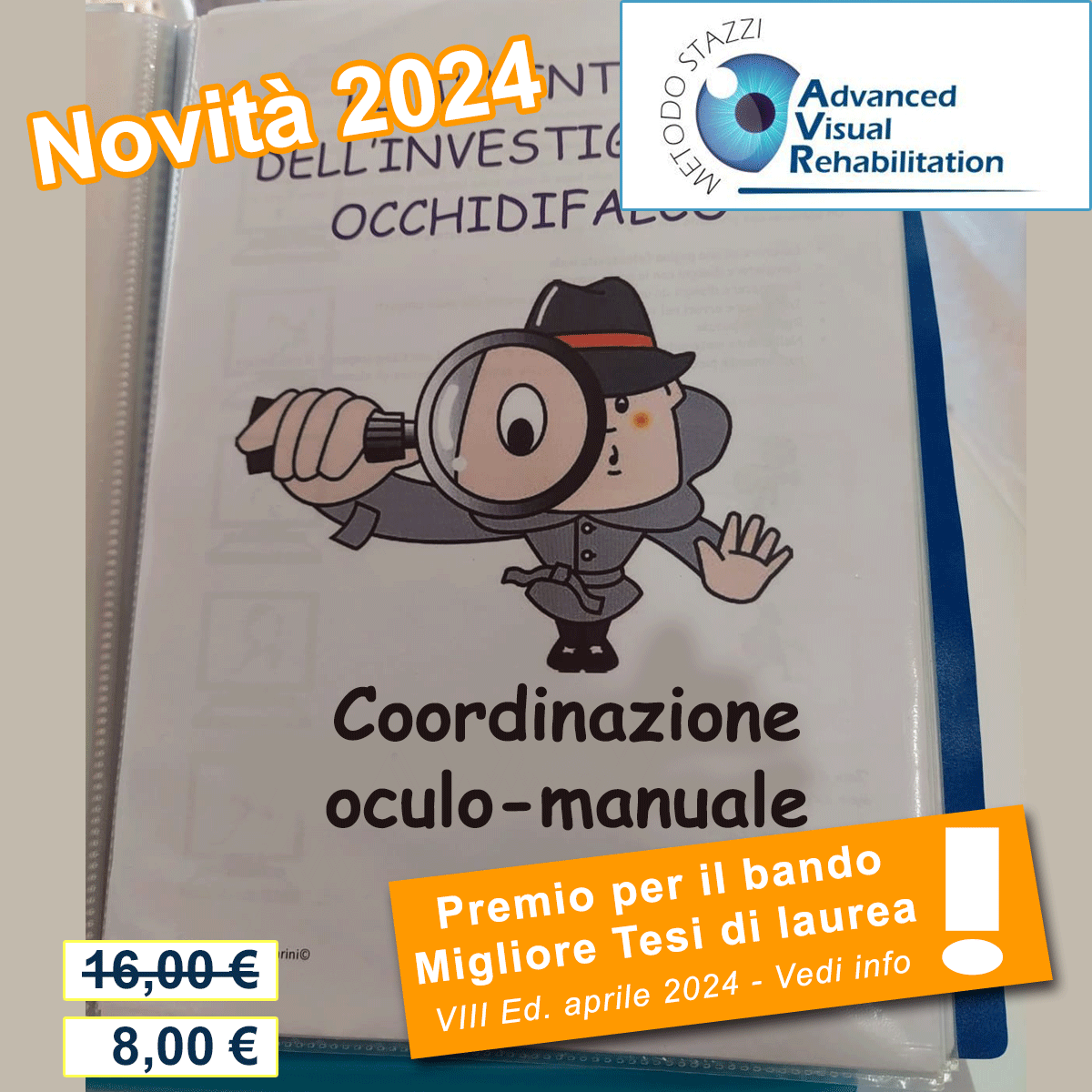La sensorialità come canale di relazione con il mondo: proposta di una scheda di osservazione del profilo sensoriale del bambino con Sindrome di Angelman

- 1.1 Le vie sensoriali
- 1.2 Modelli di integrazione sensoriale
- 1.3 Disturbo della processazione sensoriale (SPD) 18
CAPITOLO 2: L’IMPORTANZA DEGLI ASPETTI SENSORIALI NELLO SVILUPPO NEUROPSICOMOTORIO
CAPITOLO 3: LA SINDROME DI ANGELMAN
- 3.1 introduzione e storia della sindrome
- 3.2 Genotipo e meccanismi genetici
- 3.3 Diagnosi e diagnosi differenziale
- 3.4 Caratteristiche cliniche del fenotipo
- 3.5 Disturbi associati
- 3.6 Il profilo sensoriale. 36
CAPITOLO 4: IL RUOLO DEL TERAPISTA NELLA FASE DI VALUTAZIONE
- 4.1 Il ruolo del terapista della neuro e psicomotricità: il modello bio-psico-sociale
- 4.2 L’importanza del setting
- 4.3 La capacità di osservare. 42
CAPITOLO 5: MATERIALI E METODI
- 5.1 La necessità di una scheda di osservazione
- 5.2 La scheda di osservazione del profilo sensoriale nella sindrome di Angelman
- 5.3 Scopo della scheda
- 5.4 La struttura della scheda
- 5.5 Modalità di realizzazione della scheda
- 5.6 Modalità di somministrazione della scheda
CAPITOLO 7: DISCUSSIONE DEI RISULTATI
SOMMARIO
Introduzione. Lo sviluppo sensoriale è di fondamentale importanza per le prime esperienze del bambino con la realtà che lo circonda e influisce e partecipa al progresso delle tappe neuropsicomotorie in tutte le sue aree. La Sindrome di Angelman presenta un ritardo globale in tutte le aree di sviluppo e una modalità di relazione con il mondo ipoevoluta. Il profilo sensoriale dei bambini con Sindrome di Angelman è caratterizzato da aspetti peculiari e risulta di particolare interesse il suo approfondimento e studio.
Obiettivo. Questa tesi si pone come obiettivo la definizione di un protocollo di osservazione del profilo sensoriale del bambino con Sindrome di Angelman in età prescolare, al fine di validare l’osservazione qualitativa del terapista nelle sedute di osservazione e valutazione e di indagare i diversi canali sensoriali del bambino, per poter individuare quali promuovano maggiori risposte adattive da parte del bambino stesso. Tali risposte adattive permettono di essere canale di relazione tra il bambino e la realtà che lo circonda e dunque di promuovere lo sviluppo neuropsicomotorio dello stesso.
Materiali e metodi. È stata condotta una revisione della letteratura scientifica con l’obiettivo di indentificare gli strumenti osservativi già esistenti sull’argomento. Successivamente, è stata sviluppata una scheda di osservazione, che potesse rispondere alla necessità di un protocollo di osservazione che indagasse il profilo sensoriale di bambini con Sindrome di Angelman in età prescolare all’interno della seduta neuropsicomotoria. La scheda ha previsto la somministrazione di alcuni materiali adattati sensorialmente per riconoscere i canali sensoriali maggiormente coinvolti nella promozione di risposte adattive, in modo tale da poter guidare l’individuazione di obiettivi e strategie funzionali per il trattamento diretto e indiretto.
Discussione. È stato possibile, attraverso la scheda, individuare un comune profilo sensoriale e un’omogeneità nelle risposte adattive dei bambini in età prescolare con Sindrome di Angelman. Questo ha permesso di evidenziare le modalità e le strategie più adeguate per poter promuovere lo sviluppo neuropsicomotorio in tutte le sue aree. I dati raccolti hanno permesso quindi di poter strutturare un trattamento riabilitativo personalizzato per ciascun bambino e di poter individuare le migliori strategie di adattamento del setting, delle proposte e del materiale.
Conclusioni. Dal seguente lavoro emerge in modo significativo il bisogno di una scheda osservativa specifica sensoriale per il sostegno e la validazione dell’osservazione neuropsicomotoria all’interno delle sedute dedicate. Inoltre, sottolinea l’importanza degli aspetti sensoriali per il sostegno dello sviluppo neuropsicomotorio del bambino e la necessità di dover indagare, in modo più approfondito, le caratteristiche sensoriali peculiari della sindrome di Angelman al fine di poter individuare ulteriori strategie e proposte riabilitative funzionali per il bambino e la sua famiglia.
ABSTRACT
Introduction. Sensory development is of fundamental importance to a child's early experiences with the reality around him and influences and participates in the progress of neuropsychomotor milestones in all areas. Angelman syndrome presents a global delay in all areas of development and a hypoevolved way of relating to the world. The sensory profile of children with Angelman syndrome is characterised by peculiar aspects and is of particular interest to be studied in depth.
Objective. The aim of this thesis is to define a protocol for observing the sensory profile of a child with Angelman syndrome at pre-school age, in order to validate the therapist's qualitative observation during observation and assessment sessions and to investigate the child's different sensory channels, in order to identify which ones promote greater adaptive responses on the part of the child. These adaptive responses allow the child to be a channel for relating to the surrounding reality and thus promote neuropsychomotor development.
Materials and methods. A review of the scientific literature was conducted with the aim of identifying existing observational tools on the subject. Subsequently, an observation form was developed, which could meet the need for an observation protocol to investigate the sensory profile of pre-school children with Angelman syndrome within the neuropsychomotor session. The card included the administration of some sensory adapted materials to recognise the sensory channels most involved in the promotion of adaptive responses, so as to be able to guide the identification of goals and functional strategies for direct and indirect treatment.
Discussion. It was possible, through the card, to identify a common sensory profile and homogeneity in the adaptive responses of pre-school children with Angelman syndrome. This made it possible to highlight the most appropriate methods and strategies for promoting neuropsychomotor development in all its areas. The data collected thus made it possible to structure a personalised rehabilitation treatment for each child and to identify the best strategies for adapting the setting, proposals and material.
Conclusions. The following work significantly highlights the need for a specific sensory observation form for the support and validation of neuropsychomotor observation within the dedicated sessions. Furthermore, it emphasises the importance of sensory aspects in supporting the child's neuropsychomotor development and the need to investigate, in greater depth, the sensory characteristics peculiar to Angelman syndrome in order to be able to identify further functional rehabilitation strategies and proposals for the child and his family.
INTRODUZIONE
Fin dall’epoca fetale l’interazione con l’ambiente è mediata dai sensi, attraverso i quali il soggetto è capace di recepire, elaborare e integrare informazioni provenienti dall’esterno con il fine di poter processare una risposta adattiva funzionale alla situazione che si presenta. L’organismo umano riesce, attraverso gli organi di senso e il sistema nervoso centrale, dunque, a interagire con il mondo, fin dai primissimi mesi di vita. Lo sviluppo sensoriale risulta determinante per lo sviluppo neuropsicomotorio del bambino e base fondante per numerose risposte adattive e funzionali, che permettono al soggetto di conoscere e interagire con sé stesso, gli altri e il mondo. Conoscere, quindi, il profilo sensoriale del singolo bambino risulta importante per il terapista della neuro e psicomotricità, in quanto può diventare strumento utile per il raggiungimento di determinate risposte adattive e tappe funzionali dello sviluppo.
La Sindrome di Angelman è una patologia genetica rara che colpisce lo sviluppo psicomotorio, determinando deficit a livello globale. Presenta diverse peculiarità e caratteristiche funzionali specifiche per la sindrome. Tuttavia, risulta poco indagato lo sviluppo e il profilo sensoriale di questi bambini, pur presentando fascinazioni caratteristiche e comportamenti distintivi.
Lo scopo di questo progetto di tesi è dunque quello di indagare e approfondire il profilo sensoriale in bambini con la Sindrome di Angelman per poter individuare strategie possibili e efficaci per il miglioramento del funzionamento neuropsicomotorio di ciascun bambino. Il lavoro è stato possibile attraverso la costruzione di un protocollo osservativo che esaminasse i diversi canali sensoriali tramite la proposta di particolari target e materiali adattati sensorialmente, in modo da poter individuare quali caratteristiche sensoriali permettono un ampliamento delle risposte adattive.
Lo strumento osservativo è stato applicato, presso la struttura “IRCCS Eugenio Medea”, della Nostra Famiglia di Conegliano, a cinque bambini affetti da Sindrome di Angelman in età prescolare. Il progetto ha inoltre perseguito come obiettivo la valorizzazione del ruolo dei caregiver all’interno dei processi di sviluppo del bambino e l’importanza della condivisione di possibili strategie e modalità di interazione, al fine di permettere al genitore di conoscere ulteriormente il funzionamento del proprio bambino.
CAPITOLO 1: IL MODELLO SENSORIALE E LA CAPACITA’ DELL’ORGANISMO DI RICEVERE E ELABORARE INPUT SENSORIALI
Ogni essere umano vive inserito in un contesto ambientale, stimolante a livello sensoriale, dove può captare e quindi elaborare gli stimoli e gli input che da quest’ultimo riesce a ricevere, in questo modo può dunque conoscere e riconoscere il complesso sistema che lo circonda, creandosi così un’immagine della realtà. Quest’immagine, tuttavia, non è mai del tutto oggettiva ma sempre parziale, in quanto l’essere umano non è capace di riconoscere e captare tutti gli stimoli che la realtà gli offre. Infatti l’organismo, e più in particolare gli organi recettori, riescono a percepire solamente determinati stimoli, caratterizzati da intervalli di intensità, durata e qualità definiti e caratteristici. Possiamo quindi differenziare la realtà come: realtà fisica, ovvero accessibile attraverso strumenti di misurazione fisica, chimica, astrofisica ecc., e realtà fenomenica, ovvero la realtà percepita dagli organi di senso, che permette dunque di essere elaborata e conosciuta anche dalla mente umana e concorre all’immagine che ogni individuo si crea per interagire con l’ambiente circostante (Murgia, n.d.).
Nel mondo, siamo costantemente circondati e bombardati da stimoli differenti. Sono stimoli sensoriali, ovvero che attivano il nostro sistema sensoriale, grazie al quale siamo in grado di poterli convertire, elaborare e dunque tradurre in informazioni utili per il nostro organismo e che a loro volta generano una risposta verso il mondo esterno. Il processo di traduzione sensoriale, infatti, permette di trasformare una sensazione in una percezione (Ruotolo, 2021).
Dal dizionario Treccani, si può definire “Sensazione” come “Ogni stato di coscienza in quanto sia avvertito come prodotto da uno stimolo esterno o interno al soggetto”, mentre come “Percezione”, una “Presa di coscienza da parte del soggetto di una realtà esterna o interna.” Infatti, il passaggio da sensazione a percezione è modulato da un’elaborazione sensoriale, a carico del sistema nervoso centrale, la percezione, quindi, non è altro che il riconoscimento e l’attribuzione di significato della sensazione stessa, che invece è la mera rilevazione di uno stimolo sensoriale. Dunque, tutte le informazioni che riceviamo dal mondo, vengono lette e elaborate attraverso un meccanismo di: input à elaborazione à output, definendo così il processo sensoriale come la modalità con cui il sistema nervoso riceve, processa e risponde agli input sensoriali. (Russo, 2021)
La percezione è, quindi, molto più ricca rispetto alla sensazione stessa, perché arricchita da un valore aggiunto, quello derivante dai processi cerebrali che integrano la rilevazione del dato sensoriale alle conoscenze già acquisite, in modo da permettere di conoscere e riconoscere il mondo che ci circonda (Murgia, n.d.).
La realtà esterna viene, in questo modo, colta e conosciuta solo per le parti di essa che vengono captate dai recettori di senso, che si organizzano a loro volta in organi di senso. Gli organi di senso sono, dunque, i canali principi che permettono la relazione e la comunicazione con il mondo esterno. Il processo, infatti, per arrivare a una percezione nasce a livello delle cellule recettrici, ovvero cellule sensibili a un determinato tipo di stimolo, che analizzano e scompongono le informazioni sensoriali. Quest’ultime poi vengono rielaborate, a livello del SNC, e esaminate per rilevamento delle caratteristiche degli stimoli e per il tipo di scarica. Infine, le regioni centrali del SN interagendo e collaborando tra loro ricostruiscono i diversi aspetti percettivi unificandoli in un’unica percezione cosciente (Murgia, n.d.).
1.1 Le vie sensoriali
Anatomicamente, un recettore sensitivo è una cellula specializzata capace di controllare le condizioni presenti internamente e esternamente al corpo, inoltre, se stimolato è in grado di modificare la produzione di potenziali d’azione in un neurone sensitivo (Martini et al., 2019).
Le sensazioni possono essere classificate a seconda che la sensibilità sia generale o specifica. Infatti, si può parlare di sensibilità generale quando i recettori sono sparsi in tutto il corpo, senza avere un collocamento specifico, con punto d’arrivo la corteccia sensitiva primaria. Questo è il caso di sensazioni quali temperatura, dolore, tatto, pressione, vibrazione e propriocezione. Mentre, d’altra parte, la sensibilità specifica è raccolta da recettori specifici posizionati all’interno di complessi organi di senso che terminano in centri distinti dell’encefalo. In questo caso, dunque, facciamo riferimento a sensibilità quali olfatto, gusto, vista, udito e equilibrio (Martini et al., 2019).
Verranno, ora, analizzate le vie sensoriali rispettivamente del tatto, dell’udito e della vista, descrivendone la struttura anatomica e il percorso che l’input sensoriale, trasformato in potenziale d’azione, compie per raggiungere il SNC per essere elaborato.
La sensibilità tattile rientra a far parte della sensibilità generale e dunque i recettori riservati a questi input sono ben distribuiti, in tutta la superficie del corpo umano. I recettori della sensibilità generale sono strutturalmente abbastanza semplici, pur essendo però molto diversi tra loro per captare sfumature diverse dello stimolo, infatti possono essere classificati come: nocicettori, termocettori e meccanocettori. I nocicettori sono i responsabili della sensazione del dolore, i termocettori delle variazioni di temperatura e i meccanocettori vengono stimolati o inibiti per contatto o pressione, tra questi possiamo estrapolare i recettori tattili, che registrano esclusivamente stimoli pressori e vibratori provenienti dalla superficie corporea e possono essere suddivisi a loro volta in recettori per la sensibilità discriminata e non discriminata. Quelli adibiti alla sensibilità discriminata forniscono informazioni dettagliate per origine, localizzazione, forma, dimensioni e spostamento dello stimolo, dunque rientrano nella sensibilità fine del tatto, mentre la sensibilità non discriminata prevede una localizzazione non specifica a altre poche informazioni, rientrando nella parte grossolana. La propagazione della sensibilità tattile avviene attraverso 2 vie: la via spinotalamica e la via del cordone posteriore. La prima trasporta il messaggio di sensibilità tattile grossolana, pressoria, termica e nocicettiva e è una via a tre neuroni, infatti gli assoni dei neuroni sensoriali di primo ordine trasportano l’input sensoriale attraverso il midollo spinale, dove, nelle corna posterolaterali, fanno sinapsi con i neuroni di secondo ordine e ascendono come fasci spinotalamici anteriori e laterali, raggiungendo il talamo, dove, facendo sinapsi con i neuroni di terzo ordine, arrivano alla corteccia sensitiva primaria. La seconda via, invece, ovvero quella del cordone posteriore, trasporta la sensibilità tattile fine, pressoria e propriocettiva cosciente. Gli assoni sono raggruppati all’interno dei fascicoli gracile e cutaneo, dove rispettivamente avviene una sinapsi all’interno dei nuclei omonimi del midollo allungato, successivamente ascendono verso il talamo, dove, precisamente nel lemnisco mediale, avviene una seconda sinapsi e una decussazione, infine l’informazione viene portata alla corteccia sensitiva primaria, dove avviene la processazione dell’informazione attraverso uno schema che segue l’ “Homunculus sensoriale” e che permette di elaborare e individuare le caratteristiche principali dell’input sensoriale (Martini et al., 2019).
La sensorialità uditiva rientra all’interno della classe di sensorialità specifica, infatti i suoi recettori si collocano all’interno dell’organo sensoriale adibito, ovvero l’orecchio, che è dimora anche della sensorialità vestibolare. Il suono è composto da onde sonore, ovvero pressorie, che si possono propagare attraverso l’aria o l’acqua. Le onde, quindi, vengono incanalate attraverso il condotto uditivo esterno e arrivano alla membrana timpanica mettendola in vibrazione. Questa vibrazione, che ha una frequenza tra i 20 e i 20000 Hz, permette l’attivazione della finestra ovale, grazie alla propagazione amplificata attraverso gli ossicini dell’udito. I movimenti, infatti, di questi ossicini permettono la generazione di onde pressorie nella perilinfa, che essendo un liquido, portano a una distorsione delle pareti del condotto cocleare e dell’organo del Corti, sede principale dei recettori sensoriali per l’udito. La correlazione tra la forza applicata alla finestra ovale e il grado di stimolazione recettoriale permette di rilevare l’intensità dei suoni, ovvero la variazione di volume, mentre la frequenza è determinata dall’area stimolata dall’impulso. L’attivazione dei recettori, tuttavia, permette il rilascio dei neurotrasmettitori e quindi l’avvio del segnale nervoso attraverso la via uditiva. Quest’ultima è denominata a quattro neuroni, in quanto il segnale attraversa il ramo cocleare del nervo vestibolococleare, ovvero il VIII nervo cranico, poi, entrando attraverso il midollo allungato, fa sinapsi nei nuclei cocleari omolaterali, qui i neuroni di secondo ordine originano assoni che si dirigono sia ai collicoli inferiori del mesencefalo, sede dei neuroni di terzo ordine che permettono le risposte riflesse motorie ai suoni, che ai nuclei olivari superiori. Successivamente l’input sensoriale ascendente si dirige al nucleo genicolato mediale, sede dei neuroni di quarto ordine, e infine si proietta verso la corteccia uditiva nel lobo temporale, dove è presente una rappresentazione dell’organo del Corti. Se avviene un danno alla corteccia, l’individuo è capace, quindi, di reagire in modo riflesso agli stimoli ma non di interpretarli e di riconoscerli (Martini et al., 2019).
Infine, anche la sensorialità visiva è una sensorialità specifica e infatti i recettori sensoriali adibiti a questo compito sono posizionati all’interno dell’occhio, più precisamente nella parte retinica. Infatti, nella retina si collocano i fotorecettori, ovvero le cellule specializzate per la ricezione dello stimolo visivo, quest’ultimi si possono classificare a seconda delle loro caratteristiche in: coni e bastoncelli. I coni sono recettori che permettono la discriminazione dei colori e la produzione di immagini più nitide, richiedendo tuttavia una maggior quantità di luce; i bastoncelli, invece, sono cellule molto sensibili alla luce e permettono la visione negli ambienti poco illuminati. La loro distribuzione nella retina non è uniforme: i bastoncelli si collocano principalmente nella parte periferica della retina, mentre i coni nella parte centrale. I fotorecettori fanno sinapsi con i neuroni bipolari, che a loro volta, contraggono sinapsi con i neuroni multipolari. Gli assoni dei neuroni multipolari convergono nel disco ottico e vanno a formare il nervo ottico, ovvero il secondo nervo cranico. I due nervi ottici, dei due diversi occhi, raggiungono il diencefalo e a livello del chiasma ottico hanno una parziale decussazione: infatti, le informazioni visive provenienti dalle metà di sinistra di entrambe le retine arrivano al corpo genicolato laterale di sinistra, mentre le informazioni della metà di destra al corpo genicolato laterale di destra. Questi centri genicolati sono collegati sia al tronco encefalico per funzioni di riflesso che con la corteccia cerebrale per la funzione di percezione visiva. Infine, le informazioni leggermente discordanti dei due occhi giungono alla corteccia cerebrale e qui vengono, tramite il processo di integrazione corticale, unificate in un’immagine unitaria. Questo è solo un primo esempio di integrazione corticale, e di come il SNC elabora l’input sensoriale in percezione (Martini et al., 2019).
1.2 Modelli di integrazione sensoriale
Come già ampiamente descritto anatomicamente, il processo sensoriale interessa la modalità con cui il SN gestisce le informazioni sensoriali, attraverso i passaggi di discriminazione, interpretazione e organizzazione sensoriale. Questo iter definisce il processo di integrazione sensoriale che permette, a sua volta, la produzione di una risposta adattiva all’ambiente, che può essere di tipo corporeo, percettivo, emotivo e intellettivo (Schaaf & Davies, 2010).
Tra i maggiori esponenti dei processi sull’integrazione sensoriale, è necessario nominare Anna Jean Ayres, neuropsicologa e terapista occupazionale del ‘900, che ha passato l’intera sua carriera a studiare e approfondire strategie d’intervento per bambini con problemi comportamentali e di apprendimento. Basandosi in modo importante sulla letteratura delle neuroscienze, la studiosa ha indirizzato il suo interesse principalmente sui deficit sensoriali e motori che influenzano l’apprendimento e il comportamento, teorizzando, in questo modo, lei stessa il modello dell’integrazione sensoriale, che oggi è riconosciuto come “Ayres Sensory Integration® (ASI)” e analizza sia la teoria che l’aspetto clinico e di intervento sui meccanismi sensoriali. (Lane et al., 2019).
Secondo A. J. Ayres, le fondamenta su cui si basa la teoria dell’integrazione sensoriale sono rette da cinque cardini teorici dello sviluppo umano, ovvero: la risposta adattiva, la plasticità neuronale, lo sviluppo senso-motorio, l’organizzazione del sistema nervoso centrale e la predisposizione all’azione (inner-driver) (Gomes Fuchs, 2017). La risposta adattiva è una reazione ad un input sensoriale finalizzata ad uno scopo. È il risultato, quindi, di una concatenazione di feedback interni ed esterni, che influenzano a loro volta la pianificazione e l’esecuzione di nuovi movimenti, diventando in questo modo, dunque, la base dell’apprendimento in quanto genera lo sviluppo di nuovi modelli neuronali (Pfeiffer et al. 2011). La plasticità neuronale, invece, è alla base del funzionamento del sistema nervoso centrale, infatti influenza il suo cambiamento morfologico in risposta a informazioni e richieste sensoriali biologicamente significativi (Abelenda & Rodriguez, 2020) e su questa base Ayres ha dimostrato l’influenza e l’importanza dell’intervento terapeutico per intervenire in modo significativo sul funzionamento del SNC. È stato, inoltre, studiato che il processo di integrazione sensoriale influisce sullo sviluppo senso-motorio, argomento che verrà approfondito in modo più dettagliato nel capitolo secondo. Allo stesso modo, secondo A. J. Ayres le esperienze senso-motorie influenzano le funzioni corticali superiori responsabili dell’astrazione, della percezione, del linguaggio e del ragionamento, secondo un modello di organizzazione del SNC (Gomes Fuchs, 2017). Infine, sempre secondo la studiosa, ognuno ha una predisposizione naturale all’azione, ovvero a ricercare e partecipare in modo attivo alle attività sensoriali per poter interagire con il mondo che lo circonda, attuando in questo modo il modello di integrazione sensoriale (Roley et al., 2007).
Oltre alle fondamenta teoriche su cui si basa la teoria, l’approccio dell’integrazione sensoriale di Ayres segue una serie di principi che possono aiutare e guidare il terapista nella pratica clinica e nel ragionamento clinico, che è richiesto a quest’ultimo nel concreto. I principali sono: “Active Sensory–Motor Experience”, “the Just Right Challenge”, “the Adaptive Response” e “the Child-Direction.”
L’approccio terapeutico, infatti, vuole essere il più possibile stimolante e attraente per il bambino, senza porsi con un atteggiamento di insegnamento o superiorità. In questo modo, dunque, è bene proporre “Active Sensory–Motor Experience”, ovvero attività e esperienze senso-motorie attive, dove il bambino stesso in prima persona possa sentirsi protagonista dell’esperienza stessa, in modo da essere più stimolato e maggiormente coinvolto. Inoltre, è importante per il terapista saper proporre “the Just Right Challenge”, ovvero la giusta sfida, infatti il terapista deve essere capace di proporre attività accattivanti e accessibili al bambino, con però piccole componenti che possano essere sfidanti per quest’ultimo, rifacendosi al modello conosciuto di Scaffolding. In questo modo, infatti, si andrà a stimolare nel bambino “the Adaptive Response”, ovvero la risposta adattiva che si basa su nuove strategie utili per il suo sviluppo e apprendimento. Infine, è fondamentale per il terapista poter seguire “the Child-Direction”, ovvero la direzione che prende il bambino. Un buon terapista infatti riesce a leggere i segnali e i comportamenti del bambino e a indirizzarli verso il percorso designato e pensato, tuttavia considerando sempre i tempi e le modalità del bambino stesso (Schaaf & Miller, 2005).
Ayres, per tutto il tempo dedicato alla sua ricerca, è stata guidata principalmente da due principi fondamentali delle neuroscienze, ovvero: “il cervello è un sistema auto-organizzante” e “l’integrazione intersensoriale è fondamentale per farlo funzionare”, anticipando in questo modo lo studio dell’integrazione multisensoriale (Lane et al., 2019).
Infatti la percezione che il nostro organismo elabora è unitaria e coerente, anche se proveniente da diversi canali sensoriali. Anche se inizialmente, può sembrare scontato pensare che le informazioni vengano elaborate singolarmente, in quanto raccolte e inviate in modo autonomo da differenti organi di senso, nella realtà le informazioni ricevute poi vengono integrate tra loro attraverso un modello di integrazione multisensoriale dal nostro sistema nervoso. In questo modo, si realizza la possibilità di generare una risposta all’ambiente che sia il più possibile congruente in tutti i suoi aspetti e unitaria in tutte le sue caratteristiche. Dunque, compito del sistema nervoso è quello di unificare e convogliare tutte le differenti rappresentazioni sensoriali in un’unica prospettiva della realtà, in modo da consentire, attraverso questo processo, la continua ricezione di stimoli esterni momento per momento e la loro programmazione in risposte di output, permettendo in questo modo l’adattamento funzionale all’ambiente circostante e quindi, in termini evolutivi, la sopravvivenza dell’individuo. (Poma, 2016).
Seguendo le orme di Ayres, altri furono gli autori che approfondirono il processo sensoriale, tra cui è doveroso citare L. Miller e W. Dunn, due studiosi che basandosi sulle teorie di Ayres portarono avanti la ricerca scientifica in questo ambito. Entrambi portarono, però, a loro volta il loro contributo, facendo evolvere la teoria iniziale di Ayres (Camarata et al., 2020). Miller, in particolare, tra i tanti contributi cercò di chiarire e semplificare la terminologia usata in ambito clinico e di ricerca nell’area delle neuroscienze, infatti in entrambi i campi è comune usare il termine coniato da Ayres: “Integrazione sensoriale”. Tuttavia, in ambito clinico, il termine fa riferimento a un determinato modello di disfunzione, correlato a una specifica teoria, valutazione e metodo di trattamento per bambini che hanno risposte atipiche a normali stimolazioni sensoriali. In ambito delle neuroscienze, invece, il termine fa riferimento alla convergenza di informazioni nel sistema nervoso centrale da uno o più domini sensoriali. Oggi in entrambi i campi le situazioni si sono evolute: infatti in ambito clinico ora si parla di “Disturbo della processazione sensoriale”, quando si vuole parlare di bambini con difficoltà sul piano sensoriale, mentre nell’area delle neuroscienze, ha iniziato a prendere piede l’idea di integrazione multisensoriale. È importante, sia per i clinici che per gli studiosi, avere quindi chiara la terminologia corretta da usare, per evitare disguidi e essere precisi nelle ricerche e nelle comunicazioni tra colleghi e con i genitori (Miller et al., 2009).
Altra autrice che ha contribuito con i suoi studi è W. Dunn, terapista occupazionale e influente studiosa all’interno delle neuroscienze nell’ambito sensoriale, attraverso lo studio della processazione sensoriale nella vita quotidiana (Giunti Psychometrics, n.d. (a)). Infatti, Dunn teorizza uno dei modelli di elaborazione sensoriale maggiormente riconosciuti nel secolo, ovvero il “Four Quadrant Model of Sensory Processing”. Il modello è basato sulla teoria di due costrutti fondamentali: il funzionamento delle soglie neurologiche e la capacità di risposta comportamentale adattiva (Metz et al., 2019). Il primo costrutto si fonda, infatti, sul concetto di soglia per la risposta a uno stimolo sensoriale. La soglia è il valore limite per cui gli stimoli sensoriali riescono ad essere colti dall’organismo, al di sotto di questo valore lo stimolo può essere presente ma non percepibile dall’individuo. (Lanciano, 2022). Se pur le soglie sono generalmente assolute e comuni a tutti gli esseri umani, ogni singolo presenta una gamma personale di soglie per cui risponde ai diversi input sensoriali. In questo modo, individui con soglie basse possono cogliere e reagire agli stimoli in modo più rapido in quanto i loro sistemi sono più facilmente attivabili. Allo stesso modo, d’altra parte, persone con soglie molto alte fanno più fatica a cogliere gli input sensoriali e dunque possono perdere gli stimoli o ritardare le risposte adattive. Il secondo costrutto, invece, fa riferimento alla risposta adattiva. Infatti, come già descritto precedentemente, ogni individuo processa l’informazione e produce una risposta comportamentale adattiva allo stimolo sensoriale, che varia ampiamente da individuo a individuo pur rimanendo all’interno di un continuum con estremi: strategie passive e strategie attive. Le strategie passive prevedono un comportamento con tendenze di risposte interne lasciando che le cose accadono intorno al soggetto, mentre d’altra parte le strategie di autoregolazione attiva prevedono la tendenza a controllare l’importo di input a disposizione e quindi agire per modificarlo in base al proprio benessere (Metz et al., 2019).
Dunque, sia il concetto di soglia che quello di risposta adattiva si fondano su dei continuum che prevedono degli estremi. L’intersezione dei due continuum fa emergere, secondo Dunn, la formazione di 4 modelli base di elaborazione sensoriale (Dunn, 2007), come è mostrato in Figura1. Ogni modello è unico e rappresenta un estremo delle soglie.
Figura 1: Four Quadrant Model of Sensory Processing di W. Dunn (Giunti Psychometrics, n.d. (b))
I 4 modelli, dunque, sono:
- Spettatore, o registrazione bassa, che prevede una soglia elevata e una strategia di autoregolazione passiva
- Attivo, o ricerca di sensazione, che rappresenta soglie elevate e una strategia di autoregolazione attiva
- Evitante, che include soglie basse e un livello di autoregolazione passivo
- Sensoriale, che prevede una soglia bassa e un livello di autoregolazione attivo (Metz et al., 2019)
1.3 Disturbo della processazione sensoriale (SPD)
Il processo sensoriale non sempre, tuttavia, funziona e agisce come dovrebbe. Infatti, in alcuni soggetti il sistema nervoso centrale non interpreta in modo efficace i messaggi sensoriali che derivano dal proprio corpo, andando in questo modo a influenzare tutte le risposte sensoriali che si potrebbero elaborare. Questa situazione è descritta dal termine di disturbo della processazione sensoriale (SPD). I bambini, infatti, soggetti a questo disturbo non presentano difficoltà nel ricevere gli input sensoriali, quindi potrebbero avere una vista o un udito perfetto e non compromesso, ma la componente che si discosta è nella fase di elaborazione nel SNC, dove appunto quest’ultimo processa le informazioni semplicemente in modo differente rispetto ai pari, quindi una medesima situazione può causare in questi bambini risposte adattive differenti e dunque comportamenti spesso inusuali o non attesi. (Griffin Occupational Therapy, 2020).
Fu Miller la prima a parlare di “Disturbo della processazione sensoriale”, individuandone 3 principali componenti (Griffin Occupational Therapy, 2020), come viene illustrato nella Figura 2.
Figura 2: classificazione del Disturbo di elaborazione sensoriale secondo Miller (Krishnan & Travnik A., n.d.)
La prima componente si basa sulla modulazione sensoriale, quindi la capacità di produrre una risposta o un comportamento adattivo che corrisponda alla natura e all’intensità dell’input sensoriale dell’ambiente. Questo, spesso, non avviene in soggetti con SPD, infatti quest’ultimi tendono a dare risposte che non corrispondono al messaggio di input e questo può interessare solamente alcuni sensi o tutti. Inoltre, a seconda delle modalità di risposta e, quindi, capacità di modulazione, a sua volta questa categoria di problematiche può includere: iper-reattività, ipo-reattività o ricerca sensoriale (Griffin Occupational Therapy, 2020).
Il pattern di iperattività sensoriale, noto anche come evitamento sensoriale, è caratterizzato da risposte intense e negative alle esperienze di vita quotidiane, portando a comportamenti come evitamento, ansia e difesa. Questo va a influire in modo importante sulla vigilanza e l’attenzione, ma anche sull’interazione sociale e sul livello di cura di sé (Miller et al., 2007). Il pattern, invece, di iporeattività sensoriale, è conosciuto anche come a bassa registrazione, in quanto è caratterizzato da risposte adattive ridotte, in ritardo o assenti, rispetto agli input sensoriali andando a influire sul livello di prontezza, attenzione, coordinazione motoria, movimento e interazione sociale (Jorquera-Cabrera et al., 2017). Infine, i bambini con pattern di “sensory seeking”, ovvero di ricerca sensoriale, sono caratterizzati da un insaziabile bisogno sensoriale, infatti sono alla continua ricerca di input sensoriali. Dimostrano forti preferenze sensoriali e solitamente mettono in atto comportamenti socialmente inappropriati, in quanto spesso questo quadro è associato a poca consapevolezza del pericolo e delle proprie abilità, associato a un ridotto controllo inibitorio e uno stato comportamentale disorganizzato e immaturo (Miller et al., 2007).
La seconda componente del SPD è la discriminazione, ovvero la capacità di riconoscere qual è stato l’input sensoriale, dove è successo e quanto è stato intenso (Griffin Occupational Therapy, 2020). In questo caso, se questa componente è compromessa, allora il soggetto non sarà in grado di discriminare gli input sensoriali, come ad esempio non saprà riconoscere la differenza tra cibo dolce o salato, o di filtrare e riconoscere il proprio nome in un ambiente rumoroso (Krishnan & Travnik A., n.d.).
Infine, l’ultima componente del disturbo di processamento sensoriale è il movimento, che a sua volta si suddivide in posture e prassie. La postura si riferisce al controllo posturale, all’equilibrio e alla stabilità, mentre la prassia, alla capacità di pianificazione e organizzazione di nuovi movimenti, fondamentale per l’apprendimento di nuove abilità (Griffin Occupational Therapy, 2020). Il disturbo sensoriale può esprimersi anche attraverso una difficoltà di adattamento posturale all’ambiente o una forte componente disprassica che può coinvolgere la motricità fine, grossolana o oro-buccale (Krishnan & Travnik A., n.d.).
Le componenti tra loro non si escludono a vicenda, ma possono anzi presentarsi contemporaneamente in modo molto variegato, considerando le stesse sensorialità o sensorialità differenti, rendendo il disturbo ancora più complicato e intrinseco a numerosi fattori.
Si stima, inoltre, che tra il 40 e l’80% dei bambini con difficoltà nel neurosviluppo presentino difficoltà anche nell’ambito sensoriale, mentre tra il 60 e il 95% nei soggetti con autismo, invece nella popolazione con sviluppo tipico tra il 2.8 e il 6.5% della popolazione presenta difficoltà sensoriali (Jorquera-Cabrera et al., 2017).
CAPITOLO 2: L’IMPORTANZA DEGLI ASPETTI SENSORIALI NELLO SVILUPPO NEUROPSICOMOTORIO
La prospettiva empiristica della percezione secondo Helmholtz considera il neonato come una tabula rasa, ovvero un foglio bianco dove vanno ad imprimersi i dati dell’esperienza. Infatti, solo le ripetute esperienze con l’ambiente e l’apprendimento che ne deriva porterebbero a maturare la vera percezione, affidando, dunque, la capacità di percepire al lungo e lento prodotto dell’apprendimento. Renè Spitz, nel 1958, definisce il neonato nei primi 3 mesi di vita, come immerso in una realtà indifferenziata, dove la sua unica capacità di risposta a un input esterno è in funzione di una pulsione di origine solamente spiacevole e insoddisfatta, a cui si poteva contrapporre unicamente uno stato di quiete (Camaioni & Di Blasio, 2007).
Tuttavia, negli ultimi decenni è cambiata l’immagine del neonato e del suo approccio al mondo, grazie a una maggiore attenzione al periodo dell’infanzia e alle ricerche sulle competenze percettive, cognitive ed emotive precoci. Infatti, l’idea del bambino è passata da mero e passivo recettore di stimoli a un individuo competente e attivo nell’elaborazione delle esperienze già dai primi momenti di vita. Infatti, il bambino nasce dotato di prerequisiti percettivi e cognitivi precoci che si sviluppano grazie all’interazione con l’ambiente, sostenendo dunque l’apprendimento. Gran parte della conoscenza iniziale del mondo è data proprio dalla percezione, dove l’attività percettiva precoce svolge un ruolo fondamentale nelle prime fasi di sviluppo, in quanto i sistemi percettivi sono attivi già in epoca prenatale e contribuiscono quindi in modo importante allo sviluppo neuropsicomotorio del bambino, diventando punto di partenza di un processo di progressiva comprensione dell’ambiente (Saviani, 2020).
Verranno analizzati di seguito le sensorialità del tatto, dell’udito e della vista e il loro contributo allo sviluppo neuropsicomotorio nel bambino.
2.1 La sensibilità tattile
La prima sensorialità ad emergere durante la vita intrauterina è quella tattile, intorno alle otto settimane gestazionali. Il feto è inserito in un ambiente che rimanda costantemente input tattili, infatti è continuamente in relazione con la placenta, il cordone ombelicale, il liquido amniotico e la superficie uterina che lo avvolgono in modo globale e con i quali sperimenta sensazioni tattili passive o attive. Il feto, dunque, esplora e tocca il proprio corpo, preferendo alcuni distretti rispetto ad altri quali il viso, le labbra, le mani e i piedi in quanto più sensibili e innervati (Marx & Nagy, 2017).
Alla nascita, il neonato presenta competenze tattili, dimostrando piacere o dispiacere nei confronti dei diversi target. Tuttavia, la capacità di discriminazione di localizzazione dello stimolo e di reagire con una risposta adeguata si affina con l’età. Infatti, pur presentando una distribuzione non uniforme dei numerosi recettori sensibili sulla superficie cutanea per riconoscere i diversi input, nei primi mesi la sensibilità tattile risulta molto generalizzata, sviluppando solo tra i sei e i nove mesi una capacità epicritica, rendendo in questo modo più precisa la localizzazione e la discriminazione tattile, abilità che si consolidano in modo più definito verso i dodici e i sedici mesi (Montagu, 2015).
Il tatto fornisce nello sviluppo neuropsicomotorio del bambino un’impalcatura sensoriale che permette il sostenimento dello sviluppo motorio, della conoscenza e esplorazione del mondo e degli oggetti, ma anche della percezione del proprio corpo. Inoltre, negli ultimi anni, al tatto si è dato un valore anche sociale, in quanto partecipa alla mediazione dei legami interpersonali. Infatti, le sensazioni tattili risultano pervasive nell’esperienze e nelle risposte di adattamento all’ambiente (Bremner & Spence, 2017).
Una delle influenze maggiori dello sviluppo tattile nella maturazione neuropsicomotoria è data dalla possibilità di esplorare e, dunque fare esperienza e conoscere, gli oggetti che circondano il bambino, attraverso la manipolazione fine. I polpastrelli, infatti, presentano numerosi recettori tattili, che permettono di riconoscere e codificare determinate caratteristiche dell’oggetto, andando a sostenere azioni manipolative finalizzate. Inoltre, l’esplorazione tattile del materiale non ha solo valenza motoria, ma permette lo sviluppo di aspetti cognitivi, quali il confronto, la categorizzazione e la strutturazione dell’ambiente circostante. Tuttavia, il tatto non riconosce solamente stimoli esterni, ma riceve percezioni anche di carattere interocettivo. Infatti, sono presenti recettori anche all’interno dell’organismo che permettono quindi l’elaborazione della posizione e del movimento del corpo nello spazio. Questa abilità viene definita propriocezione e si dimostra fondamentale per il riconoscimento del sé corporeo, la distinzione con l’altro, l’attenzione e la vigilanza, lo schema corporeo, il tono muscolare, la modulazione e il movimento stesso (Bremner & Spence, 2017).
Il canale tattile, inoltre, gioca un ruolo importante nello sviluppo emotivo-relazionale del bambino, infatti, soprattutto nei primi mesi, il tatto è uno dei canali preferenziali per l’interazione e la creazione di una buona relazione tra lattante e caregiver, che poi getterà le basi dello sviluppo sociale del bambino stesso. Il tocco diventa portatore carico di significati emotivi, relazionali e comunicativi, sostituendosi, in modo importante, soprattutto nel primo periodo di vita al linguaggio vero e proprio. Attraverso il tatto, dunque, il soggetto può promuovere e scoprire la relazione non solo con il mondo e con sé stesso, ma anche con l’altro (Cascio et al., 2018).
2.2 La sensibilità uditiva
Sebbene non sia ancora completamente maturo, il sistema uditivo consente la risposta al suono anche in epoca intrauterina. Infatti, si stima che il feto inizi a dare risposte comportamentali agli input sonori già dalla 28esima settimana gestazionale (Birnholz & Benacerraf, 1983). Tuttavia, lo sviluppo del sistema uditivo procede gradualmente sia durante la gestazione che, poi, nella vita extrauterina. Infatti, alla nascita, la conformazione anatomica dell’organo recettore, pur non mostrando sostanziali differenze, risulta di dimensioni minori rispetto a quelle dell’adulto che, non permettono ancora una trasmissione efficace delle vibrazioni sonore, per cui dimostrano una soglia uditiva più alta, portando il bambino a percepire gli stimoli sonori in modo più attutito rispetto all’adulto (Camaioni & Di Blasio, 2007). Alla nascita, i neonati presentano una soglia percettiva più alta di 25dB, con un miglioramento progressivo che già a 6 mesi porta a un’alterazione solamente di 10-15dB, fino a un raggiungimento del gap intorno ai 5 anni di età. Anche il rilevamento della frequenza del suono varia a seconda dello sviluppo, infatti quando il canale uditivo è maturo e completo il range di percezione è tra i 20 e i 20.000 Hz, tuttavia nel bambino la capacità di discriminazione della frequenza cambia. Infatti, a tre mesi il soggetto riesce a discriminare in modo migliore i toni con frequenza di 500 Hz rispetto a 4000 Hz, mentre risulta invertito a sei mesi, quando il bambino riesce a distinguere l’intensità e la durata del suono (Litovsky, 2015).
Nonostante, un’iniziale non completamento dello sviluppo uditivo, il neonato è capace di essere reattivo ai suoni, orientandosi attraverso il direzionamento degli occhi e della testa verso la fonte sonora, in modo particolare, se si tratta di suoni ritmici e voci umane. Inoltre, è possibile osservare una preferenza verso la voce materna, dimostrando un possibile apprendimento prenatale dato da un riconoscimento delle caratteristiche prosodiche della voce materna recepita in fase fetale, in quanto trasmessa internamente attraverso le ossa e i tessuti fino all’utero (Capobianco, 2014).
Il sistema uditivo ha un ruolo chiave nella comunicazione sociale, nell’integrazione e nella capacità di apprendimento. Inoltre, permette al soggetto di localizzare la sorgente sonora, permettendo in questo modo di dare, oltre a un significato motorio, anche uno cognitivo e soprattutto sociale. Infatti, questa abilità contribuisce alla costruzione di una mappa spaziale della realtà che circonda l’individuo e dunque permette l’orientamento nello spazio. Nei primi mesi il soggetto può reagire agli input sonori attraverso risposte incondizionate e di riflesso, tuttavia intorno ai sei mesi, il lattante è in grado di localizzare la fonte sonora sia sul piano orizzontale che verso il basso, mentre tra i 21-24 mesi in tutte le direzioni (Fuchs & Turker, 2015).
Il sistema uditivo permette l’accesso all’apprendimento del linguaggio, tappa fondamentale per lo sviluppo neuropsicomotorio del bambino. Per raggiungerlo, tuttavia, è necessario riuscire a differenziare e cogliere i singoli fonemi, abilità che il neonato dimostra di possedere fin dalla nascita. I bambini sono in grado di discriminare i singoli fonemi, non solo della propria lingua d’origine ma dimostrano analoga competenza anche nei confronti di tutte le altre lingue, anche se non è una capacità che permane in modo costante nel corso dello sviluppo. Infatti, quest’ultima può essere mantenuta esclusivamente se sostenuta dall’esperienza, in quanto la capacità di percezione fonetica universale si trasforma in una competenza sempre più specifica e funzionale per l’apprendimento della propria lingua nel corso della crescita (Camaioni & Di Blasio, 2007).
Oltre a aspetti di tipo linguistico e quindi conseguentemente socio-relazionale, il sistema uditivo contribuisce anche in modo importante a aspetti di tipo cognitivo. Infatti, come si dimostra in modo più evidente nel bambino con ipovisione, la percezione uditiva concorre, insieme alla vista, alla capacità di permanenza dell’oggetto e di continuità dell’esperienza. La possibilità del bambino di poter percepire e inseguire una fonte che si muove nello spazio grazie al suono permette al soggetto di acquisire tale competenza cognitiva, tappa fondamentale per lo sviluppo del bambino stesso. La stessa voce materna, che si sposta nello spazio, dà sicurezza al bambino anche quando quest’ultimo non ne può più percepire la fisicità, permettendo inoltre anche la sperimentazione di primi processi positivi di separazione e individuazione (Zumiani, 2014).
2.3 La sensibilità visiva
La vista è l’ultimo senso a svilupparsi in modo completo. Infatti, inizia la sua maturazione in epoca prenatale, ma la termina solamente nel periodo post-natale. In epoca intrauterina, intorno alla settima settimana gestazionale si formano i neuroni primordiali della retina, tuttavia solo dal terzo mese avviene la mielinizzazione delle cellule gangliari, che terminerà nei primi quattro mesi dopo la nascita. Il feto inizia a percepire la luce a diciotto settimane e a fare i primi movimenti oculari alla ventesima settimana. Lo sviluppo della macula, invece, inizia durante il terzo trimestre e matura nel sesto mese di vista extrauterina, mentre le connessioni tra l’organo principale della sensorialità visiva e l’encefalo richiedono circa cinque mesi. Alla nascita, la capacità visiva del neonato è pari a quella di un feto di 36 settimane gestazionali, in quanto sebbene gli occhi possano recepire l’input, la corteccia visiva non è pronta a elaborare tutte le informazioni (IAPB Italia onlus, 2022). Infatti, i neonati a termine riescono a mettere a fuoco solamente immagini poste a circa 25 cm da loro (Clark-Gambelunghe & Clark, 2015).
In epoca neonatale, i soggetti prestano attenzione alla luce ma risulta limitata la capacità di fissazione, che si sviluppa verso i tre mesi, permettendo la percezione dell’ambiente che li circonda. L’abilità, invece, di inseguire luci in movimento e prestare attenzione a stimoli nuovi si dimostra dai due mesi. Tuttavia, è verso i quattro mesi, quando termina la mielinizzazione, che il lattante è in grado di produrre movimenti oculari più lineari e aumentare l’acuità visiva, permettendo la scoperta degli oggetti. La maturazione delle funzioni visive giunge verso i 18 mesi (Magli & Esposito, 2012).
La percezione visiva è una funzione adattiva che permette lo sviluppo neurologico in modo molto importante, infatti la vista permette e partecipa allo sviluppo delle capacità motorie e dell’apprendimento, allo sviluppo neuropsicologico e psichico e all’evoluzione e crescita emotiva e relazionale, in quanto fondamentale per la creazione delle prime relazioni con i caregiver attraverso il contatto visivo. Inoltre, è alla base dello sviluppo della comunicazione preverbale, per la strutturazione dell’intenzionalità e la reciprocità cognitiva, motoria, affettiva e sociale (Purpura & Tinelli, 2020). Viene, infatti, definita da Fraiberg come “sintetizzatore di esperienze”, mettendo in questo modo in risalto la capacità del sistema visivo di coordinate tutti gli altri sistemi percettivo-sensoriali e di dare un significato univoco all’ambiente (Fraiberg, 1977).
Il canale visivo risulta fondamentale per un buon sviluppo cognitivo, infatti le prime capacità cognitive che si sviluppano avvengono attraverso il confronto attivo tra il bambino e il mondo che lo circonda e grazie alla vista l’individuo può raccogliere e far memoria di tutte le sue esperienze. La sensazione visiva ha una gran componente motivatrice nell’esplorazione del mondo, permettendo in questo modo un apprendimento dal punto di vista sia cognitivo che motorio (Zumiani, 2014). Infatti, la vista collabora anche al controllo del movimento e delle azioni, facendo da costante feedback corporeo. In questo modo permette l’emergere delle capacità di reaching e afferramento dell’oggetto, guidando il bambino nelle abilità manipolatorie, fino-motorie e di coordinazione oculo-manuale (Blasi, 2015).
Lo sviluppo percettivo e sensoriale si dimostra quindi di importanza fondamentale per lo sviluppo neuropsicomotorio del bambino, in quanto si pone come base di numerose abilità che il bambino grazie all’esperienza con l’ambiente circostante può apprendere.
CAPITOLO 3: LA SINDROME DI ANGELMAN
3.1 introduzione e storia della sindrome
La sindrome di Angelman (AS) è una malattia neurologica, di origine genetica, classificata nell’ICD-11 all’interno delle “Condizioni con disordine dello sviluppo intellettuale come caratteristica clinica rilevante” (LD90). Il manuale per la Classificazione Internazionale delle malattie, aggiornato annualmente dall’Organizzazione mondiale della sanità (OMS), definisce come criteri diagnostici: severo deficit cognitivo, caratteristica dismorfia facciale e disordini comportamentali e neurologici.
La sindrome di Angelman viene descritta per la prima volta nel 1965 dal dottor Harry Angelman, pediatra inglese, che, osservando tre bambini, riscontrò alcune similitudini cliniche caratteristiche, quali: disabilità intellettiva, epilessia, atassia, una risata facilmente provocabile, assenza di linguaggio e una dismorfia facciale peculiare associata ad atrofia ottica primaria, tutti segni correlati ad un’origine sconosciuta e che non rientravano in alcun quadro descrivibile o classificabile già esistente. Il dottor Angelman, quindi, decidette di nominare questa specifica categoria di bambini secondo il termine “Puppet children”, ovvero bambini burattini, chiarendo lui stesso di non aver attribuito un nome scientifico, ma una dicitura che potesse dare la giusta allusione alle caratteristiche di questi bambini. (Angelman, 1965). Nel corso degli anni, poi, con l’apporto di altri autori, come B. D. Bower and P. M. Jeavons, il nome si è modificato in “Happy puppet syndrome”, proprio per sottolineare ulteriormente la caratteristica maggiormente peculiare della sindrome, ovvero quella della risata e del riso immotivato (Bower & Jeavons, 1967). Oggi, tuttavia, si preferisce nominare i bambini che presentano questa patologia attraverso la dicitura di “Sindrome di Angelman” (AS), in modo da risultare meno giudicanti e più professionali verso i bambini e le loro famiglie (Clayton-Smith & Pembrey, 1992).
Solo dagli anni ’90 in poi, però, è aumentato l’interesse verso questa patologia, incrementando in questo modo il numero di bambini diagnosticati. Questo grazie ad un maggior investimento nello studio della citologia, della genetica e alla scoperta di caratteristici tracciati di EEG, che permettono e implementano la possibilità di avere una diagnosi precoce e differenziale. (Clayton-Smith & Pembrey, 1992). Oggi nel mondo si conta, secondo i dati di Orphanet, una prevalenza stimata di 1/10.000 e 1/20.000 (Orphanet, n.d.), classificandosi in questo modo come una malattia genetica rara, in quanto la prevalenza non supera il 0,5% della popolazione e quindi non risulta maggiore di una persona colpita ogni 2000, limite stabilito dall’Europa (Presidio della rete Regionale Malattie rare della Regione Campania, n.d.).
3.2 Genotipo e meccanismi genetici
La sindrome di Angelman è una malattia di origine genetica, ma non di forma ereditaria. Infatti, l’alterazione genetica si manifesta in modalità sporadica nel processo di formazione delle cellule riproduttive. Dunque, spesso, le persone affette dalla sindrome non hanno una storia familiare per la patologia. (Telethon, 2021)
La sindrome è causata da un’alterazione dell’espressione di un gene nel cromosoma 15. In questo cromosoma è presente un gene nominato UBE3A che è responsabile della codifica per l’enzima ubiquitina-ligasi E3A, proteina a capo del processo di degradazione delle proteine all’interno delle cellule. Questo enzima ha il compito di legare alle proteine da espellere, una piccola molecola di ubiquitina, in modo da poter essere riconosciute dai proteasomi, le strutture cellulari designate all’eliminazione degli scarti cellulari, e, attraverso un processo di digestione cellulare, essere espulse dalla cellula. Le proteine marcate, e quindi eliminate, sono materiale biologico danneggiato o non necessario, infatti questo processo di eliminazione e degradazione è un procedimento che aiuta a mantenere le normali funzioni cellulari e contribuisce a regolare l’equilibrio della sintesi proteica, all’interno delle sinapsi nervose, dove avviene la comunicazione tra una cellula e l’altra. Il processo denominato proteostasi, ovvero l’omeostasi delle proteine, è fondamentale per permettere la plasticità sinaptica, ovvero l’adattamento nel tempo delle cellule nervose in risposta alle esperienze che l’organismo vive nel corso della sua vita (Medline, 2022).
Il gene UBE3A, codificante per la proteina in questione, nella maggior parte dei tessuti del corpo, è espresso e attivo da entrambe le copie ereditate da ciascun genitore. Tuttavia, nelle cellule del sistema nervoso centrale, è attiva solo la copia ereditaria di origine materna, mentre quella paterna è silenziata. Questo processo è denominato come imprinting genomico. (Medline, 2022)
I geni soggetti all’imprinting genomico non seguono i postulati mendeliani, dove si evince che entrambe le copie dei genitori prendono parte in egual misura alla formazione del tratto fenotipico secondo i canoni di dominanza e recessività, ma, invece, risentono in modo differente dall’espressione materna o paterna. Infatti, questi tipi di geni esprimono in modo distinto il carattere fenotipico in base all’attivazione e al silenziamento dei geni ereditati dai genitori. Questo processo è determinato da un meccanismo di spegnimento dell’espressione genica, denominato per l’appunto imprinting genomico (Rizzo, 2020).
È proprio il meccanismo di imprinting a esplicitare e spiegare al meglio la sindrome di Angelman, in quanto quest’ultima è determinata dalla perdita di funzione di geni che si trovano nella regione cromosomica 15q11-13. In questa regione, infatti, si trovano diversi geni alcuni con imprinting materno, altri con imprinting paterno, come si evince dalla Figura3.
Figura 3. Espressione della regione cromosomica 15q11-13
Perciò, una possibile delezione in questa zona del gene può causare diverse sindromi a seconda che siano trasmesse per via materna o paterna. Infatti, se la delezione è nel gene paterno e sono presenti alleli imprinted inattivi in quello materno allora ci si troverà di fronte a una situazione di Sindrome di Prader-Willi. Se, invece, al contrario è presente una delezione materna e in aggiunta si trovano degli alleli imprinted inattivi dal padre, allora sarà la situazione che causa la sindrome di Angelman. (Rizzo, 2020).
Sembra, quindi, sufficiente la perdita della funzione del gene UBE3A per causare la malattia, tuttavia può essere determinata da 4 diversi meccanismi molecolari:
- Delezione materna de novo del cromosoma 15q11-q13 (70-80%)
- Mutazione intragenica nella regione di origine materna UBE3A (10-20%)
- Disomia uniparentale paterna (UPD) (3-5%)
- Difetto dell’imprinting che alterna l’espressione della regione ereditata dalla madre (3-5%)
Ogni meccanismo molecolare può presentare una variabilità fenotipica, rispetto alle altre (Margolis et al., 2015).
3.3 Diagnosi e diagnosi differenziale
La sindrome di Angelman può essere sospettata quando si individuano determinati criteri clinici, genetici e radiografici. I seguenti criteri per poter diagnosticare la patologia sono stati pensati, elaborati e infine pubblicati dal Scientific Advisory Committee of the US Angelman Syndrome Foundation (Williams et al., 2006).
I criteri clinici fondamentali sono: storia prenatale e natale nella norma, con parametri auxologici standard, inizio di ritardo nello sviluppo psicomotorio dai 6-12 mesi d’età, ritardo di linguaggio, caratterizzato da l’assenza di produzione di parole o la minima produzione, disordine di movimento e di equilibrio, solitamente caratterizzato da atassia e/o tremori e problemi comportamentali, come una frequente risata o sorriso immotivati, eccitabilità e iperattività. Sono presenti poi altri criteri, che però sono stati rilevati in meno dell’80% delle persone affette e quindi non fanno diagnosi, ma possono aiutare nell’indirizzamento della ricerca diagnostica. Questi possono essere: dismorfia facciale, problemi di alimentazione collegata a ipotonia, strabismo, ipopigmentazione, disturbi del sonno e altri.
I criteri di laboratorio, invece, sono collegati alla ricerca genetica di anomalie nella regione del cromosoma 15q11.2-q13. Analisi, invece, metaboliche, ematologiche e chimiche risultano nella norma e non sono significative per una diagnosi.
Le ricerche diagnostiche, attraverso la radiografia, portano ad osservare una struttura nella norma del cervello, anche se è possibile riscontrare una atrofia corticale o una anomalia di mielinizzazione.
Dunque per poter diagnosticare la sindrome di Angelman è importante considerare più fattori, anche se poi, ad essere determinante, è la ricerca genetica che riesce a definire se è presente un’alterazione di espressione o funzione della copia materna dell’allele UBE3A. Possono essere, infatti, proposti i seguenti test molecolari genetici: l’analisi metilica del DNA, che riesce a individuare circa l’80% degli individui affetti, proposto per questo motivo come primo test. Se questo test, però, non riporta alcun risultato allora si può analizzare geneticamente il singolo gene oppure più geni, attraverso i pannelli multigenici, per poter escludere anche ulteriori diagnosi differenziali. Infine è possibile poter fare un test che include anche l’analisi della sequenza dell’esoma, per avere maggiori informazioni dettagliate. (Dagli et al., 2021).
La diagnosi differenziale per la sindrome di Angelman si fa con tutte le patologie che presentano microdelezioni a singoli geni.
3.4 Caratteristiche cliniche del fenotipo
La sindrome di Angelman presenta caratteristiche fenotipiche peculiari che permettono di indirizzare la diagnosi e di essere campanelli d’allarme importanti per potersi accorgere di essere di fronte a una sindrome genetica.
La sindrome comporta un ritardo globale delle tappe psicomotorie, interessando particolarmente l’area grosso-motoria, fine-motoria, del linguaggio, cognitiva e relazionale. Il ritardo psicomotorio è evidente dal primo anno di vita e le capacità che il bambino sviluppa, solitamente, non superano l’età mentale di 24-30 mesi (Bird, 2014).
Le maggiori caratteristiche cliniche vengono sintetizzate nella tabella che segue (Figura 4) che espone i segni e sintomi principali della patologia.
Figura 4. Segni clinici della Sindrome di Angelman (Copyright © 2006 John Wiley and Sons. Adapted with permission from Williams CA, Beaudet AL, Clayton-Smith J, et al. Angelman syndrome 2005: updated consensus for diagnostic criteria. Am J Med Genet. 2006;140(5):413–418.6)
Per quanto riguarda l’area neuropsicologica, il bambino con sindrome di Angelman presenta un importante ritardo sul piano cognitivo, che non lo porta a raggiungere le tappe fondamentali dello sviluppo psichico e cognitivo. Infatti, spesso, questi soggetti possiedono schemi semplici e ripetitivi di pensiero e è difficile per loro sviluppare e comprendere meccanismi più elaborati di problem solving (Bird, 2014). Inoltre, rimane sempre molto presente e importante la fase orale, infatti hanno la tendenza di portare gli oggetti alla bocca e di esplorare prima con la cavità orale che con le mani. L’esplorazione orale è spesso associata a un’ipersalivazione e a scialorrea. (Viri, 2021).
Anche l’area del linguaggio è altrettanto compromessa, difatti la sindrome di Angelman comporta un ritardo sostanziale delle tappe linguistico-comunicative, con spesso quadri di assenza completa di comunicazione verbale, circa tra il 71% e il 90% dei soggetti. Solo pochi individui raggiungono l’uso della parola, spesso caratterizzata da un vocabolario molto ristretto e semplice, con impossibilità di accesso alla frase. Infatti, il vocabolario è solitamente composto, per coloro che accedono alla comunicazione verbale, dalle 2 alle 15 parole, con una media di 5 parole, usate tuttavia raramente con scopi comunicativi (Pearson et al., 2019). Nel 2016, è stato pubblicato uno studio italiano (Micheletti et al., 2016) che ha analizzato e valutato lo sviluppo psicomotorio, in tutte le sue aree, di 10 bambini, dai 5 agli 11 anni, con Sindrome di Angelman e, in particolare nell’area linguistica, è stato riscontrato una grave compromissione delle capacità ricettive e espressive in tutti i soggetti, a tutte le età, con una capacità limitata di poter acquisire l’intera gamma di fonemi della lingua, ma prediligendo quelli nasali e occlusivi, come /m/, /n/, /p/, /b/, come avviene nelle prime fasi dello sviluppo linguistico nei lattanti. Inoltre, la maggior parte dei soggetti che non raggiungono la parola, comunicano esclusivamente attraverso dei vocalizzi, che secondo alcuni studi (Grieco et al., 2018), non sono di tipo avanzato come dittonghi o sillabe canoniche, ma la gamma prodotta è più riconducibile ai vocalizzi tipici dei lattanti tra gli 0 e i 6 mesi di vita. Come la comunicazione verbale, anche quella non verbale è inficiata, ma rimane la forma di comunicazione più usata da questi soggetti (Pearson et al., 2019). Infatti, alcuni studi (Grieco et al., 2018; Micheletti et al., 2016) dimostrano come i gesti deittici, ovvero i gesti che portano l’attenzione dell’altro verso un oggetto, vengono acquisiti e utilizzati dal 50% al 100% del campione, mentre i gesti deittici più specifici, come il pointing, sono raggiunti dal 40% al 50%. I gesti referenziali, invece, non sono così comuni come i gesti deittici. Inoltre, un’altra forma di comunicazione non verbale molto comune per i soggetti con sindrome di Angelman è la manipolazione fisica di altri, dunque l’uso del corpo dell’altro e del proprio per esprimere i propri bisogni e desideri. La comunicazione non verbale, può essere anche sostenuta da strumenti che possono implementarla e permettere e favorire degli scambi relazionali-comunicativi primitivi ma fondamentali. Uno tra questi è l’utilizzo della CAA, è stata infatti studiata l’efficacia che questo strumento può avere con questa tipologia di soggetti e il 70% (Calculator, 2013) ha evidenziato la funzionalità della Comunicazione Aumentativa Alternativa, permettendo così ai soggetti di potersi esprimere in modo più chiaro e esaustivo. La comprensione, invece, sembra migliore della produzione, ma rimane in egual modo compromessa dal basso profilo cognitivo, che a sua volta è inficiato dal disturbo di linguaggio e comunicazione. Infatti, la difficoltà di comunicazione interrompe in modo importante il continuum tra costruzione e condivisione dei significati con il resto del mondo, fondamentale per poter sostenere lo sviluppo cognitivo e relazionale (Costantino, 2021).
L’area emotivo-relazionale, invece, è caratterizzata da un pattern comportamentale caratteristico determinato da: una risata facilmente provocabile e spesso non contestuale, tempi di attesa e attenzione molto brevi per età, stati di iperattività, accompagnati da esplorazione disordinata dell’ambiente. Solitamente sono bambini che ricercano la relazione e lo scambio con l’altro, ma che attuano comportamenti dirompenti come mordere, pizzicare, tirare i capelli. Sono comportamenti che non hanno lo scopo di causare un danno all’altro, ma sono risposte irruenti date da una iniziale difficoltà di comunicazione, dalla possibile frustrazione di non essere capiti, dalla scarsa capacità di modulare la forza e i movimenti e da un importante quadro di ipereccitabilità (Bird, 2014).
Anche a livello motorio è presente un ritardo nelle acquisizioni delle tappe motorie, come dimostra uno studio, (Beckung et al., 2004), per cui su 23 individui di età compresa tra i 21 mesi e i 23 anni, lo stato effettivo dello sviluppo motorio grossolano si aggirava dagli 8 ai 60 mesi, con mediana di 24 mesi, mentre per lo sviluppo delle tappe della motricità fine variava dai 6 ai 60 mesi, con mediana di 15 mesi. Infatti il bambino raggiunge il cammino più tardi rispetto ai suoi coetanei e è evidente una difficoltà a livello di motricità fine. Inoltre, la qualità del movimento è inficiata da possibili tremori e difficoltà di equilibrio, che si racchiudono in un movimento atassico e poco sicuro, spesso a guardia alta, base allargata e titubante. Possono essere presenti anche spasticità a livello degli arti inferiori, soprattutto distalmente, e coattivazione di muscoli agonisti e antagonisti nell’attività di locomozione. La sindrome, inoltre, può portare ad alterazioni di tono durante lo sviluppo e la crescita, infatti la letteratura riporta che il 51% presenta ipotonia durante l’infanzia, che può però diminuire durante la crescita, infatti solamente un 22% presenta ipotonia persistente, mentre un 33% ipertonia (Tan et al., 2011).
Inoltre, come spesso succede per altre sindromi genetiche, anche gli individui con AS sono generalmente dismorfici, tuttavia la facies non compare subito in età neonatale, ma si sviluppa con il tempo, presentando microcefalia, un sottile fenotipo di recessione mediana, prognatismo e bocca larga, queste ultime due caratteristiche sono probabilmente conseguenze della propulsione della lingua, data dal comportamento della bocca e per un aumento del sorriso (Dagli et al., 2021).
3.5 Disturbi associati
La maggior parte dei soggetti presenta difficoltà legate al sonno. Solitamente sono bambini che dormono per poche ore la notte (5-6 ore), senza dimostrare poi il bisogno di recuperare le ore di sonno durante il giorno, ma solamente presentando un ridotto fabbisogno di riposo. Alcuni studi, (Takaesu et al., 2012), inoltre, riportano che i soggetti con Sindrome di Angelman presentano un ridotto valore di melatonina in corpo che spiegherebbe il mancato bisogno di dormire. Spesso i cicli sonno-veglia sono disturbati e poco regolari, ma con la somministrazione di alcuni farmaci possono tornare sotto controllo. Non è ancora chiaro, tuttavia, se il disturbo del sonno influenza la presenza di epilessia o se invece è l’epilessia che si ripercuote nelle difficoltà di sonno di questi soggetti (Bird, 2014).
Infatti, altra caratteristica della Sindrome di Angelman è l’epilessia, circa l’80-90% dei soggetti sviluppa crisi epilettiche. L’insorgenza è solitamente tra 1 e 3 anni di vita, ma il 25% dei soggetti può presentare crisi anche prima di un anno di età. La gravità dell’epilessia può variare a seconda del sottotipo genetico di cui il soggetto è portatore: infatti, risulta un quadro di epilessia più grave nei casi di delezione del gene, seguito poi dalla mutazione isolata di UBE3A, mentre il sottotipo della disomia uniparentale è associato alla frequenza più bassa di epilessia, con fenotipo meno grave. Comunque più del 95% dei pazienti con epilessia può avere crisi giornaliere per un periodo limitato alla prima infanzia, mentre 2/3 dei soggetti sviluppano crisi invalidanti. Le crisi epilettiche possono essere sia generalizzate che focali, anche se solitamente sono più presenti quelle generalizzate, tra cui le più diffuse sono: crisi mioclonica, crisi di assenza atonica e atipica. Inoltre, negli ultimi anni è stato osservato un tracciato tipico dell’EEG in questi pazienti, infatti si è riscontrato che coloro che sviluppano la patologia avrebbero in comune delle anomalie nell’EEG caratteristiche. Questo comporterebbe un importante passo avanti per la diagnosi e per il riconoscimento della patologia, in quanto potrebbe diventare uno degli esami gold standard per la Sindrome di Angelman. Boyd ha riportato l’EEG di 11 bambini con caratteristiche cliniche di AS, di fascia 11 mesi – 11 anni, e ha indentificato 3 caratteristiche comuni a tutti isolate o in combinazione:
- Ritmo persistente 4-6 Hz, attività >= 200 microVolt durante la veglia
- Esecuzioni prolungate del dominante anteriore, con ritmica 2-3 Hz con o senza scariche di onde a punte miste
- Attività delta e theta posteriori di 3-4 Hz >= 200 microVolt, mescolato con punte onda mal definite e facilitato dalla chiusura degli occhi
(Samanta, 2020)
La prognosi dei soggetti che presentano la Sindrome di Angelman non è infausta, infatti l’aspettativa di vita è comune a tutte le persone non portatori della patologia, se pur la qualità di vita non potrà essere la medesima, in quanto tutte le autonomie sono intaccate e risulta, quindi, difficile per una persona con AS potersi autogestire.
3.6 Il profilo sensoriale
Nello studio della Sindrome di Angelman pochi sono stati gli studi sul profilo sensoriale della patologia. Infatti, in letteratura si possono trovare risultati davvero molto limitati sull’argomento (Heald et al., 2021; Peters et al., 2011 Walz & Baranek, 2006). La sindrome stessa, però, suggerisce un pattern sensoriale alterato, peculiare e comune tra i vari soggetti, infatti sono presenti comportamenti di ipereccitabilità, sfarfallio delle mani, esplorazione orale persistente, fascinazione per l’acqua e ipersensibilità per il caldo. Appare chiaro e fondamentale, dunque, svolgere un’analisi attenta e specifica sul profilo sensoriale di questi bambini, per poter comprendere e, successivamente indirizzare, i target per loro più attraenti e facilitanti, in modo tale da poter progredire nella relazione e nella comprensione dell’altro, di sé stesso e del mondo che lo circonda.
Alcuni autori hanno indagato il profilo sensoriale del bambino con sindrome di Angelman: Williams (2005), che descrive queste persone come ipereccitabili, accompagnate da azioni come ridere, afferrare e tirare gli altri con forza, esplorare oralmente in modo eccessivo. Clarke e Marston’s (2000), studiando 72 persone con Sindrome di Angelman, hanno riscontrato che un 22% presenta una fascinazione particolare per la plastica e la gomma, mentre un 68% per l’acqua e i giochi d’acqua. Buntinx et al. (1995) riporta un comportamento irrequieto e iperattivo legato alla masticazione e a leccare gli oggetti a qualsiasi età. Mentre, Clayton-Smith e Pembrey (1992), dopo una valutazione clinica su 82 persone, hanno descritto il campione come amante dell’acqua, affascinato dagli specchi, dai riflessi e con una preferenza specifica per i giochi che fanno rumore. In linea generale, in letteratura gli studi riportano che le persone affette da AS sono sovra eccitabili e molto attive (Clarke & Marston, 2000; Clayton-Smith & Pembrey, 1992; Summers & Feldman, 1999; Walz & Benson, 2002; Zori et al., 1992).
Uno dei pochi studi riportato in letteratura sugli aspetti sensoriali dei bambini Angelman, è quello svolto da Nicolay Chertkoff Walz e Grace T. Baranek (Walz & Baranek, 2006). Lo studio si è basato sulla somministrazione di un questionario indiretto già standardizzato sugli aspetti sensoriali a genitori di 500 bambini Angelman dai 3 ai 22 anni. Il questionario somministrato è il Sensory processing questionnaire (SEQ), utilizzato solitamente per bambini con autismo o disabilità del neurosviluppo. I risultati espressi dallo studio dimostrano che la maggioranza del campione (75%) presenta anomalie sensoriali, che sembrano più evidenti nell’area di ipo-reattività all’input tattile e vestibolare, coerente con le interpretazioni del comportamento “sensory seeking”. Infatti tutti gli stimoli che più attivavano il bambino sono di target tattile o propriocettivo. Infine, lo studio ha confermato l’attrazione per le esperienze sensoriali con l’acqua. Questo studio dimostra come sia importante lavorare nell’area della sensorialità, in quanto, questi bambini presentano una sensorialità alterata rispetto ai coetanei e possibili risposte comportamentali eccessive possono essere date da una ricerca smisurata per determinati target e stimoli sensoriali, in particolar modo tattili. È infatti, scopo, di questo elaborato poter fornire ulteriori dati in merito alle risposte sensoriali di questi bambini, in modo da poter orientare i target proposti in terapia e a casa per facilitare le risposte adattive dei soggetti. Anche lo studio di M. Heald, D. Adams, Walls E & C. Oliver (Heald et al., 2021) sottolinea e suggerisce l’importanza degli stimoli sensoriali come efficaci rinforzi per l’apprendimento di nuove strategie e attività, per poter implementare il range di azione di questi soggetti, che risultano in costante ricerca di nuovi input e stimoli.
Un altro studio, (Heald et al., 2019), invece, ha posto in relazione i profili sensoriali atipici della sindrome di Angelman, di Cornelia de Lange e dell’X fragile, evidenziando come per tutte e tre le patologie sia facile riscontrare un profilo sensoriale differente rispetto a quello classico, ma allo stesso tempo diverso e caratteristico per ogni sindrome citata. Infatti, quello per la sindrome di Angelman si distingue dalle altre per dei comportamenti sensory seeking, ovvero di ricerca di input che attivino nei soggetti sensazioni forti, spiegando in questo modo tutte quelle reazioni di ipereccitabilità in tutti quei momenti di fascinazione per determinati input sensoriali.
Inoltre, è stato dimostrato (Peters Set al., 2011) che non esistono differenze di profili sensoriali tra le diverse tipologie genotipiche della sindrome, infatti tutte e 4 le variazioni molecolari sembrano presentare lo stesso modello di funzionamento sensoriale.
A questo quadro, è bene aggiungere i risultati ottenuti da uno studio svolto da Michieletto e altri autori, che riporta un’analisi approfondita sulla visione e la situazione oftalmica in questa sindrome. Infatti, gli autori riferiscono che un 97% dei casi soffre di ametropia, mentre il 94% di astigmatismo. Inoltre tre quarti del campione ha manifestato ipermetropia e il 75% strabismo (Michieletto et al., 2011).
Il profilo sensoriale, dunque, riportato dalla letteratura risulta omogeneo ma poco dettagliato. È, quindi, parso importante poter approfondire l’argomento in modo più specifico e concreto, in modo da poter contribuire alla descrizione, il più accurata possibile, di un profilo sensoriale coerente alla patologia, così da poter comprendere quali possono essere le conseguenze a livello riabilitativo e se possono essere preferibili determinati proposte di intervento per facilitare il trattamento di questi bambini.
CAPITOLO 4: IL RUOLO DEL TERAPISTA NELLA FASE DI VALUTAZIONE
4.1 Il ruolo del terapista della neuro e psicomotricità: il modello bio-psico-sociale
Il Terapista della Neuro e Psicomotricità dell’Età Evolutiva (TNPEE) è una figura professionale relativamente giovane: infatti è stata regolarizzata e inserita all’interno delle professioni sanitarie solamente con il decreto del 17 gennaio 1997, n. 56, dove, nell’art.1, viene descritta in questo modo: “il terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva è l'operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante, svolge, in collaborazione con l'equipe multiprofessionale di neuropsichiatria infantile e in collaborazione con le altre discipline dell'area pediatrica, gli interventi di prevenzione, terapia e riabilitazione delle malattie neuropsichiatriche infantili, nelle aree della neuro-psicomotricità, della neuropsicologia e della psicopatologia dello sviluppo.”(D.L. 56/97). Dunque, il TNPPEE è una figura professionale dell’ambito sanitario che si occupa esclusivamente di disabilità nell’area evolutiva, ovvero tra 0-18 anni d’età, dove, il range di intervento è correlato alla disabilità dello sviluppo, ossia ogni situazione per cui il soggetto presenta difficoltà nello sviluppo e nella realizzazione del proprio progetto di crescita.
Il TNPEE ha, in questo senso, dunque, come core competence la realizzazione di attività di: riabilitazione, attraverso interventi terapeutici-riabilitativi (b1, Funzioni mentali globali e specifiche; b2, Funzioni sensoriali; b7, Funzioni neuro-muscolo-scheletriche e correlate al movimento), abilitazione, per favorire l’emergere di nuove funzioni (d1, Apprendimento e applicazione delle conoscenze; d2, Compiti e richieste generali; d3, Comunicazione; d4, Mobilità; d7, Interazioni e relazioni interpersonali) e prevenzione, con il fine di precedere l’avvio di sviluppo atipico nelle situazioni di rischio e di prevenire l’esclusione del soggetto diversamente abile, favorendo la generalizzazione in tutti gli ambiti di vita quotidiana. (Abrunzo et al., 2020).
Il TNPEE agisce e interviene seguendo i riferimenti operativi per l’individuazione degli obiettivi descritti dalla Classificazione Internazionale del Funzionamento, delle Disabilità e della Salute – Versione Bambini ed Adolescenti (ICF-CY), elaborata dall’OMS (ANUPI, n.d. (a)). Il suo intervento, infatti, è guidato da un approccio che segue il Modello bio-psico-sociale della disabilità, a sua volta indicato dall’OMS.
L’OMS, infatti, definisce nel 1948, la salute come “Uno stato di completo benessere fisico, sociale e mentale, e non soltanto l'assenza di malattia o di infermità.” (Ministero della Salute, 2017). Parlando in questi termini, dunque, inizia a farsi strada il concetto per cui la stessa disabilità venga vista come conseguenza di una complessa relazione tra le condizioni di salute del soggetto, i fattori personali e quelli ambientali, riportati dalla realtà in cui è immerso. In questo modo, ogni individuo può trovarsi in situazioni di svantaggio, dove è l’ambiente che può limitare la partecipazione e le capacità funzionali dello stesso. Dunque, l’approccio del Modello bio-psico-sociale della disabilità, si vuole porre come sguardo più ampio verso la presa in carico del soggetto, in modo da considerare non solo gli aspetti biologici e di salute strettamente correlati, ma anche tutti quei fattori ambientali che determinano l’area personale e sociale dell’individuo e che, spesso, risultano maggiormente impattanti (Università degli studi della Basilicata, 2021).
Infatti, a sostegno del modello bio-psico-sociale nell’ambito della disabilità, è stato istituito l’ICF (International Classification of Functioning, Disability and Health), un manuale che può essere usato come strumento di progettazione e identificazione dei bisogni, nella scelta dei trattamenti e nella realizzazione dei piani d’intervento. È l’OMS stesso che raccomanda l’integrazione tra l’ICD (International Classification of Diseases) e l’ICF a tutti gli operatori che intervengono e riabilitano persone con disabilità. In questo manuale, il modello biopsicosociale è alla base dei principi teorici che lo sostengono, ponendo in questo modo maggiore attenzione all’analisi del contesto personale, sociale e fisico, in modo da consentire all’operatore di cogliere la persona nella sua interezza. Infatti questo modello permette di porre sullo stesso piano gli aspetti riguardanti la salute, da un punto di vista medico, e gli aspetti di partecipazione sociale, il tutto inserito nella cornice fondamentale dettata dai fattori ambientali e dunque dall’ambiente dove l’individuo è inserito. Attraverso questi principi, quindi, lo specialista può basare la sua osservazione su 3 piani differenti: corpo, persona e ambiente, consapevole che l’uno influenzerà l’altro, in quanto la disabilità colpisce in modo universale tutti gli aspetti della persona stessa (ANUPI, n.d. (b)).
4.2 L’importanza del setting
Per quanto appena esposto, risulta importante, per un terapista, considerare l’ambiente in cui il bambino è immerso e come questo può modificare il suo stato di salute e di stress psicofisico. Per questo, diventa obiettivo principale, nella prima fase, creare un ambiente sicuro, stabile e accogliente per il bambino all’interno dell’intervento neuro-psicomotorio, in modo da facilitare e promuovere lo sviluppo delle abilità dello stesso.
Infatti, lo scopo della terapia neuropsicomotoria è quella di far vivere al bambino concretamente le sue problematiche con lo scopo di ricostruire e promuovere esperienze e vissuti delle fasi evolutive per stimolare lo sviluppo delle competenze non ancora acquisite. In questo modo, quindi, è necessario una cornice che contenga le dinamiche terapeutiche vissute per sottolineare l’importanza di ogni attività esperita. Per raggiungere i propri obiettivi terapeutici il terapista necessiterà di impostare un setting specifico basato sull’agito corporeo e sulle capacità di base del bambino (Russo, 2018).
Il setting neuro-psicomotorio è costituito da un tempo e uno spazio delimitati e definiti all’interno della vita del bambino. È un ambiente che, deve essere considerato dal bambino, come un ambiente nuovo dove può esprimere liberamente le sue modalità, attraverso la realizzazione di un valido rapporto di fiducia con il terapista. Il setting definisce la cornice e delimita l’azione del bambino, dando a lui la libertà di potersi esprimere per rielaborare e plasmare i vissuti delle proprie esperienze e per sperimentare nuove abilità evolutive, diventa infatti, in questo modo, un luogo personale separato dalla realtà esterna dove il bambino può sentirsi accettato per come è e dove è possibile quindi dare un senso terapeutico alle cose che accadono in terapia. Il setting terapeutico diventa così uno spazio-tempo intermedio tra realtà esterna ed il Sé, con la possibilità, tuttavia, di una comunicazione tra le due realtà mediata da una propria e esclusiva elaborazione (Russo, 2018).
Ogni professione è tale per il suo setting, secondo Boscaini (Boscaini et al., 1992), e quello neuro-psicomotorio solitamente è costituito da una specifica sistemazione degli oggetti, che suggerisce spazialmente i quattro stadi evolutivi alla base dello sviluppo psicomotorio, ovvero lo stadio senso motorio, lo stadio tonico-emozionale, lo stadio simbolico e di realtà. Infatti, in ogni stanza di terapia è comune trovare:
- Lo spazio sensomotorio: caratterizzato da oggetti e giochi visibili e accessibili. Sono oggetti grandi che coinvolgono tutto il corpo, con il quale il bambino può sperimentare il movimento, come corde, palloni, cubi etc. È un movimento spesso senza progettualità, ma con il solo fine di raccogliere stimoli piacevoli e conoscere la realtà per modificarla.
- Lo spazio tonico-emozionale, invece, è determinato da materassi, coperte, oggetti morbidi, dove il bambino può sperimentare sensazioni di abbandono e rilassamento che rimandano al dialogo tonico con il care-giver.
- Lo spazio simbolico è solitamente rappresentato dalla presenza di uno specchio, oggetto fondamentale nella stanza neuropsicomotoria
- Lo spazio del reale è determinato dal luogo designato al tavolino e alle sedie, dove il bambino può esprimersi attraverso una motricità più controllata a servizio del pensiero. (Bonavolonta, 2012)
È necessario per il bambino che il setting venga attuato in maniera molto rigorosa da parte del terapista, in modo tale da fornire stabilità e sicurezza al bambino ed essere riconosciuto da quest’ultimo, ma allo stesso tempo non deve essere applicato in maniera rigida, infatti deve essere flessibile a seconda delle esigenze del bambino e quindi adattarsi in base alle sue caratteristiche, al progetto, al momento evolutivo in cui ci si trova e alla storia terapeutica (Savini, 2021).
4.3 La capacità di osservare
L’Associazione Nazionale Unitaria Psicomotricisti Italiani (ANUPI) da anni si interessa della tutela dei TNPEE e del loro riconoscimento nell’ambito sanitario e lavorativo. Ha, così, steso e fornito un modello di protocollo da poter seguire per strutturare la propria attività di riabilitazione e abilitazione, in modo da facilitare i professionisti, regolarizzare l’attività e creare un legame di maggior fiducia con i caregiver, in quanto il progetto è chiaro, semplice e ben strutturato. In questo modo, si instaura un contratto terapeutico tra operatore e famiglia, che facilita e stabilizza il rapporto tra le due parti, rendendolo ancora più solido e equo. Il modello divide il trattamento in diverse fasi:
- L’analisi del caso, dove il professionista riceve dall’inviante, che può essere il medico di base, il neuropsichiatra infantile o lo psicologo, il caso e fissa un primo incontro conoscitivo con i genitori.
- L’osservazione, fase fondamentale per rilevare le informazioni che l’operatore necessita per poter strutturare il proprio trattamento. Inoltre risulta importante anche per dare un contributo al profilo diagnostico del soggetto.
- Il progetto psicomotorio, dove si individuano le modalità, gli obiettivi, le tempistiche e la verifica dell’azione. È un progetto che viene condiviso con i genitori e che viene monitorato nel tempo anche dalla figura di riferimento e coordinamento del caso clinico.
- Le verifiche, attuate con i tempi designati dal progetto, possono riguardare gli obiettivi, i progressi, le problematiche, le modalità di conduzione, l’aderenza o lo scostamento dalle linee del progetto.
- Le dimissioni.
(Berti et al., 2015).
La fase di osservazione si pone come prima forma di interazione con il bambino e diventa in questo modo un momento che sancisce la relazione e il rapporto di fiducia tra quest’ultimo e il terapista. È, per questo quindi, una fase molto importante e delicata, dove il professionista deve investire le sue energie e risorse affinché si possa creare la base giusta per continuare un eventuale percorso di trattamento. Inoltre, è un momento all’interno del progetto riabilitativo limitato e definito nel tempo, infatti le sedute dedicate all’osservazione sono di numero inferiore rispetto a quelle riabilitative e sono definite a livello temporale in modo chiaro e preciso, sancendo con la loro conclusione l’inizio di una fase completamente diversa: quella dell’azione (Berti et al., 2015).
Osservare, tuttavia, non è un’attività semplice, richiede uno sforzo e un allenamento costante. Infatti, al terapista viene richiesto di selezionare e raccogliere informazioni nel modo più completo e accurato possibile, senza omettere e allo stesso tempo senza rischiare di strabordare nella soggettività dell’osservatore e delle sue ipotesi. Infatti, una buona osservazione è quella che riesce a estrapolare le giuste informazioni, per poi poterle elaborare e strutturare in un pensiero critico e clinico. Rispetto a un esperimento, l’osservazione non prevede la manipolazione delle variabili, se non a un livello minimo e si basa esclusivamente sulle capacità dell’osservatore (Berti et al.,2015).
L’osservazione può essere strutturata o naturalistica. L’osservazione strutturata prevede l’intervento attivo dell’osservatore, che fornisce stimoli affinché si verifichi un certo comportamento, spesso è standardizzata ed è molto più simile ad un approccio sperimentale. L’osservazione naturalistica, invece, presuppone la fase di osservazione all’interno dell’ambiente naturale del soggetto con la riduzione al minimo delle interferenze da parte dell’osservatore. In questo caso quindi non ci sono variabili da controllare, ma si osserva il comportamento spontaneo del soggetto. Il padre dell’osservazione naturalistica, o etologica, è Konrad Lorenz, che ha utilizzato questa modalità principalmente per osservare e comprendere lo sviluppo comportamentale degli animali, studiando e promuovendo il concetto di imprinting (Morelli De Rossi, 2020).
Per il TNPEE, inoltre, l’osservazione può caratterizzarsi a seconda del grado di partecipazione del terapista stesso all’interno delle sedute dedicate a questo momento. Infatti, l’osservazione può essere: diretta e partecipata, diretta non partecipata o differita. Si parla di osservazione diretta e partecipata quando l’operatore è a diretto contatto con il bambino e interagisce con quest’ultimo; il terapista può relazionarsi con il bambino attraverso la guida di esercizi o attività specifiche, o lasciandolo più libero, affinché sia lui stesso a prendere iniziativa. L’osservazione diretta non partecipata, invece, prevede un contatto tra bambino e terapista ma senza l’interazione tra i due, mentre l’osservazione differita, non presuppone nessun tipo di contatto, infatti l’operatore osserva il bambino solamente attraverso una videoregistrazione (Berti et al., 2015).
Il TNPEE, tuttavia, a differenza di altre figure professionali ha come oggetto di osservazione non solo il bambino, bensì anche la sua relazione con il terapista stesso, in quanto le relazioni che si vanno ad instaurare nel rapporto terapeutico sono più della somma delle componenti stesse. Infatti, l’interazione spesso dice molto di più e descrive in modo più accurato il soggetto stesso. Inoltre, le stesse azioni del bambino non sono altro che risposte a input e stimoli che il terapista stesso propone in modo diretto o indiretto, ma pur sempre consapevole. È importante, quindi, per il terapista essere conscio che l’attività di osservazione del bambino, si presenta allo stesso tempo come un’attività di auto-descrizione e auto-osservazione. Questo processo, quindi, deve essere frutto di un elaborato e lungo processo di apprendimento e auto-controllo del proprio agire e del proprio stile comunicativo, in modo da attuare degli atteggiamenti congrui e coerenti con l’agire del bambino (Berti et al., 2015).
Considerando tutto ciò, è impossibile poter affermare che l’osservazione sia del tutto oggettiva. Infatti, è ormai accettato che l’osservatore e l’osservato siano all’interno dello stesso sistema e quindi formino un tutt’uno. L’osservazione quindi non è altro che la descrizione della relazione tra i soggetti stessi ed appartiene al dominio cognitivo dell’osservatore. Quindi l’osservazione è contemporaneamente la descrizione dell’osservatore, delle sue teorie e dei suoi valori impliciti ed espliciti (Berti et al., 2015).
CAPITOLO 5: MATERIALI E METODI
5.1 La necessità di una scheda di osservazione
Nella pratica neuropsicomotoria risulta di centrale importanza, come già descritto precedentemente, l’osservazione del bambino e delle sue capacità di relazionarsi con il mondo. È evidente, infatti, la rilevanza del ruolo dell’osservazione all’interno del progetto riabilitativo e della storia terapeutica del soggetto, nonostante sia altrettanto chiara la difficoltà da parte dell’osservatore di riuscire a descrivere nel modo più coerente e esaustivo quello che osserva. Nel corso degli anni, dunque, sono state strutturate schede e protocolli di osservazione e valutazione, che andassero a validare il lavoro del terapista, rendendo l’osservazione più sistematica e oggettiva. Un’osservazione sistematica, svolta attraverso un protocollo osservativo, permette di seguire una traccia e di organizzare l’osservazione in aree funzionali. In questo modo, i singoli item hanno lo scopo di individuare più facilmente e velocemente gli aspetti fondamentali da osservare per la descrizione del funzionamento del bambino, permettendo di attuare una sintesi tra l’osservazione strutturata e quella spontanea. L’utilizzo di uno strumento osservativo, inoltre, sostiene gli operatori nel processo di monitoraggio e confronto dei risultati nel tempo: utilizzando sempre il medesimo protocollo di osservazione, questo permette di evidenziare il possibile andamento dell’evoluzione del bambino, all’interno di un protocollo che non varia nel tempo. (Burbi, 2016).
Le schede e i protocolli di osservazione diretta che indagano gli aspetti sensoriali presenti in letteratura, tuttavia, non sono numerosi. Pochi, infatti, sono gli strumenti che il terapista può utilizzare se vuole indagare in modo più sistematico queste caratteristiche. Solitamente, l’area sensoriale è imputata a questionari indiretti consegnati ai genitori o all’ambiente scolastico, che considerano le abitudini sensoriali del bambino nella sua quotidianità. Risulta invece importante, poter osservare, anche all’interno del setting neuropsicomotorio, in ogni bambino le risposte agli stimoli sensoriali, in quanto, come già descritto, lo sviluppo sensoriale contribuisce e influenza lo sviluppo globale neuropsicomotorio. È, dunque, importante poterlo indagare nel tempo, attraverso un’osservazione più sistematica. Inoltre, diventa un aspetto fondamentale poter indagare le caratteristiche sensoriali soprattutto in bambini dove questi aspetti risultano una chiave ulteriormente importante nella relazione con il mondo.
Si è sentita quindi l’esigenza di poter indagare e approfondire il profilo sensoriale del bambino con Sindrome di Angelman, affinché possa essere punto di partenza per promuovere strategie che possano permettere al bambino di entrare in maggiore relazione con sé stesso, l’altro e il mondo, attraverso nuove risposte adattive che possano sostenere lo sviluppo neuropsicomotorio del bambino stesso. È stata, dunque, effettuata una ricerca bibliografica tramite la piattaforma Pubmed allo scopo di individuare gli strumenti osservativi e valutativi validati esistenti per l’osservazione e valutazione del profilo sensoriale e percettivo del bambino. Le voci usate nella ricerca sono state “sensory test”, “sensory scale”, “infant development”, “sensory profile” e “children”. La ricerca ha portato all’individuazione di alcuni modelli di osservazione di riferimento: il “Test of Sensory Function in Infants”, il “Sensory Rating Scale” e il “Sensory Profile 2”.
Il “Test of Sensory Function in Infants” è un test per soggetti dai 4 ai 18 mesi e misura principalmente i comportamenti sensoriali difensivi, quindi di evitamento e ipersensibilità agli stimoli. Viene somministrato a bambini con disturbi regolatori e ritardi dello sviluppo. Il test è composto da 24 items e richiede l’interazione dell’infante con determinati materiali, tra cui stimolazioni tattili, di pressione, di integrazione visivo-tattile, vestibolari e di controllo oculomotorio (Eeles et al., 2012).
Il “Sensory Rating Scale” è una scheda di valutazione indiretta che compila il caregiver utilizzata per identificare e quantificare la reattività sensoriale dei bambini da 0 a 3 anni d’età. La scheda va a indagare il tatto, l’udito, la vista, il gusto, l’olfatto, il temperamento e gli aspetti dell’area motoria. La scheda presenta 2 versioni: il modulo A composto da 88 items e utilizzabile dalla nascita agli 8 mesi d’età e il modulo B, con 136 domande, compilabile dai 9 mesi ai 3 anni. Ogni elemento di valutazione sensoriale può essere valutato con un punteggio che va da 1 a 5, con 5 considerato ad alto rischio di comportamenti sensoriali difensivi, come risposta ritardata al dolore, ritiro, o scarsa risposta (Eeles et al., 2012).
Il “Sensory Profile 2” è uno strumento che individua e descrive il profilo sensoriale di bambini e adolescenti dalla nascita ai 14 anni. È un questionario indiretto che compila il caregiver e/o la scuola per descrivere i pattern di processazione sensoriale e le risposte del soggetto agli stimoli esterni. Si suddivide in 5 protocolli a seconda dell’età del bambino e ognuno è articolato in diverse sezioni: sensoriale, comportamentale, quadranti e fattori scuola, solo per il questionario relativo a quest’ultima. La scheda è basata sul Sensory Processing Framework di Winnie Dunn (1997), che spiega le modalità con cui le persone processano le informazioni sensoriali, individuando quattro specifici pattern sensoriali: registrazione, ricerca, sensibilità e evitamento. (Giunti psychometrics, n.d.(b)).
Dalla ricerca fatta, è emersa l’esigenza di avere a disposizione uno strumento osservativo pratico, che si basi sulle schede già esistenti in letteratura, che possa validare l’osservazione diretta del terapista all’interno della seduta neuropsicomotoria, al fine di individuare obiettivi e strategie funzionali per il bambino e i caregiver. Per questo motivo è nata la necessità di stilare e costruire una scheda di osservazione che possa essere strumento utile per il terapista nella fase di osservazione e valutazione del bambino in età prescolare, andando a indagare in modo diretto, all’interno del setting neuropsicomotorio, le sensorialità di quest’ultimo e le sue competenze legate al profilo sensoriale. Inoltre, come già citato, è limitato in letteratura l’approfondimento sugli aspetti sensoriali del bambino con Sindrome di Angelman, pur possedendo caratteristiche peculiari nell’area sensoriale. È risultato, quindi, rilevante poter andare a indagare il profilo sensoriale di questa patologia rara con lo scopo di promuovere risposte adattive e individuare canali sensoriali che possano sostenere lo sviluppo neuropsicomotorio di questi bambini.
5.2 La scheda di osservazione del profilo sensoriale nella sindrome di Angelman
Alla luce di queste premesse, è stata costruita la seguente scheda di osservazione (Allegato 1) per andare a indagare se e quale canale sensoriale attiva di più una risposta adattiva, che può essere di tipo relazionale, comunicativo, motorio o cognitivo, in bambini di età prescolare con Sindrome di Angelman.
SCHEDA DI OSSERVAZIONE E VALUTAZIONE SENSORIALE DEL BAMBINO CON SINDROME DI ANGELMAN
Nome_____________________________________________________________ Cognome__________________________________________________________
Data di nascita___/____/_____
Anamnesi__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Nome del terapista della neuro e psicomotricità____________________________
Data dell’osservazione___/____/____
Note da allegare____________________________________________________
_________________________________________________________________
MATERIALI
|
Adattamento visivo |
Adattamento uditivo |
Adattamento tattile |
|
|
Ventose |
Ventosa con pattern bianchi e neri Ventosa con volto stilizzato |
Ventosa con sonaglio |
Ventosa morbida Ventosa ruvida |
|
Riccio |
Aculei a forte contrasto |
Aculei con sonaglio |
Aculei morbidi Aculei ruvidi |
|
Palline + scatola di cartone con buco centrale |
Palla con luce all’interno |
Palla con sonaglio |
Palla liscia Palla ruvida Palla fredda Palla calda |
SETTING E MODALITA’ DI PROPOSTA
Le diverse proposte vengono presentate una per volta, differenziando il setting a livello spaziale e temporale e strutturando il materiale in modalità differenti l’uno dall’altro.
Ventose: le ventose, adattate per i 3 tipi di sensorialità che la scheda indaga, vengono proposte su una superficie verticale es. specchio, in modo da favorire i passaggi posturali. L’altezza è variabile a seconda del bambino e delle sue competenze motorie. Importante dopo una prima osservazione, provare a cambiare l’ordine spaziale delle ventose per evitare che la risposta del bambino venga condizionata da altri fattori, quali: rapidità nella risposta, vicinanza del target e/o preferenza spaziale. Proporre contemporaneamente tutti i target, avendo cura che siano posizionati tutti alla stessa altezza.
L’esaminatore deve attendere la risposta del bambino e il suo orientamento verso il target, può, però, fornire una guida fisica e/o verbale, per far capire al bambino come avviare lo schema motorio. Si posiziona di lato al bambino, per poter interagire con lui, se e quando il bambino attiva risposte relazionali e emotive.
Riccio: il riccio viene proposto a tappeto, in uno spazio preferibilmente contenuto e libero da altri stimoli, che possono distrarre il bambino. Si presenta, quindi, con il bambino seduto, preferibilmente in long sitting, e con il gioco posto di fronte a lui, in modo da facilitare il movimento di prensione e l’afferramento.
L’esaminatore si posiziona di fronte al bambino, seduto a tappeto. Presenta il target e favorisce i diversi schemi di movimento attraverso la guida verbale e fisica, se necessaria, o attraverso l’imitazione. È chiamato a relazionarsi con il bambino, rispondendo ai comportamenti emotivi e sociali che il bambino mette in atto, durante l’attività.
Palline: l’attività delle palline e della scatola di cartone viene presentata in uno spazio privo di altri stimoli e vuoto, per incentivare il movimento e lo spostamento, in modo prevalente. Il bambino infatti deve essere nelle condizioni di potersi muovere liberamente nello spazio e di poter raggiungere il target che preferisce, nelle modalità a lui più consone. È importante, però, avere la possibilità di poter posizionare la scatola di cartone, con il buco per fare canestro, a diverse altezze e quindi usufruire di diversi piani dello spazio, per favorire i passaggi posturali e l’orientamento spaziale, non solo orizzontale ma anche verticale. Le palline, adattate in modo che ognuna possa rappresentare una tipologia di sensorialità diversa, vengono proposte inizialmente una alla volta, per poter osservare come il bambino si comporta e successivamente di più contemporaneamente, favorendo in questo modo l’emergere di una scelta binaria. Lo scatolone, inoltre, va proposto anche per favorire risposte cognitive, quali la permanenza dell’oggetto, e di schemi d’azione semplici, come mettere dentro e tirare fuori, è importante quindi dedicare del tempo anche a proposte di tipo cognitivo e relazionale posizionando, nello spazio, lo scatolone all’altezza del bambino, in modo tale che quest’ultimo sia capace di interagire con la scatola e di utilizzarla come canestro.
L’esaminatore deve presentare i diversi target uno alla volta, posizionandoli in un secondo momento a diverse altezze e in diversi piani dello spazio, per favorire lo spostamento e l’orientamento. Si deve porre come partner di relazione e di gioco, favorendo lo scambio relazionale e emotivo, attraverso scambi e giochi di interazione. Inoltre, deve essere un iniziale modello per il bambino, mostrando le possibilità d’azione con la scatola e la palla, come mettere dentro e tirare fuori, proporre attività di permanenza dell’oggetto o di scelta binaria, sempre incoraggiando e guidando il bambino con la voce e il proprio assetto posturale.
SCHEDA
Compilare la scheda indicando, secondo la legenda (A1, A2, A3, B1, B2, C1, C2, C3, C4, D, NV), qual è il target sensoriale che maggiormente ha attivato nel bambino una risposta. È possibile, poi, aggiungere delle considerazioni qualitative sull’osservazione, nello spazio finale dedicato alle note.
Legenda:
- Target visivo
- Pattern luminoso
- Pattern bianco/nero
- Alto contrasto
- Target uditivo
- Target a bassa frequenza
- Target ad alta frequenza
- Target tattile
- Target morbido
- Target ruvido
- Target caldo
- Target freddo
- Non significativamente rilevabile
NV. Non valutabile
|
ITEM |
A1 |
A2 |
A3 |
B1 |
B2 |
C1 |
C2 |
C3 |
C4 |
D |
NV |
|
1. Richiama l’attenzione del partner |
|||||||||||
|
2. Instaura l’attenzione condivisa |
|||||||||||
|
3. Uso protesico dell’adulto |
|||||||||||
|
4. Pointing richiestivo |
|||||||||||
|
5. Pointing dichiarativo |
|||||||||||
|
6. Modifica la mimica facciale |
|||||||||||
|
7. Attua semplici schemi di turnazione |
|||||||||||
|
8. Accenna schemi di imitazione (espressioni facciali, suoni vocalici, gesti codificati e non) |
|||||||||||
|
9. Modula il tono |
|||||||||||
|
10. Aumenta l’intento comunicativo |
|||||||||||
|
11. Aumenta la possibilità di comunicare attraverso gesti codificati e non |
|||||||||||
|
12. Aumenta la possibilità di comunicare verbalmente |
|||||||||||
|
13. Fissazione e inseguimento |
|||||||||||
|
14. Maggior investimento dell’esplorazione manipolatoria |
|||||||||||
|
15. Migliora la coordinazione occhio-mano |
|||||||||||
|
16. Migliora la coordinazione bimanuale |
|||||||||||
|
17. L’afferramento risulta più deciso, sicuro e orientato |
|||||||||||
|
18. Adatta la presa al target |
|||||||||||
|
19. Amplia i suoi schemi di azione di motricità fine (es. girare, lanciare, infilare, mettere dentro/tirare fuori) |
|||||||||||
|
20. Attua i passaggi posturali in modo funzionale e adeguato per età |
|||||||||||
|
21. Attua spostamenti pre/locomotori |
|||||||||||
|
22.Orienta la sua attenzione e le sue azioni verso il target |
|||||||||||
|
23.Localizza e raggiunge il target |
|||||||||||
|
24. Mantiene l’attenzione per una lunga durata |
|||||||||||
|
25. Riduzione dei tempi di latenza |
|||||||||||
|
26. Capacità di attesa |
|||||||||||
|
27.Riduzione dell’esplorazione orale |
|||||||||||
|
28. Permanenza dell’oggetto |
|||||||||||
|
29. Scelta binaria o tra più oggetti |
|||||||||||
|
30. Comprende la relazione di casualità tra gli oggetti |
NOTE:__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
5.3 Scopo della scheda
L’obiettivo principale dell’osservazione neuropsicomotoria del bambino che presenta disordini del neurosviluppo è la decodifica del comportamento spontaneo e delle azioni attuate per potersi relazionare con la realtà estera e circostante, con lo scopo di poter individuare le potenzialità evolutive e le peculiarità adattive proprie di ogni bambino, per poter poi definire gli obiettivi di riabilitazione capaci di favorire lo sviluppo globale (Wille & Ambrosini, 2010).
Inoltre, negli ultimi anni è avvenuto un cambiamento culturale che ha portato a evidenziare l’importanza di un approccio olistico e globale del bambino, mettendo, in questo modo, al centro della presa in carico tutti gli aspetti di vita del bambino e della sua famiglia e non le singole aree di sviluppo (Fedrizzi, 2009).
Come più volte argomentato, il bambino non è un mero recettore di stimoli ma grazie agli input ambientali riesce a produrre delle risposte adattive, che possono essere di tipo motorio, sociale, emotivo e cognitivo, che a loro volta determinano il comportamento e dunque lo sviluppo neuropsicomotorio del bambino stesso. Questo permette, come fine ultimo di ogni osservazione neuropsicomotoria, quello di riuscire a cogliere il manifestarsi delle problematiche evolutive e le modificabilità adattive capaci di promuovere e sostenere lo sviluppo globale del bambino stesso.
La Scheda di osservazione e valutazione del profilo sensoriale del bambino con Sindrome di Angelman, dunque, nasce proprio dalla necessità di aiutare e sostenere il lavoro del terapista di fronte all’esigenza di comprendere quali possano essere le strategie più funzionali per ciascun soggetto con questa patologia in grado di promuovere una maggiore adattabilità al mondo esterno in tutti i suoi aspetti. Rappresenta, infatti, uno strumento specifico per l’individuazione delle caratteristiche sensoriali di ciascun bambino in età prescolare con Sindrome di Angelman, identificando i canali sensoriali preferenziali in modo da poter adattare le proposte nel trattamento e nella quotidianità, per favorire l’aumento di risposte adattive e funzionali, che possano promuovere lo sviluppo motorio, emotivo, relazionale, comunicativo-linguistico e cognitivo del bambino.
La Scheda di osservazione e valutazione del profilo sensoriale del bambino con Sindrome di Angelman ha lo scopo di delineare uno strumento per il terapista, condivisibile anche con il caregiver, che possa strutturare un’osservazione qualitativa degli aspetti senso-percettivi del bambino con Sindrome di Angelman, all’interno delle sedute di osservazione e valutazione. Dunque, permette di sistematizzare l’osservazione neuropsicomotoria, con l’obiettivo di suggerire e fornire una guida di lettura delle modalità di approccio adattivo alla realtà esterna che il bambino è in grado di metter in atto dalle diverse esperienze sensoriali proposte dall’adulto.
Il lavoro compiuto è stato quello di sistematizzare l’osservazione neuropsicomotoria definendo il setting, il materiale sensoriale da proporre, le modalità con cui farlo e le competenze da osservare per sostenere il terapista nella comprensione delle abilità di adattamento al mondo esterno e del funzionamento del bambino stesso. Tutti fattori fondamentali per l’impostazione di un progetto riabilitativo, capace di definire obiettivi e strategie, atte a promuovere la modificabilità adattiva del bambino e di favorire lo sviluppo delle tappe neuropsicomotorie.
Inoltre, il progetto di ideazione del protocollo di osservazione è risultato rilevante anche nel fornire strategie e indicazioni più strutturate e personalizzate ai caregiver. Infatti, la scheda è stata costruita anche con il fine di riuscire a trasferire e adattare gli obiettivi riabilitativi, nella vita quotidiana con la partecipazione e il coinvolgimento attivo dei genitori, diventando in questo modo anche strumento utile per il trattamento indiretto. È importante, infatti, essere consapevoli dell’importanza del ruolo del caregiver e del contesto di vita quotidiano per lo sviluppo delle abilità e potenzialità del bambino, riconoscendo i genitori come massimi esperti dello sviluppo e delle competenze del proprio figlio.
5.4 La struttura della scheda
Il protocollo di osservazione si compone di diverse parti. La sezione iniziale è dedicata alle generalità ed informazioni anamnestiche del paziente. Inoltre, è presente un piccolo riquadro dedicato alle note, dove è possibile annotare brevemente eventuali considerazioni sulla famiglia o sulla situazione e storia clinica del bambino.
Successivamente, in modo schematico, vengono presentati i materiali da utilizzare, differenziati tra loro in base alle loro caratteristiche sensoriali e alla risposta adattiva che evocano. Ogni materiale possiede una proprietà sensoriale caratteristica e precisa che fa riferimento a valori standardizzati in letteratura, capaci quindi di determinare risposte adattive nel bambino. Il protocollo utilizza 3 tipologie di materiali differenti, scelti per scopi specifici, dove per ogni categoria è rappresentata una sensorialità differente, tattile piuttosto che uditiva o visiva, pur presentando le stesse forme e dimensioni, permettendo, in questo modo, di chiarire eventuali dubbi sulla relazione tra la scelta e le caratteristiche intrinseche dell’oggetto diverse dalla sensorialità.
Vengono, poi, descritte in modo accurato e specifico le modalità di proposta del materiale e il setting in cui immergere il bambino, spiegando, inoltre, il ruolo dell’esaminatore e quello che è portato a fare per poter fare emergere le risposte adattive attraverso il materiale proposto. In questo modo si può garantire una maggiore omogeneità nella rilevazione dei dati e una maggiore sistematicità nell’osservazione.
Lo strumento principale, tuttavia, rimane la tabella che racchiude gli item e le competenze da osservare nel bambino con rispettiva legenda per la compilazione. La tabella è composta da numerose risposte adattive di tipo emotivo-relazionale, comunicativo-linguistico, motorio e cognitivo che il bambino può mostrare in riferimento alla sua età. Queste abilità, selezionate come indicatori dello sviluppo neuropsicomotorio in età prescolare, sono disposte in un’iniziale colonna verticale e organizzate visivamente per colore seguendo le aree principali dello sviluppo neuropsicomotorio. Per ogni item di competenza, il terapista può compilare, seguendo la legenda, quale canale sensoriale maggiormente promuove quella determinata risposta. È, dunque, premura dell’osservatore soffermarsi sulla lettura dei comportamenti del bambino per poter compilare la scheda, dall’analisi successiva dei risultati il terapista avrà la possibilità di poter comprendere il funzionamento adattivo del bambino e quindi poter stilare un progetto riabilitativo che possa sostenere lo sviluppo neuropsicomotorio specifico di quel soggetto.
Nella parte finale della scheda, invece, è presente una sezione dedicata alle note dove è possibile descrivere in modo più dettagliato l’osservazione, in quanto la tabella limita gli aspetti più qualitativi dell’osservazione neuropsicomotoria, dunque questa parte può essere utilizzata dal terapista per annotare i modi dell’azione e le variazioni al protocollo, in modo da rendere l’osservazione ancora più completa e individualizzata.
5.5 Modalità di realizzazione della scheda
Per la costruzione del protocollo di osservazione si sono presi in considerazione le esperienze cliniche passate presenti in letteratura e ampiamente utilizzate dai terapisti oggi come strumenti di osservazione neuropsicomotoria nelle prime sedute di valutazione. In particolare, per la stesura e la scelta degli item è stata utilizzata la Scheda di Osservazione/Valutazione Neuropsicomotoria (SON), opera di Gison G., Bonifacio A. e Minghelli E.
Pur variando le proposte del terapista nel corso della seduta, le competenze del bambino da osservare sono trasversali e rimangono le stesse nonostante cambi il materiale sensoriale utilizzato. È importante poter valutare tutte le possibili risposte adattive, perché è attraverso di esse che il bambino può entrare in relazione con l’altro e con la realtà esterna e dunque poter sostenere lo sviluppo relazionale, cognitivo, motorio, linguistico e sensoriale. È la possibilità e l’abilità del bambino di poter percepire l’oggetto nella sua totalità e di possedere il desiderio di raggiungerlo o manipolarlo che favorisce e promuove uno sviluppo psichico e cognitivo, attraverso la creazione di rappresentazioni mentali e la capacità di percepire sé stesso, l’altro e il mondo.
Gli item, quindi, utilizzati nella scheda di osservazione sono stati individuati attraverso lo studio dello sviluppo neuropsicomotorio del bambino in età prescolare, prestando particolare attenzione agli indicatori delle tappe evolutive delle aree: affettivo-relazionale, comunicativo-linguistica, motoria e cognitiva. Successivamente è avvenuto un confronto con i segnalatori dello sviluppo individuati dalla Scheda SoN, che ha portato alla selezione e all’ottenimento di una lista di competenze chiave da osservare in un bambino con ritardo globale dello sviluppo in età prescolare, quale può essere il bambino con Sindrome di Angelman. Gli item, inoltre, sono stati organizzati visivamente, evidenziandoli con colori diversi, nelle diverse aree dello sviluppo: affettivo-relazionale, nella scheda rappresentata dal colore rosso, comunicativo-linguistica, di colore giallo, motoria, di colore azzurro, e cognitiva, di colore verde, per favorire e facilitare l’osservazione e la sintesi del terapista.
Per la scelta, invece, del materiale da proporre è stata compiuta una ricerca in letteratura per poter somministrare degli oggetti che avessero valenza e significato all’interno del mondo scientifico e che potessero effettivamente determinare una risposta adattiva nel bambino. Sono stati, dunque, adattati dei materiali e dei giochi sulla base delle ricerche pregresse sulla sensorialità del bambino. Ogni target, difatti, presenta caratteristiche sensoriali specifiche e contrapposte. I materiali sono classificati in base a tre diverse categorie, dove per ogni sezione è presente lo stesso materiale adattato con sensorialità tattile, uditiva o visiva, in modo da uniformare forma e dimensione dei target e evitare, in questo modo, qualsiasi malinteso o dubbio sulla scelta dell’oggetto per altre caratteristiche intrinseche, ma basandosi, con una maggiore sicurezza, sulla predominanza delle caratteristiche sensoriali in ogni oggetto.
In particolare, le categorie di materiali proposte per l’utilizzo della scheda sono:
Le ventose (Figura 5) sono oggetti che permettono la sperimentazione della motricità fine e l’attivazione di schemi fino-motori quali girare e fermare, con prese e velocità differenti. Inoltre, appese allo specchio, possono essere fonte motivante per la localizzazione e il raggiungimento, attraverso la sperimentazione di differenti passaggi motori, da quelli orizzontali, come la postura prona, a quelli verticali, come il passaggio da seduto a in piedi, anche con il sostegno della parete di fronte. Le ventose, poi, presentano un’azione che si esaurisce e questo permette di attivare e richiedere risposte di tipo relazionale con l’adulto, in modo da ripetere l’azione, risultando in questo modo più motivante e più incisivo nell’apprendimento. È possibile quindi con questo tipo di materiale proporre schemi di imitazione, di turnazione e di attenzione condivisa, oltre che favorire l’emergente capacità di comprensione della causa-effetto.
Figura 5. Ventose adattate sensorialmente
Il riccio (Figura 6) è stato scelto per attivare principalmente schemi differenti di motricità fine come infilare, sfilare, mettere dentro e tirare fuori, battere con uno o più oggetti. Gli aculei del riccio permettono di sperimentare prese differenti e di controllare il movimento negli aspetti più di coordinazione oculo-manuale. Inoltre la struttura del gioco permette, anche in questo caso, la ripetizione dell’azione e dunque l’attivazione di risposte di richiesta di continuazione dell’attività. È un’attività che indaga meno la motricità grosso-motoria ma che si concentra maggiormente sulle capacità di scambio relazionale in un contesto più contenuto e diretto, in quanto la proposta viene effettuata attraverso una postura seduta che permette un maggiore contatto oculare e contribuisce a rallentare la frenesia di movimento, caratteristica della sindrome.
Figura 6. Il riccio sensoriale
- Le palline e lo scatolone (Figura 7) sono materiali che permettono, invece, in modo diretto risposte di adattabilità grosso-motoria per il raggiungimento, il lancio e il recupero. Permettono, inoltre, risposte di tipo relazionale attraverso semplici scambi dove entra in gioco la capacità di attesa, la turnazione, l’imitazione e l’attenzione condivisa. Sono state scelte palline di facile presa per consentire e facilitare la motricità fine e la manipolazione, aspetto carente e limitante nei bambini con Sindrome di Angelman. Lo scatolone, invece, permette di attuare situazioni di verifica della permanenza dell’oggetto, per attivare risposte di tipo cognitivo, e di semplici schemi di azione come mettere dentro e tirare fuori,
attraverso l’imitazione e la guida verbale.
Figura 7. Palline sensoriali con scatolone
Per ognuna di queste categorie sono presenti oggetti caratterizzati dalle diverse sensorialità, di tipo visivo, uditivo e tattile. I materiali sono stati adattati seguendo determinate evidenze presenti in letteratura, in quanto determinate tipologie di sensorialità permettono in modo più significativo di ricevere risposte adattive da parte del bambino e quindi sviluppare e sostenere il suo sviluppo neuropsicomotorio, come già ampiamente descritto nei capitoli precedenti. È stato scelto, quindi, di poter contribuire alla verifica degli elementi già presenti in letteratura presentando al bambino materiali dalle caratteristiche diverse e contrapposte per poter osservare direttamente le sue preferenze e le sue risposte adattive, in modo da poter descrivere, più accuratamente, il profilo sensoriale del bambino con Sindrome di Angelman all’interno della clinica neuropsicomotoria.
Per la sensorialità visiva i materiali adattati proposti sono stati:
Ventose con pattern bianco e nero e con volto stilizzato (Figura 8); In letteratura, è riportato la preferenza del bambino verso i pattern bianchi e neri (Fantz, 1958-1963), infatti sono i target più usati nell’ambito della riabilitazione del bambino ipovedente in quanto facilitano la percezione dell’oggetto. È stato quindi scelto di adattare 2 ventose con pattern bianchi e neri. Inoltre, secondo Shaffer, nel 1984, il neonato, fin dalla nascita, dimostra una predisposizione iniziale per la preferenza del volto umano, che va a stimolare l’attenzione selettiva. Il motivo di tale attrazione non è il realismo allo stimolo, tuttavia la presenza di caratteristiche intrinseche che lo contraddistinguono quali: la nitidezza dei contorni, la simmetria, il movimento e la complessità (Camaioni & Di Blasio, 2007). Lo stesso Fantz, nei suoi studi, ha dimostrato che il lattante osserva il volto per tempi maggiori rispetto ad altri input (Fantz, 1963). Per questo motivo, è stata adattata una ventosa, oltre ai pattern in bianco e nero, anche con un volto stilizzato che potesse riprendere le caratteristiche principali e la geometria del volto umano, in modo da attirare maggiormente l’attenzione del soggetto.
Figura 8. Ventose visive con pattern bianco e nero
Aculei con alto contrasto (Figura 9); nella riabilitazione del bambino ipovedente è utilizzato il forte contrasto, solitamente caratterizzato dal semplice bianco e nero, ma può essere anche con l’utilizzo di colori ad alta distinzione cromatica, come nel caso degli aculei del riccio adattati visivamente: arancioni e blu. Il bambino riesce maggiormente a percepirli e a distinguerli dall’ambiente circostante (Mercuri et al., 2005).
Figura 9. Riccio sensoriale: aculei visivi ad alto contrasto
- Pallina luminosa (Figura 10); la luce gioca un ruolo fondamentale negli aspetti di percezione visiva. Può essere uno stimolo molto accattivante e maggiormente motivante per il bambino, soprattutto se presentato con piccoli adattamenti del setting, come creare un ambiente semi-buio per far risaltare in modo ancora più evidente la presenza di una fonte luminosa e dunque attirare l’attenzione del bambino. Così è stato fatto per la pallina che abbiamo adattato per gli aspetti visivi. È stata costruita inserendo all’interno delle piccole luci colorate che si attivano quando la pallina colpisce il pavimento, così da favorire anche un’iniziale causalità dell’azione.
Figura 10. Pallina luminosa
Per la sensorialità uditiva i materiali adattati proposti sono stati:
Ventosa sonora e pallina sonora: target a bassa frequenza (Figura 11);
Figura 11. Ventosa e pallina sonora
Aculei con sonaglio: target ad alta frequenza (Figura 12);
Figura 12. Riccio sensoriale con aculei sonori
Sono stati scelti materiali con frequenze diverse in modo da poter indagare la preferenza del bambino con Sindrome di Angelman per quanto riguarda il canale uditivo. Gli oggetti rappresentano rispettivamente target a alta frequenza, circa 4450 Hz, e a bassa frequenza, 150 Hz, in modo da poterli confrontare poi nei risultati finali e poter definire se a provocare maggiori risposte adattive sono i suoni più forti o più deboli.
Come già ampiamente descritto precedentemente la stimolazione cutanea risulta primariamente importante per lo sviluppo neuropsicomotorio del bambino. Allo stesso tempo, tuttavia, pochi sono gli studi sulla sensorialità tattile e le sue diverse possibilità. È stato quindi scelto di analizzare questo tipo di sensorialità attraverso diversi input, con le stesse caratteristiche, in modo da ampliare la possibilità di poter analizzare la sua ampia varietà e il suo grande potenziale nello scaturire nel bambino nuove risposte adattive. Per cui, per la sensorialità tattile, i materiali adattati proposti sono stati:
Ventosa morbida, aculei con presa morbida, pallina morbida (Figura 13); sono presenti pochi studi in letteratura sull’evidenza di questa caratteristica tattile. Il feto e il neonato, tuttavia, sperimentano in prima linea la sensazione del morbido all’interno dell’utero materno e attraverso il contatto della pelle della madre nei primi momenti di vita, fondamentali per la base dell’attaccamento e della relazione con il caregiver. Inoltre, Harlow nel 1959, attraverso alcuni studi sui macachi, dimostra come quest’ultimi prediligessero un surrogato di madre dalle caratteristiche morbide, rivestita di spugna e stoffa, rispetto a una costituita da metallo (Harlow, 1959), sottolineando quindi una preferenza da parte del piccolo per le sensazioni di morbidezza e calore. Per questo motivo, sono stati adattati per ogni tipologia di target degli oggetti attraverso un rivestimento di spugna o stoffa morbida, che potessero far sperimentare al bambino questa sensazione tattile, in modo da analizzare questa caratteristica sensoriale in ogni proposta di target.
Figura 13. Materiali dalle caratteristiche sensoriali morbide
- Ventosa ruvida, aculei con presa ruvida, pallina ruvida (Figura 14); come per i target morbidi, anche per quelli con caratteristiche ruvide non sono presenti in letteratura particolari evidenze scientifiche. È stato ritenuto, tuttavia, opportuno poter far sperimentare anche questa sensazione al bambino, in modo da analizzare e poter osservare la possibile presenza di maggiori risposte adattive e poterle quindi comparare con quelle dei target morbidi. Sono stati, quindi, adattate tutte
le tipologie di target attraverso l’utilizzo di materiale ruvido come il velcro.
Figura 14. Materiali dalle caratteristiche sensoriali ruvide
Pallina calda (Figura 15); in letteratura il caldo è descritto come una caratteristica peculiare del piacere del bambino. Bakwin, uno dei primi pediatri a riconoscere l’importanza delle cure materne all’interno della pediatria ospedaliera, sottolinea l’importanza delle sensazioni cutanee, in particolare descrivendo il calore come caratteristica dall’effetto calmante per i bambini, associata a un senso di piacere (Montagu, 2015). È stato, dunque, scelto di adattare e presentare una pallina calda che potesse verificare quanto descritto in letteratura.
Figura 15. Pallina calda
- Pallina fredda (Figura 16); la sperimentazione degli stimoli freddi, secondo la letteratura, irritano e infastidiscono il bambino, descrivendo questa caratteristica sensoriale come poco piacevole (Montagu, 2015). Abbiamo, dunque, optato di modificare la stessa tipologia di target del caldo, presentando esattamente le stesse caratteristiche di forma, colore e dimensione, in modo da poter valutare quale target legato alla temperatura potesse presentare maggiori risposte motorie,
relazionali e cognitive.
Figura 16. Pallina fredda
I materiali scelti hanno lo scopo di poter stimolare il maggior numero di risposte adattive nel bambino in età prescolare con Sindrome di Angelman e per questo motivo, dunque, presentano caratteristiche differenti tra i vari target in modo da poter osservare come il bambino si relaziona ad essi, con l’obiettivo di individuare il canale sensoriale maggiormente coinvolto nella modifica del profilo neuropsicomotorio del bambino e le modalità migliori per poter proporre nuovi stimoli all’interno della seduta neuropsicomotoria e di riabilitazione.
5.6 Modalità di somministrazione della scheda
È importante per un terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva conoscere e maneggiare i modi dell’azione, descritti e sintetizzati dalle sette categorie psicomotorie o analogiche, che rappresentano: tono, postura e sguardo, spazio, tempo, oggetti, voce e movimento. Ogni qual volta si struttura un incontro, che sia di osservazione e valutazione o di riabilitazione, il terapista deve essere consapevole di queste sette categorie e deve saperle sfruttare e modificare a seconda del bambino che a lui si presenta (Savini, 2022). Per questo motivo, all’interno di un protocollo di osservazione è opportuno poter descrivere, in modo ampio e esaustivo, le modalità dell’azione affinché il terapista abbia una traccia da poter seguire per organizzare la seduta, il setting, i materiali e il ruolo da assumere all’interno della stessa, in relazione con il soggetto.
La scheda costruita e qui presentata riporta, nella sezione tra la tabella dei materiali e lo strumento effettivo di osservazione, ovvero la tabella degli item da compilare, una parte, denominata “SETTING E MODALITA’ DI PROPOSTA”, che descrive in modo dettagliato le modalità di somministrazione dei vari target e materiali. Il protocollo prevede una guida alla somministrazione in modo da rendere l’osservazione più sistematica e omogenea nella riproducibilità tra i terapisti e all’interno delle stesse sedute di osservazione e valutazione. Descrivere, dunque, i modi, i tempi e gli spazi di presentazione dei target e del setting della stanza di terapia permette e facilita l’organizzazione stessa della seduta e la sua costanza nel tempo, sostenendo in questo modo il terapista e ponendosi come traccia dei primi incontri con il bambino. Inoltre, come nel caso qui riportato, la possibilità di seguire delle indicazioni chiare e precise per fornire i determinati materiali consente di validare e agevolare i confronti costruttivi tra soggetti con la stessa età e la stessa sindrome, in modo da evidenziare somiglianze e differenze e poter avanzare ipotesi cliniche sul funzionamento stesso del singolo e della patologia.
Allo stesso tempo, tuttavia, le indicazioni riportate sulla modalità di somministrazione dei diversi target non risultano specifiche e definite in modo dettagliato come nei casi di test validati e portatori di significato quantitativo. Lo strumento di osservazione proposto ha lo scopo, come già espresso, di validare e facilitare il compito di osservazione del profilo sensoriale del bambino con sindrome di Angelman in età prescolare, attraverso un protocollo di origine e scopo qualitativo. Per questo motivo, dunque, le informazioni riportare nella sezione riguardanti le modalità di somministrazione permettono e lasciano al terapista molta libertà sui modi dell’azione e sull’utilizzo delle strategie neuropsicomotorie sulla base individuale di ogni singolo bambino, in modo da favorire le maggiori risposte adattive agli stimoli proposti. È, quindi, discrezione del terapista quella di comprendere e capire il soggetto con cui si relaziona e adattare le modalità e i propri comportamenti al fine di ottenere la best performance del bambino stesso, attuando la scheda per ricavarne vantaggio.
In questo modo, il risultato che si ottiene sarà una guida alla stesura di un’osservazione il più esaustiva e accurata possibile sul profilo sensoriale del bambino e sulle sue modalità di relazione con il mondo, evidenziando quali canali sensoriali permettono la maggiore attivazione del soggetto e promuovono, dunque, uno sviluppo neuropsicomotorio che preveda un possibile miglioramento all’interno di tutte le aree dello sviluppo.
L’osservazione strutturata, oltre a validare il lavoro del terapista, permette inoltre di essere punto di partenza per il confronto con i caregiver del bambino, ponendosi come strumento che riporta in modo sintetico e sistematico quello che il terapista osserva all’interno della sua seduta. Risulta fondamentale poter parlare con i genitori degli aspetti di sviluppo del proprio figlio, in quanto risultano i maggiori esperti della crescita e del cambiamento del loro bambino. Comprendere, quindi, e poi riferire alle figure di riferimento la predisposizione del bambino a un determinato stimolo o il mancato interesse verso un determinato target concede al genitore stesso di poter comprendere meglio il funzionamento comportamentale del figlio e potersi, quindi, adattare di conseguenza. La scheda, dunque, oltre a essere strumento utile per individuare strategie e obiettivi per il trattamento riabilitativo di questi bambini, permette al terapista di poter lavorare anche sul trattamento indiretto, in modo più sistematico e validato. Infatti, individuati i canali sensoriali maggiormente coinvolti, attraverso la scheda, il terapista riesce a indirizzare e consigliare ai genitori modalità e strategie personalizzate per il loro bambino. Il protocollo, poi, suggerisce e presenta già degli esempi di materiale adattato che può essere proposto ai caregiver come giochi da riproporre anche nella quotidianità e nella vita di tutti i giorni, anche se tuttavia numerose sono le proposte che si possono consigliare ai genitori per quanto riguarda gli aspetti sensoriali, potendo variare e adattare le indicazioni a seconda del bambino, dell’età e dello sviluppo neuropsicomotorio.
La Scheda di osservazione e valutazione del profilo sensoriale del bambino con Sindrome di Angelman, quindi, si dimostra uno strumento utile non solo per la sistematizzazione dell’osservazione diretta del terapista, ma può essere mezzo che facilita la stesura del progetto riabilitativo, attraverso obiettivi e strategie per il trattamento diretto all’interno della stanza di neuropsicomotricità e per il trattamento indiretto con i genitori, attraverso le indicazioni di proposte ludiche nella quotidianità che possono sostenere lo sviluppo in tutte le sue aree.
CAPITOLO 6: IL PROGETTO
6.1 La strutturazione degli incontri
Successiva alla fase di ricerca e stesura di un protocollo di osservazione che validasse il lavoro di tesi, è seguita la formulazione delle modalità di somministrazione della scheda all’interno delle sedute neuropsicomotorie e l’applicazione della stessa, atta alla stesura di un progetto riabilitativo diretto e indiretto, con i caregiver.
L’intervento è stato strutturato attraverso 5 incontri dedicati all’osservazione e valutazione del bambino, tutti avvenuti in un setting neuropsicomotorio. Le sedute del progetto sono state in questo modo suddivise:
Seduta 1: primo incontro con la famiglia e presentazione del progetto
La terapista accoglie la famiglia all’interno della stanza neuropsicomotoria. Il primo incontro è dedicato alla conoscenza e alla presentazione del progetto. È la prima volta che la terapista vede il bambino e parla con la famiglia. Inizialmente, la terapista pone domande ai caregiver sullo sviluppo neuropsicomotorio del bambino e sulla sua storia clinica, chiedendo quali proposte riabilitative sono attivate nel territorio e in che modalità, in modo da poter collocare il soggetto all’interno di una cornice più ampia e conoscerne meglio il funzionamento. Successivamente avviene un confronto con i genitori sulle modalità di relazione tra quest’ultimi e loro figlio e sulla gestione della quotidianità, indagando sulle criticità e i punti di forza del bambino, in modo da poter indagare la consapevolezza dei genitori riguardo alla patologia e alle difficoltà del figlio. Infine, all’interno del colloquio di conoscenza, si esplorano gli aspetti sensoriali, chiedendo a genitori se ci sia una preferenza, una fascinazione o un evitamento di particolari stimoli o input sensoriali. Il tutto viene registrato e riportato, per punti rilevanti, nella prima parte della scheda di osservazione. La seduta si conclude esponendo il progetto ai genitori, attraverso la spiegazione di obiettivi, modalità e possibilità poi all’interno dell’intervento riabilitativo del bambino stesso. In questa prima seduta, rimane centrale la figura del genitore e le informazioni da lui riportate, il bambino, invece, per tutti i casi sempre presente in stanza, non viene coinvolto in particolari attività, ma lasciato libero di esplorare l’ambiente in sicurezza se attivo o lasciato tranquillo se dorme.
Seduta 2,3 e 4: somministrazione della Scheda di osservazione e valutazione del bambino con Sindrome di Angelman e confronto con i caregiver
Le sedute centrali del progetto hanno come obiettivo la somministrazione effettiva del materiale e l’osservazione del comportamento adattivo del bambino. In questi incontri il genitore rimane fuori alla stanza e il bambino rimane solo con la terapista. Vengono, quindi, proposti i diversi materiali seguendo le modalità descritte nella scheda e vengono ricavati i dati osservativi per poter poi compilarla e completare la relazione di osservazione. I diversi materiali all’interno delle sedute sono stati proposti seguendo i tempi dei diversi bambini e adattandosi alle loro necessità. È importante dedicare tre incontri all’osservazione, in modo da non giungere a conclusioni affrettate, ma prendendosi il tempo necessario per poter comprendere nel modo più ampio possibile il comportamento effettivo del bambino e le sue risposte adattive in relazione al mondo. Al termine di ogni incontro, vengono dedicati i minuti finali alla restituzione ai genitori su quanto appena osservato in stanza, in modo da poter costruire una relazione di dialogo e confronto con i caregiver. Nel quarto incontro, invece, si occupa un tempo maggiore alla restituzione con i genitori, facendoli entrare gli ultimi 15 minuti nel setting riabilitativo, in modo da poter rendere un’osservazione completa dell’intero progetto e una sintesi di quanto osservato nel setting neuropsicomotorio. La restituzione è un momento importante per il terapista e i genitori, in quanto, è un momento di scambio e di confronto di strategie e modalità da poter attuare nella quotidianità, vengono, infatti, consigliati giochi personalizzati, in base alle competenze del bambino, e adattati, in modo da sostenere le risposte adattive emergenti, e vengono, inoltre, mostrate e descritte modalità di relazione con il bambino e strategie utili per il suo funzionamento, dando esempi pratici e mostrando i materiali usati in stanza. Questa alleanza tra genitore e terapista permette una generalizzazione delle competenze e un apprendimento maggiormente incisivo.
Seduta 5: stesura dell’osservazione neuropsicomotoria e individuazione degli obiettivi e delle strategie di intervento
L’ultima seduta del progetto viene dedicata alla compilazione della scheda e alla stesura del progetto riabilitativo del bambino. Attraverso i dati e le osservazioni raccolte durante gli incontri precedenti, la terapista può sintetizzare l’osservazione attraverso lo strumento proposto e individuare, in questo modo, i canali sensoriali che emergono in modo più evidente all’interno delle sedute. Questo le permette di poter identificare in modo più facile e schematico i punti chiave del funzionamento sensoriale e adattivo del bambino e, dunque, le modalità d’azione atte per sostenerlo. Infatti, una volta completata la compilazione della scheda, la terapista dedica del tempo alla stesura di una descrizione di quanto osservato, mettendo in luce i punti di forza e di debolezza del bambino e le sue modalità di interazione con il mondo. La sintesi dell’osservazione permette poi di poter stilare un progetto riabilitativo individuale per il bambino, dove compito della terapista è quello di individuare gli obiettivi del trattamento diretto e indiretto e le strategie attraverso le quali raggiungerli. In questo modo viene scritta la relazione di osservazione e valutazione che verrà poi inviata al territorio di appartenenza di ogni bambino, in modo da poter sostenere le terapiste che hanno in carico il bambino e poterle indirizzare verso nuove proposte e modalità di interazione. Il progetto riabilitativo viene condiviso anche con i genitori durante la restituzione finale di ricovero con il medico.
6.2 Il campione
Il progetto è stato svolto dal mese di Maggio al mese di Ottobre 2023 presso l’IRCCS della Nostra Famiglia di Conegliano (TV). La struttura offre ricoveri a bambini e alle loro famiglie, provenienti da tutta Italia, per poter svolgere un’osservazione e una valutazione completa multidisciplinare del bambino. La famiglia soggiorna nella struttura per un tempo limitato, in modo da attuare una valutazione globale del bambino e della sua condizione attuale. Il bambino viene, infatti, dimesso poi con una relazione scritta dai professionisti del servizio contenente la sintesi delle diverse osservazioni e del progetto riabilitativo proposto, composto da obiettivi e strategie su tutte le aree dello sviluppo. La relazione, consegnata ai genitori, diventa canale di comunicazione con il servizio territoriale che ha in carico il bambino e con il quale è possibile condividere le modalità d’azione e d’intervento.
Hanno partecipato al progetto cinque bambini con le loro famiglie. Il campione era distribuito in questo modo: composto da tre femmine e due maschi, tutti in età prescolare, dunque di età compresa tra i due e i cinque anni, in particolare due soggetti presentano due anni, un soggetto quasi quattro anni, un altro riporta quattro anni e l’ultimo ha cinque anni. Del campione presente, tutti i casi sono stati in ricovero all’interno della struttura per un tempo compreso tra una e due settimane di permanenza. Un solo caso proveniva dal territorio circostante alla struttura, mentre tutti gli altri giungevano da regioni differenti. Alcuni bambini, con le loro famiglie, avevano già fatto uno o più accessi presso il servizio di Conegliano, in quanto inseriti all’interno di un programma di controllo per cui vengono nella struttura in ricovero una volta ogni sei mesi o una volta all’anno per essere monitorati nel tempo e nello sviluppo; questo è il caso dei tre bambini con età maggiore. Invece entrambi i casi che riportano due anni d’età erano al loro primo accesso in struttura e dunque conoscevano per la prima volta la realtà del servizio e delle proposte. Per tutti i bambini inseriti nel progetto è stato dato il consenso di trattamento dei dati da parte di tutte le figure esercenti la responsabilità genitoriale.
I criteri di inclusione per strutturare il campione sono stati: la diagnosi di Sindrome di Angelman, l’età che rientrasse all’interno della fascia prescolare e la possibilità di strutturare cinque incontri con il bambino e la sua famiglia. Parlando di una sindrome rara sono stati pochi i criteri di inclusione e esclusione perché il campione su cui poter fare riferimento era già limitato.
6.3 I casi clinici
Di seguito vengono riportate le descrizioni dei casi osservati durante il tirocinio per la stesura del progetto. Per ogni bambino viene riferita brevemente la storia clinica e anamnestica, la sintesi dell’osservazione neuropsicomotoria, svolta tramite la scheda di osservazione proposta, e alcune indicazioni su strategie e modalità d’intervento rivolte alla famiglia e al servizio territoriale che ha in carico ogni bambino.
NINA
Data di nascita: 07/2021
Data dell’osservazione: luglio 2023
Età al momento dell’osservazione: 24 mesi
STORIA CLINICA E ANAMNESTICA
Gravidanza normodecorsa. Parto indotto a 36+4 SG per rottura prematura delle membrane amnio-coriali. Alla nascita: peso 2920 g (60°) lunghezza 48 cm (50°), C.C. 32cm (40°) e Indice di Apgar 9-9. Nel primo mese di vita rigurgiti frequenti e difficoltà di regolazione sonno-veglia, successivamente sonno regolare. Nell’ultimo anno riferito sonno notturno, nuovamente, disturbato con irrequietezza motoria, assume quindi melatonina ma con scarso beneficio.
Sviluppo neuropsicomotorio: posizione seduta raggiunta a 8 mesi e gattonamento a 9-10 mesi. Ora ha iniziato a raggiungere la stazione eretta con il supporto degli arti superiori. Trai i 13 e 15 mesi viene riferito che produceva alcune sillabe in modo contestuale, tale capacità, tuttavia, è apparentemente regredita a partire da fine 2022. Presenti, inoltre, alcune stereotipie motorie e scialorrea.
I genitori riportano che negli ultimi tre mesi in 5-6 occasioni Nina ha presentato, in apparente benessere, episodi isolati o in cluster caratterizzati da midriasi, movimenti lenti del capo da un lato all’altro, automatismi oro-alimentari, aresponsività, della durata di pochi secondi. I risultati del Video EEG, svolti in struttura di ricovero, riportano: diffuso rallentamento dell’attività elettrica cerebrale, anomali lente ed epilettiformi sulle regioni posteriori dei due emisferi e a tratti presenti mioclono ritmico distale degli arti superiori. È stato, inoltre, registrato un cluster di manifestazioni critiche focali per cui è stato somministrato, e mantenuto come terapia continuativa, il Rivotril.
Nina vive con i genitori, un fratello minore, nato nel 2022, e un fratello maggiore di 7 anni in salute e frequenta il nido. La bambina è seguita presso il servizio territoriale dall’età di 13 mesi, dove inizialmente ha effettuato neuropsicomotricità e fisioterapia, ma attualmente svolge una volta a settimana solamente neuropsicomotricità.
OSSERVAZIONE NEUROPSICOMOTORIA
La bambina accede al setting accompagnata da entrambi i genitori, dai quali si separa serenamente. il ricongiungimento avviene con entusiasmo e ricerca del contatto fisico, manifestato dall’allungamento degli AASS verso di loro.
All’interno del setting Nina appare serena e curiosa, esplora spontaneamente l’ambiente circostante con atteggiamento caotico, interesse maggiore per la sperimentazione corporea a tappeto e fatica a soffermarsi sui diversi oggetti.
Nina ha appreso tutti i passaggi posturali in autonomia fino alla stazione eretta, che effettua con aiuto degli AASS in appoggio frontale. Per raggiungerla passa attraverso la posizione di cavalier servente, preferendo il carico a sinistra. In stazione eretta, si osservano arti inferiori abdotti, ginocchia ipertese, appoggio dei piedi in eversione e pronazione con griffe delle dita, Nina riesce a mantenere la posizione anche staccando una mano per afferrare un oggetto. Si sposta attraverso spostamenti orizzontali, quali il gattonamento, dove è presente lo schema crociato degli arti. Il movimento di Nina è caotico e veloce e risulta difficile organizzare il suo orientamento all’interno del setting neuropsicomotorio; tuttavia con la presenza di target dalle caratteristiche calde, ruvide e sonore, la bambina è stata capace di orientare il movimento e raggiungere i target attraverso la promozione di passaggi posturali, atti a prolungare e favorire la stazione eretta e quindi il carico sugli AAII. Inoltre, sono stati stimoli importanti per promuovere i primi passi in navigazione costiera, se pur ancora molto difficoltosa.
L’esplorazione appare ancora prevalentemente di carattere oro-buccale, con breve monitoraggio visivo dell’azione, la quale risulta spesso disinvestita della sua principale funzione conoscitiva. In presenza di target dalle caratteristiche sensoriali accattivanti per Nina, ovvero oggetti ruvidi, caldi o dai suoni forti, si nota la possibilità di attivare schemi manipolatori spontanei limitati al battere, schiacciare, ruotare, tirare, in cui l’aggancio visivo appare più costante e i tempi attentivi più duraturi. Su guida dell’adulto risulta possibile ampliare le modalità esplorative, aiutando la bambina a mettere dentro, aprire/chiudere, girare, battere tra loro, disincentivando l’atteggiamento di portare alla bocca i target. Nina appare incuriosita dall’attivazione delle conseguenze semplici, come ruotare per vedere girare la ventosa, per cui si osserva iniziale attivazione motoria spontanea volta a ripetere l’azione e condividere l’attenzione con l’adulto, soprattutto se i materiali proposti hanno caratteristiche ruvide, calde e sonore. È possibile l’iniziale passaggio degli oggetti da una mano all’altra e l’integrazione bimanuale, seppur da sostenere.
Nella cornice ludica, Nina mostra interesse verso gli stimoli sociali, con spontanei sorrisi, risa e possibilità di agganciare visivamente lo sguardo, seppur poco sostenuto. Appare possibile coinvolgere la piccola in dinamiche relazionali tramite giochi sensopercettivi e di scambio tonico-relazionale, capaci di favorire la modulazione tonica in rapporto all’altro ed instaurare momenti di attenzione congiunta.
L’attenzione alle diverse parti del corpo risulta da sostenere tramite proposte sensoriali, denominando le diverse zone corporee mentre entrano a contatto con le diverse superfici sensoriali. Nina si mostra interessata alla propria immagine riflessa allo specchio con tentativi di dare baci e interagire.
I tempi di permanenza e di attenzione risultano tendenzialmente ridotti; si coglie infatti instabilità e labilità attentiva, aspetti modificabili in presenza di target sensoriali specifici, come suoni molto forti, oggetti ruvidi e caldi, e all’interno di dinamiche senso-percettive.
Per quanto concerne gli aspetti affettivo-relazionali, Nina appare disponibile allo scambio con l’operatore, spontaneamente ricerca il contatto corporeo dell’adulto e instaura con lui brevi momenti di attenzione reciproca. La bambina presenta un atteggiamento di ascolto e interesse verso le proposte vocali e sonore e appare sensibile alle variazioni dell’espressività mimica e della prosodia dell’adulto, seppur non sufficiente a favorire un’imitazione delle stesse. L’intenzionalità comunicativa appare da sostenere; anche se in contesti altamente motivanti si osservano emergenti vocalizzi modulati e contatto di sguardo con finalità richiestive, come richiedere la ripetizione di azioni di target sensoriali.
Complessivamente, la bambina ha presentato un temperamento solare e disponibile all’interazione con il contesto e con l’altra persona; manifesta un buon adeguamento al setting e possibile coinvolgimento al contesto ludico interattivo, attraverso i materiali sensoriali, con particolare attenzione per quelli con caratteristiche tattili e dai suoni forti.
INDICAZIONI ALLA FAMIGLIA E AL SERVIZIO TERRITORIALE
Alla luce dell’osservazione del comportamento spontaneo di Nina, si consiglia di continuare la presa in carico neuropsicomotoria volta a sostenere il suo sviluppo globale, con particolare attenzione ai seguenti aspetti:
- Favorire la variazione degli schemi d’azione sull’oggetto tramite la guida fisica ed imitativa dell’adulto; proporre oggetti dalle caratteristiche sensoriali specifiche, canale sonoro-tattile, capaci di attivare una maggiore spontaneità motoria della bambina e di sostenere l’interesse, l’attenzione ed un monitoraggio visivo più costante. Si possono utilizzare anche oggetti adattati dalla facile prensione per sostenere l’integrazione bimanuale e il passaggio da una mano all’altra.
- Sostenere l’attenzione alle diverse parti del corpo ed una maggiore consapevolezza corporea tramite massaggi diretti ed indiretti alle diverse zone con oggetti sensoriali diversificati, prestando attenzione a denominare le parti ce entrano in contatto con le varie superfici.
- Sostenere la curiosità per l’osservazione delle conseguenze semplici delle proprie azioni e la spontaneità nell’attivazione del gesto motorio, tramite semplici proposte di causa-azione, come pulsanti sonori, ventose, tamburo sonoro
- Sostenere i tempi attentivi sul gioco, tramite la cura dell’ambiente e le proposte di gioco da inserire nel setting, ridurre le interferenze visive e sonore e limitare lo spazio di gioco, rendendolo accogliente ma selezionato.
- Sostenere la spontanea attivazione tramite vocalizzi e contatto di sguardo nella richiesta di ripetere azioni piacevoli esperite e la condivisione dell’attenzione con l’adulto. Interrompere l’attività ed attendere un segnale comunicativo di Nina prima di avviare la sequenza di gioco risulta una strategia importante per sollecitare l’intenzionalità comunicativa. Utilizzare target facilmente esauribili come ventose, bolle, pulsanti sonori.
- Anticipare verbalmente le diverse routine che si susseguono nella giornata, in modo da dare prevedibilità alle attività della vita quotidiana e sostenere la comprensione verbale delle stesse.
GABRIEL
Data di nascita: 08/2021
Data dell’osservazione: settembre 2023
Età al momento dell’osservazione: 25 mesi
STORIA CLINICA E ANAMNESTICA
Gabriel nasce primogenito a termine (39+4 s.g.) da TC urgente per rottura del sacco e mancato avvio di travaglio. L’Indice di Apgar è di 7-8, con Peso di 3620g e Lunghezza di 49cm. Alla nascita segue un periodo di osservazione in patologia neonatale per sospetta ingestione di meconio. Nel primo mese di vita sono frequenti irritabilità e pianti frequenti. L’alimentazione è stata avviata con allattamento con latte artificiale e dai primi mesi di vita esordisce un disturbo del sonno, che attualmente è controllato dall’assunzione di melatonina.
Sviluppo psicomotorio: è determinato, nel primo anno di vita, da un ritardo delle acquisizioni posturo-motorie, con ridotta iniziativa motoria e tendenza a rilasciare bruscamente gli oggetti non appena li toccava. Presenti inoltre movimenti di tipo a “scatto”. Posizione seduta acquisita dai 10 mesi. Si sposta a carponi (poggiando sui gomiti) dai 20 mesi e verticalizza con supporto da qualche mese. Presenta, inoltre, astigmatismo e ipermetropia.
L’EEG effettuato in ricovero ha portato come risultato “ridotta organizzazione attività elettrica; anomalie lente ed epilettiformi centro-posteriori bilaterali, accentuate dalla sonnolenza dove si organizzano in brevi scariche diffuse”. Durante il pernottamento, tuttavia, in struttura Gabriel presenta un episodio critico in sonno caratterizzato da apertura degli occhi, sguardo fisso e orientato verso l’alto e a sinistra, alterazione del respiro, aresponsività allo stimolo e evoluzione tonico-clonica. Interrotto farmacologicamente dopo 5 minuti.
Gabriel frequenta il nido con una figura di sostegno alla classe e è previsto da quest’anno l’inserimento di una figura per la CAA. Gabriel è in carico al servizio territoriale dall’età di 9 mesi e segue un trattamento nei setting di logopedia, neuro-psicomotricità e fisioterapia, per un totale di 6 sedute a settimana.
OSSERVAZIONE NEUROPSICOMOTORIA
Il bambino accede al setting accompagnata da entrambi i genitori, dai quali si separa serenamente. Il ricongiungimento avviene con entusiasmo e ricerca della figura genitoriale.
All’interno del setting Gabriel appare sereno e curioso, esplora spontaneamente l’ambiente circostante tramite spostamenti prelocomotori come striscio o gattono; tramite il sostegno dell’adulto è possibile promuovere l’avvio dei primi passi. Si osserva maggior interesse per la sperimentazione corporea a tappeto e lentezza nel raggiungere elementi distanti dal proprio spazio peripersonale, con facile distraibilità e predilezione per materiali più facilmente raggiungibili. Gli oggetti dalle caratteristiche sonore, tuttavia, sono risultati maggiormente accattivanti ed utili per promuovere spostamenti finalizzati e spontanei sia a carattere prelocomotorio che locomotorio con sostegno dell’adulto ed il raggiungimento della verticalizzazione. Per quanto concerne gli aspetti di motricità globale, questa risulta maggiormente disorganizzata e caotica con impaccio psicomotorio, positivamente modificabile su guida dell’adulto: Gabriel su richiesta dell’adulto si porta seduto per avviare dinamiche ludiche. Osservata fatica nell’eseguire la verticalizzazione; la posizione eretta viene brevemente mantenuta con base allargata, piedi in extrarotazione (dx>sx) ed instabilità motoria con successiva iperestensione del tronco e ritorno in posizione seduta con caduta sui glutei. La posizione seduta a tappeto appare mantenuta con bacino in retroversione e appoggio sacrale; si osserva tendenza a portarsi supino.
L’esplorazione dei materiali proposti avviene spontaneamente e con ridotti schemi d’azione sugli oggetti; l’afferramento avviene con movimenti distali poco fluidi, migliori in presenza di materiali dalla facile prensione. Si osserva possibilità di manipolare e scuotere gli oggetti per sentirne il rumore e le diverse consistenze, possibile l’azione del togliere con presa palmare e pluridigitale. Su guida fisica dell’adulto, Gabriel co-partecipa al movimento di tirare con possibile integrazione bimanuale, mettere dentro e infilare. Durante queste azioni si riporta difficoltà nella coordinazione oculo-manuale e ridotto monitoraggio visivo dell’azione, migliore in presenza di oggetti tattili: ruvidi e morbidi. Presente seppur non invalidante l’esplorazione oro-buccale dei materiali, maggiore in presenza di oggetti morbidi (gommosi). Difficilmente osservato il trattenere due oggetti contemporaneamente, al contrario non rilevato il passaggio da una mano all’altra e l’integrazione bimanuale. Scarsamente possibile avviare schemi d’azione su imitazione dell’adulto, seppur sostenuti. Possibile avviare inziali scambi con la palla, in cui sollecitare Gabriel ad attenderne il ritorno, la compliance maggiore avviene con la palla sonora.
L’attenzione alle diverse parti del corpo risulta da sostenere tramite proposte sensoriali, denominando le diverse aree corporee. Gabriel si mostra interessato alla propria immagine riflessa allo specchio. Presente partecipazione passiva al momento di infilare e sfilare le scarpe, con sostegno fisico dell’adulto che lo guida nel gesto motorio.
I tempi di permanenza e di attenzione risultano tendenzialmente ridotti; si coglie infatti instabilità e labilità attentiva, aspetti modificabili in presenza di target sensoriali specifici, quali oggetti sonori, morbidi e caldi, e all’interno di dinamiche sensopercettive.
Per quanto concerne gli aspetti affettivo-relazionali e comunicativi, Gabriel appare disponibile allo scambio con l’operatore, spontaneamente ricerca il contatto corporeo dell’adulto e instaura con lui brevi momenti di attenzione reciproca. Il contatto oculare appare agganciabile, seppur labile, e la triangolazione di sguardo possibile ma da incentivare. In presenza di oggetti particolarmente motivanti, come le ventose sonore e tattili, si osserva la ricerca dell’adulto per condividere l’attenzione e l’emozione sul target. Presente il sorriso sociale e le risa in relazione al contesto. Dimostra piacere verso giochi relazionali e sensopercettivi, capaci di favorire una modulazione tonica in rapporto all’altro ed instaurare momenti di attenzione congiunta e richiesta di ripetere l’azione tramite aggancio oculare, vocalizzi ed uso protesico dell’adulto. Gabriel mostra una buona intenzionalità comunicativa volta a condividere l’emozione e l’attenzione ed avanzare richieste: tramite l’uso protesico dell’adulto, richiede l’aiuto dell’adulto per avviare azioni maggiormente gradite o promuoverne il raggiungimento. Tutti questi aspetti risultano da sostenere in un setting selezionato e ben delimitato e con materiali sensoriali, preferibilmente sonoro-tattili.
Complessivamente, il bambino ha presentato un temperamento solare e disponibile all’interazione con il contesto e con l’altra persona; manifesta un buon adeguamento al setting, possibile coinvolgimento al contesto ludico interattivo e interesse per i materiali sensoriali, con particolare attenzione per quelli dalle caratteristiche tattili e dai suoni deboli.
INDICAZIONI ALLA FAMIGLIA E AL SERVIZIO TERRITORIALE
Dall’osservazione dello sviluppo adattivo e spontaneo di Gabriel emerso nel setting neuropsicomotorio si consiglia di proseguire le diverse prese in carico avviate. In particolar modo:
- Consolidare gli scambi affettivo-relazionali e la spontanea intenzionalità comunicativa del piccolo. Promuovere la spontanea ricerca dell’adulto, il contatto oculare e la triangolazione di sguardo, il sorriso sociale e sostenere l’imitazione dell’altro sia a livello mimico che gestuale. Sostenere maggiori tempi di attenzione congiunta e condivisa, la presenza di vocalizzi e l’uso protesico dell’adulto come modalità per richiedere il suo aiuto, dando un rimando verbale del gesto compiuto (“mamma aiuto”).
- Promuovere lo sviluppo della permanenza dell’oggetto e sostenere l’acquisizione della causalità diretta tramite l’avvio di attività ludiche semplici quali torre, pianola, migliori se danno un rimando sonoro o tattile al bambino.
- Sostenere gli aspetti di motricità fine, lo sviluppo della presa a pinza superiore ed inferiore e l’acquisizione di spontanei schemi d’azione quali mettere dentro, battere, attaccare/staccare, ruotare. Promuovere la coordinazione oculo-manuale ed il monitoraggio visivo costante dell’azione tramite la proposta di oggetti adattati a livello tattile, morbidi, ruvidi, vibranti, in cui guidare Gabriel al completamento dell’azione.
- Favorire l’ampliamento dei tempi attentivi sul gioco tramite l’utilizzo di materiali sonoro-tattili risultati particolarmente motivanti per Gabriel e attraverso l’organizzazione e strutturazione del setting; proposte ben selezionate e cadenzate, risultano ottimali strategie volte al supporto dei tempi attentivi e di attesa.
- Sostenere la consapevolezza corporea, tramite massaggi diretti ed indiretti con materiale dalle diverse sensorialità e favorire una co-partecipazione alle azioni di svestizione e vestizione.
AURORA
Data di nascita: 09/2019
Data dell’osservazione: luglio 2023
Età al momento dell’osservazione: 3 anni e 10 mesi
STORIA CLINICA E ANAMNESTICA
Aurora è unicogenita e nata, con parto eutocico, a 40 s.g. Alla nascita presentava un peso di 2786g e una CC di 33.5 cm (25-40°p). Il decorso alla perinatalità è stato fisiologico salvo ittero, per la quale è stata trattata. Ha presentato difficoltà di suzione al seno e per questo dopo poche settimane è stato introdotto il latte artificiale; dai 9 mesi tuttavia rifiuta il biberon e accetta solamente di essere alimentata con l’uso del cucchiaino, svezzamento avviato a 7 mesi, caratterizzato da conati di vomito per consistenze miste. Difficoltà di addormentamento, ora ritmo sonno-veglia regolare con assunzione di melatonina.
Sviluppo psicomotorio: Aurora raggiunge il rotolo a 8 mesi e la postura seduta a 11 mesi, lo spostamento funzionale in stazione eretta, invece, viene acquisito all’età di 2 anni e 8 mesi. Le prime parole sono comparse all’età di 2 anni e 6 mesi, anche se continua a comunicare attraverso lallazioni modulate.
I genitori riportano episodi di assenza e ammiccamento palpebrale, più frequenti alla sera, con frequenza plurisettimanale e dalla durata di qualche secondo. Il tracciato dell’esame EEG è, infatti, caratterizzato da un diffuso rallentamento dell’attività elettrica in rapporto all’età, con anomalie epilettiformi a prevalenza posteriore, talora anche indipendenti sulle regioni anteriori,
Aurora vive con i suoi genitori e ha frequentato il primo anno di scuola dell’infanzia con sostegno. Svolge 2 sedute di neuropsicomotricità e uno di logopedia a settimana.
OSSERVAZIONE NEUROPSICOMOTORIA
Aurora accede al setting neuropsicomotorio accompagnata dai genitori, dai quali si separa e si ricongiunge serenamente.
La bambina all’interno della stanza neuropsicomotoria ha un atteggiamento caratterizzato da una frenesia motoria e un movimento caotico e instabile. Aurora esplora l’ambiente, cerca e manipola oggetti di suo interesse, attraverso un cammino instabile, accelerato, a base allargata e a guardia alta, dimostrando difficoltà di equilibrio. Accede a tutti i passaggi posturali, anche se con difficoltà motoria. In stazione eretta tende a stazionare senza presentare l’appoggio dell’intera pianta del piede ma presentando un atteggiamento in equino, senza i tutori; con le scarpe e i tutori AFO gamba-piede, la sicurezza e la stabilità tendono a migliorare, seppur in maniera minima. È presente ancora in alcune situazioni l’interesse a cercare un contatto globale con le diverse superfici, adottando, dunque, una postura orizzontale.
La modalità di esplorazione dei target è prevalentemente orale, spesso disinvestita del suo valore conoscitivo, tuttavia risulta un atteggiamento riducibile in presenza di target in movimento sonori e tattili, specialmente dalle caratteristiche ruvide. Si possono osservare schemi motori d’azione semplici come tirare fuori, premere, scuotere, tirare; sono azioni che vengono sostenute dalla presenza di target di interesse, quali oggetti sonori e ruvidi, e ampliabili attraverso il prompt fisico dell’adulto con possibilità di mettere dentro, battere tra loro, avvitare e svitare, girare. Per quanto riguarda la motricità fine, Aurora presenta una presa palmare-pluridigitale, presentando difficoltà di preadattamento al materiale e di movimento selettivo delle dita. Presenta, tuttavia, la possibilità di trattenere due oggetti e l’integrazione bimanuale, seppur da sostenere.
È sviluppata e presente la permanenza dell’oggetto, risulta, invece, da sostenere e promuovere la comprensione della casualità diretta, che viene maggiormente attivata dalle dinamiche con target esauribili e ripetitivi dalle caratteristiche sonore e ruvide.
I tempi attentivi si dimostrano molto labili e non sufficienti per avviare dinamiche di scambio, infatti Aurora tende a shiftare spesso da un’attività all’altra esaurendo in tempi molto brevi la conoscenza dell’oggetto con cui entra in relazione. Questo comporta un atteggiamento caotico e costantemente di ricerca all’interno del setting neuropsicomotorio, dove risulta difficile fermare la bambina e proporre sequenze più lunghe, visti i scarsi tempi d’attesa e di permanenza. Tuttavia, in presenza di un setting contenuto e di target adattati sensorialmente, dalle caratteristiche sonore e tattili ruvide e morbide, è possibile osservare un mantenimento dell’attenzione più duraturo, con possibile completamento dell’attività richiesta e variazione delle modalità d’azione.
Nell’area affettivo-relazionale, la bambina appare disponibile all’interazione con l’altro, attraverso la presenza di sorrisi sociali, triangolazione dello sguardo, sguardo referenziale, attenzione congiunta e condivisa, anche se risultano tutti aspetti da sostenere e promuovere all’interno del setting; risulta infatti difficile proporre scambi relazionali come “Dammi” o sostenere lo sguardo della bambina.
Per quanto concerne gli aspetti comunicativo-linguistici, Aurora mostra un’intenzionalità comunicativa ridotta e limitata nella richiesta di determinate azioni; viene manifestata attraverso lo sguardo e la variazione della mimica espressiva, seppur ridotta e caratterizzata dalla prevalenza di sorrisi e risa immotivate. Aurora comunica verbalmente attraverso alcuni vocalizzi modulati e qualche semplice lallazione, queste aumentano in risposta ad attività maggiormente gradite come con i target dalle caratteristiche sensoriali sonore e tattili. La comprensione risulta inficiata e legata strettamente al contesto, attraverso l’uso di poche e semplici parole.
La percezione e la consapevolezza corporea appaiono immature. Aurora non collabora nei momenti di vestizione e svestizione, tuttavia appare attenta alle diverse parti del corpo se stimolare da diverse superfici, in particolar modo dalle caratteristiche ruvide e calde; in questi momenti Aurora riesce a fermarsi e a seguire con lo sguardo l’oggetto che entra in contatto con il suo corpo, porgendo poi spontaneamente un arto alla volta e dimostrando il suo piacere attraverso vocalizzi e triangolazione di sguardi.
INDICAZIONI ALLA FAMIGLIA E AL SERVIZIO TERRITORIALE
Dopo l’osservazione fatta in setting neuropsicomotorio, si consiglia di continuare la presa in carico nel servizio territoriale, consigliando ai terapisti e alla famiglia le seguenti indicazioni e strategie:
- Sostenere lo sviluppo di nuovi schemi d’azione, attraverso la proposta di materiali dalle dimensioni diverse e dalle caratteristiche sensoriali, preferibilmente adattate per il canale sonoro e tattile, che possano suggerire modalità diverse e nuove di approccio e azione. Sostenere la bambina alla scoperta di possibili schemi d’azione differenti attraverso il prompt fisico, verbale e l’imitazione.
- Favorire attività e giochi di casualità diretta, come pulsanti sonori, ventose adattate sensorialmente, torre, strumenti musicali
- Promuovere l’ampliamento dei tempi attentivi sulle attività, strutturando un setting pulito, limitato e chiaro e proponendo attività fortemente motivanti e gratificanti per la bambina, come proposte di tipo sonoro e musicale.
- Sostenere gli aspetti relazionali, come lo sguardo, la triangolazione e l’attenzione condivisa ponendosi come partner di gioco della bambina.
- Aumentare l’intenzionalità comunicativa, attraverso la proposta di attività ludiche esauribili e ripetitive, come le ventose, le bolle, i pulsanti sonori, in modo da aspettare una richiesta da parte della bambina per poter ripetere l’azione.
- Sostenere la produzione e la comprensione linguistica, tramite un linguaggio chiaro, semplice, positivo e legato al contesto, la denominazione delle azioni e degli oggetti che la bambina usa, la modulazione della voce e la lettura di libri sonori.
- Favorire la percezione e lo schema corporeo, proponendo massaggi diretti e indiretti, con target sensoriali dalle caratteristiche ruvide e calde, denominando le diverse parti del copro che entrano in contatto con l’oggetto.
BENEDETTA
Data di nascita: 05/2019
Data dell’osservazione: luglio 2023
Età al momento dell’osservazione: 4 anni e 2 mesi
STORIA CLINICA E ANAMNESTICA
Gravidanza normodecorsa. Parto spontaneo a 37+5 SG; perinatalità nella norma. Allattamento con latte materno fino al secondo mese di vita, poi con latte artificiale. Svezzamento decorso con difficoltà: la bimba avrebbe assunto esclusivamente latte e frutta fino ai 12 mesi. Successivamente alimentazione varia. Sonno regolato con melatonina.
Sviluppo psicomotorio: Controllo della posizione seduta dai 10 mesi, ora possibile in completa autonomia. Acquisizione della deambulazione autonoma da circa 3 settimane dall’osservazione. Passaggi posturali possibili in autonomia. Linguaggio caratterizzato da vocalizzi indifferenziati. Non udite parole. Strabismo divergente noto dai 7 mesi di vita. Forza e trofismo sono nella norma. Benedetta presenta una facies peculiare, associata a: lieve macroglossia con lingua protrusa e scialorrea.
Benedetta presenta un quadro di crisi epilettiche, con ultima crisi rilevata a marzo 2023. Gli ultimi esami di Video-EEG in veglia e in sonno, eseguiti durante il ricovero di luglio 2023, riportano “Attività di fondo lenta ritmica, inabituale, scarsamente reagente. Non rilevate anomalie epilettiformi. Lieve mioclono distale”. La bambina prosegue la terapia farmacologica con Depakin e Frisium.
Benedetta vive con i genitori e un fratello minore nato nel 2023. La bambina ha frequentato il primo anno di scuola dell’infanzia con sostegno, dove viene riferito buon adattamento; avviato trattamento nei setting di fisioterapia e logopedia con 3 sedute a settimana, una in compresenza.
OSSERVAZIONE NEUROPSICOMOTORIA
Benedetta accede al setting neuropsicomotorio accompagnata da entrambi i genitori, dai quali si separa con serenità. Il ricongiungimento avviene con entusiasmo e ricerca del contatto fisico.
La piccola all’interno della stanza mostra un atteggiamento di curiosità e di vivacità, esplicata da frenesia motoria: esplora l’ambiente circostante per ricercare oggetti di suo interesse, tramite il cammino che appare instabile, con base allargata e difficoltà di equilibrio. Presente ancora in alcune occasioni l’interesse a ricercare il contatto globale con le diverse superfici, adottando posture orizzontali.
Benedetta mostra attenzione per oggetti dalle caratteristiche sensoriali, specificatamente sonore, ed in movimento; esplora principalmente i materiali con modalità orale, spesso disinvestita del suo valore conoscitivo. Si osserva presenza di alcuni schemi motori d’azione quali battere tra loro, premere, scuotere, tirare fuori, tirare; questi risultano ampliabili su prompt fisico dell’adulto con possibilità di mettere dentro, svitare/avvitare, impilare, inserire. Nella spontaneità Benedetta tende ad innescare dinamiche ripetitive e poco funzionali nelle modalità esplorative, quali scuotere ripetutamente un oggetto, portarlo alla bocca e ruotare su sé stessa con il target in mano. In presenza di contesto strutturato, privo di interferenze visuo-sonore, pare possibile tramite l’imitazione e la guida verbale e fisica, incoraggiare la riduzione di tali attività e promuovere l’uso funzionale e diversificato dell’oggetto.
Per quanto concerne gli aspetti di manipolazione, la presa appare pluridigitale, inficiata da tremore e movimenti distali poco fluidi, riferita emergente presa a pinza, presente difficoltà di coordinazione oculo-manuale, più costante, seppur da sostenere, il monitoraggio visivo dell’azione. Presente l’integrazione bimanuale e la possibilità di trattenere due oggetti.
Risulta da promuovere la comprensione della causalità diretta, data la possibilità di catturare l’interesse della piccola nell’attivare alcune dinamiche, attraverso target sonori e tattili. Sviluppata la permanenza dell’oggetto.
Durante l’osservazione spontanea delle modalità di gioco della piccola si evince un miglioramento rispetto al precedente ricovero dei tempi attentivi, seppur risultano da sostenere. I tempi di attesa appaiono labili e non sufficienti ad avviare dinamiche di scambio e a favorire momenti di pausa-azione in cui ricercare l’attivazione comunicativa della bambina.
All’interno della cornice ludica si riferisce presente piacere e ricerca attiva per lo spazio psicomotorio e per le esperienze di sperimentazione corporea attiva e passiva. Benedetta mostra piacere nell’esplorazione sensoriale dei materiali inseribili all’interno di un percorso psicomotorio, appare divertita dalla possibilità di sperimentare il proprio corpo in relazione a contesti e situazioni differenti. Tuttavia, si registra difficoltà ed impaccio psicomotorio, con equilibrio precario e presenza importante di tremore, difficoltà nel monitorare visivamente l’ambiente durante la deambulazione e fatica nella possibilità di superare ostacoli, necessità della guida fisica e verbale dell’adulto per proseguire lungo un percorso strutturato e difficoltà ad avviare dinamiche di pausa-azione.
La percezione corporea in relazione al sé e l’ambiente circostante appare da sostenere e la consapevolezza corporea immatura. Benedetta non collabora al momento dell’infilare e sfilare le scarpe, ma appare attenta alle diverse parti del corpo quando entrano in contatto con diverse superfici, in particolar modo se dalle caratteristiche tattili ruvide e calde, seppur risulta un aspetto da sostenere.
Per quanto concerne gli aspetti affettivo-relazionali, Benedetta appare disponibile all’interazione con l’altro resa evidente da presenza di sorrisi, triangolazione di sguardo, attenzione congiunta, seppur tali aspetti risultano fluttuanti e da sostenere. Non sempre presente attenzione all’altro e risposta al nome.
Gradite esperienze sensomotorie e giochi tonico-emozionali con buona possibilità di instaurare un dialogo tonico e ricerca del contatto corporeo altrui.
Per quanto concerne gli aspetti comunicativo-linguistici, Benedetta mostra un’intenzionalità comunicativa ridotta e manifestata da sguardo, sorriso e variazione della mimica espressiva, seppur ridotta. Presenti alcuni vocalizzi in risposta ad attività maggiormente gradite, dalle caratteristiche sensoriali sonore e tattili.
INDICAZIONI ALLA FAMIGLIA E AL SERVIZIO TERRITORIALE
Da quanto osservato all’interno del setting neuropsicomotorio, si rende necessario proseguire la presa in carico territoriale volta a:
- Sostenere gli aspetti affettivo-relazionali e la possibilità di instaurare un dialogo tonico con l’adulto; promuovere l’accettazione della guida fisica dell’adulto resa necessaria per sostenere le modalità di gioco e consolidare la relazione con l’altro realizzata dal contatto di sguardo, triangolazione e momenti di attenzione congiunta e condivisa;
- Favorire la sperimentazione corporea e l’accesso al piacere sensomotorio, sostenendo la maturazione della consapevolezza del sé corporeo, attraverso il coinvolgimento di Benedetta in esperienze corporee positive e gratificanti. Proporre sequenze sensomotorie passive (quali dondolii sull’amaca, oscillazioni sopra il pallone) e tonico-corporee (es. giochi di contrasto tonico, pressioni, solletico). Ricercare all’interno delle esperienze maggiormente gradite l’attivazione di primarie dinamiche di pausa-azione (es. Interrompere il gioco e aspettare un segnale che veicoli la richiesta di ripetizione da parte della bambina, come lo sguardo o un vocalizzo)
- Strutturare un contesto ludico capace di sostenere l’esplorazione tramite atteggiamenti manipolatorio-fini dei diversi materiali proposti, partendo da target sonori e dalle caratteristiche ruvide e calde; promuovere l’acquisizione tramite prompt fisico di una maggiore variabilità negli schemi d’azione (mettere dentro, inserire, attaccare, avviare/svitare). La proposta di oggetti di diversa grandezza, consistenza e rumore, dalle caratteristiche percettive differenti, possono sostenere un’esplorazione ricca e varia con semplici prassie differenziate, lo sviluppo della presa a pinza superiore a seconda della funzione e delle caratteristiche dell’oggetto.
- Favorire lo sviluppo del gioco di causa-effetto proponendo attività quali la torre, le bolle, le ventose e i libretti sonori, in cui occorre guidare la bambina nel portare al termine l’azione. Promuovere lo sviluppo del gioco di scambio come i primi passaggi con la palla e le prime turnazioni.
- Migliorare ed ampliare i tempi attentivi sul gioco costruendo un setting selezionato e che presenti pochi stimoli, altamente interessanti per lei. Occorre proporre un’attività alla volta guidando Benedetta nel portare al termine l’azione. Favorire una riduzione dei tempi di attesa tramite attività di pausa-azione in cui attendere un suo segnale prima di ripetere l’azione o attendere il via.
ENEA
Data di nascita: 02/2018
Data dell’osservazione: giugno 2023
Età al momento dell’osservazione: 5 anni e 4 mesi
STORIA CLINICA E ANAMNESTICA
Secondogenito, nato a 39+2 SG da parto eutocico indotto dopo gravidanza normodecorsa. Alla nascita presenta i seguenti indici auxologici: PN 3300 g (50%ile), L 50 cm (50%ile), CC 33,5 cm (10%ile) e dopo mezz’ora dalla nascita avviene un ricovero in TIN per 4 giorni per episodio di desaturazione con successiva ossigeno-dipendenza e tachipnea.
Sviluppo psicomotorio: sorriso sociale in epoca, controllo del capo a 7 mesi, a 11 mesi ha raggiunto la posizione seduta con sostegno posteriore e accenna al semirotolo da supino con facilitazione, non spostandosi autonomamente. A 3 anni e 4 mesi raggiunge e mantiene autonomamente la postura seduta con anteroflessione del tronco, si sposta strisciando e verticalizza con sostegno. All’età di 4 anni e 9 mesi raggiunge la deambulazione, che rimane fino a data dell’osservazione incerta, su base allargata e con tendenza alla ricerca di supporto dopo pochi passi in autonomia. Enea porta i tutori AFO gamba-piede. Si esprime solamente attraverso vocalizzi modulati della voce. Presenta una facies tipica della Sindrome, con morso aperto, macroglossia, scialorrea e esotropia all’occhio sinistro.
In ambito epilettologico, Enea presenta una ridotta organizzazione dell'attività cerebrale di base in rapporto all'età, dominata da attività lenta diffusa, anomalie lente ed epilettiformi prevalenti sulle regioni posteriori dei due emisferi e più rare anomalie lente sulle regioni frontali. Inoltre, vengono riportati dai genitori alcuni episodi nell’ultimo anno di “tremori”, da indagare per sospetto di mioclono o startle dispercettivi, degli arti inferiori elicitati da modifiche posturali della durata di 2-3 secondi che comportano la perdita della postura, solitamente eretta. Si presentano con andamento variabile e periodi liberi anche di molte settimane. Tuttavia, non è stato possibile rilevarli durante la registrazione dell’EEG, rimangono dunque al momento manifestazioni parossistiche dalla natura non definita.
Enea vive con i genitori e una sorella maggiore di 11 anni. Attualmente frequenta la scuola materna 4 ore al giorno. Effettua 1 intervento di logopedia e 2 di fisioterapia a settimana. Inoltre, frequenta la piscina 3 volte a settimana.
OSSERVAZIONE NEUROPSICOMOTORIA
Enea accede al setting neuropsicomotorio accompagnato dalla mamma, dalla quale si separa senza difficoltà. Il ricongiungimento avviene con entusiasmo e ricerca fisica del genitore.
Dall’osservazione risulta un’organizzazione grosso motoria in ritardo rispetto all’atteso per età. Il mantenimento della posizione seduta autonoma avviene con carico sacralizzato, Enea si siede tra i talloni e con piedi in equino e cifosi globale del tronco. Enea raggiunge la posizione in statica eretta con appoggio delle mani e minima facilitazione, passando da cavalier servente, e mantiene tale posizione tendenzialmente con appoggio ventrale al piano ma possibile anche con il solo appoggio delle mani. La statica è realizzata con completo appoggio dei piedi a terra, con carico in valgo-pronazione, e globale extrarotazione degli arti inferiori. Possibile iniziale navigazione costiera con appoggio e deambulazione con sostegno, realizzata con base allargata, e disequilibri posturali che lo portano a severo sbilanciamento nello spazio posteriore. Migliora la performance se si offre sostegno laterale o anteriore, il bambino infatti, con tale modalità, riesce a mantenere il corretto bilanciamento del corpo e a realizzare un avanzamento sfruttando un minimo appoggio. Inoltre, si è potuto osservare come target sensoriali dalle caratteristiche sonore, ruvide e calde, motivassero maggiormente il bambino al movimento attraverso il raggiungimento degli oggetti proposti, portando il bambino anche a compiere piccole distanze, per la prima volta, anche senza alcun sostegno o appoggio nella fase di spostamento.
Il bambino all’interno della stanza appare sereno e ben disponibile alla relazione con la terapista. Enea accetta le diverse proposte di gioco dell’adulto e spontaneamente condivide con lui l’attenzione e l’emozione, tramite contatto di sguardo, triangolazione di sguardo, sorriso sociale, gesti richiestivi (porge l’oggetto) e gesti referenziali (ciao); questi aspetti risultano labili e da sostenere, migliori se motivato e in presenza di gratificazioni. La mimica facciale risulta poco variabile, modificabile lentamente in relazione alle proprie emozioni; difficile elicitare l’imitazione di gesti motori, anche in differita, migliore in presenza di target ruvidi. Enea si modula al contatto corporeo e ricerca il contenimento fisico dell’adulto durante i momenti di maggior stanchezza e faticabilità.
Si registra scarsa tolleranza alla frustrazione con atteggiamenti di rifiuto del compito richiesto e lancio dell’oggetto.
Presente l’intenzionalità comunicativa, seppur ridotta, volta alla richiesta di ripetere schemi d’azione particolarmente motivanti, in particolar modo di carattere sensoriale ruvido e sonoro, e per catturare l’attenzione dell’adulto al fine di esprimere desideri di gioco attraverso il canale mimico-gestuale (tendersi verso l’oggetto di desiderio e triangolare); non osservato il pointing e gesti deittici. Si registra la presenza di suoni gutturali finalizzati alla sperimentazione del canale orale e se fortemente motivato per attirare l’attenzione dell’adulto e condividere l’emozione. La scelta binaria avviene tramite allungamento diretto verso l’oggetto desiderato.
Enea comunica la propria stanchezza ed il desiderio di concludere l’azione con il lancio del materiale, precedentemente gradito.
Il gioco spontaneo è di carattere sensomotorio, volto all’esplorazione dei materiali e alla scoperta dei primi schemi d’azione che può avviare sul materiale. Il bambino compie ridotti schemi gestuali sul target quali mettere dentro, tirare fuori, lanciare, schiacciare, tirare, ruotare, questi risultano ampliabili su guida fisica dell’adulto e appare possibile favorire il gesto di inserire e sfilare, attaccare, strappare, girare. Durante l’esplorazione dei diversi materiali si osserva miglior avvio spontaneo dell’azione e della variazione dello schema d’azione in presenza di materiali tattili (ruvidi/morbidi/caldi) o dai suoni forti; possibile la manipolazione degli oggetti tattili, con passaggio da una mano all’altra. Possibile osservare l’integrazione bimanuale, che risulta da sostenere tramite l’utilizzo di oggetti dalla facile prensione e dalle dimensioni medio-grandi; la coordinazione oculo-manuale appare difficoltosa, con oggetti dalle piccole dimensioni risulta necessaria la guida fisica dell’adulto per completare l’azione; Enea mostra un monitoraggio visivo dell’azione non sempre costante, influenzato dall’interesse.
La presa appare pluridigitale ma risulta emergente la presa digitale con possibilità di adattare le mani alle caratteristiche dell’oggetto. Su guida, possibile la settorializzazione dell’indice. Durante le attività esplorative si registra primaria attivazione dell’AS sx, possibile osservare presa alternata dell’oggetto.
Con materiali tattili e sonori è possibile avviare primi schemi del gioco di scambio con intenzionalità nella direzione e possibilità di attendere il ritorno dell’oggetto. Risulta acquisita la comprensione della relazione di causalità e possibile lo svolgimento dei primi incastri semplici sonori su guida.
I tempi attentivi sull’attività risultano labili con atteggiamento di rinuncia nei confronti di azioni difficoltose; possibile l’ampliamento con oggetti in movimento, dalle caratteristiche sensoriali adattate quali tattili-sonore.
L’inseguimento visivo risulta discontinuo in tutti le direzioni di sguardo e con sostegno del capo (sx>dx); i movimenti saccadici difficoltosi e lenti, mentre l’aggancio visivo appare sostenuto.
Il bambino collabora nel momento del togliere ed infilare le scarpe e mostra buona comprensione del rituale della seduta di inizio e fine. Emergente la consapevolezza corporea, con buona attenzione e partecipazione attiva (passa i piedi) nel momento dei massaggi corporei indiretti (palla ruvida).
INDICAZIONI ALLA FAMIGLIA E AL SERVIZIO TERRITORIALE
Alla luce dell’osservazione neuropsicomotoria, si consiglia di proseguire la presa in carico volta a:
- Sostenere gli aspetti affettivo-relazionali e comunicativi implementando l’intenzionalità comunicativa e la condivisione attentiva ed emotiva sull’attività. Avviare giochi di scambio con target sensoriali che ne sostengono la motivazione, favorire la richiesta dell’avvio del gioco in dinamiche di pausa-azione, la lettura di libretti sonori condivisa o di attività sensoriali particolarmente motivanti, sono importanti per sostenere la triangolazione di sguardo, gesti richiestivi, sorriso sociale, condivisione attentiva ed emotiva e i suoni gutturali.
- Promuovere la variazione degli schemi d’azione, sostenendo la possibilità di compiere in autonomia gesti quali strappare/attaccare, tirare, inserire/sfilare e girare. Favorire l’integrazione bimanuale e sostenere il raggiungimento dei materiali con entrambi gli AASS, riducendo la risposta latente dell’AS dx. Si possono utilizzare materiali sensoriali motivanti e dalla facile prensione da presentare nell’emicampo dx;
- Sostenere la settorializzazione dell’indice tramite attività ludiche che promuovono l’uso delle dita singolarmente e lo sviluppo della presa a pinza superiore tramite oggetti dalle dimensioni differenti, piccole e dalla prensione facilitata;
- Sostenere gli apprendimenti cognitivi attraverso la proposta di incastri semplici, meglio se sonori, e le attività di causalità, come il gioco della torre, che può essere adattato sensorialmente. Promuovere il gioco imitativo e di scambio attraverso la proposta di azioni su imitazioni motivanti, massaggio indiretto con target sensoriale ruvido o caldo, da svolgere in alternanza;
- Sostenere la consapevolezza corporea e ricercare la partecipazione attiva durante i rituali quotidiani che passano attraverso il corpo (lavarsi, vestirsi, svestirsi). I massaggi diretti ed indiretti tramite l’uso di materiali ruvidi e caldi permettono di sostenere tali aspetti;
- Ampliare i tempi attentivi sul gioco tramite proposte sensoriali risultate accattivanti e motivanti, al fine di promuovere la conclusione delle azioni e la ripetizione di queste;
- Sostenere l’oculomotricità e gli aspetti della funzione visiva, migliorando l’inseguimento visivo nelle diverse traiettorie di sguardo e favorendo lo sviluppo di movimenti saccadici più fluidi e rapidi; promuovere la ricerca visiva sia in spazi ampi che permettono il coinvolgimento corporeo del piccolo nello spazio, sia in spazi ristretti che richiedono l’uso specifico di funzioni di scanning visivo. Si possono proporre attività capaci di motivare Enea a spostare lo sguardo da un bersaglio all’altro come il gioco del far apparire/scomparire palline dietro uno schermo.
- Potenziare il tono muscolare agli AASS, a livello distale, proponendo attività con le paste modellabili (pongo, plastilina, pasta di sale, etc..), introdurre nel gioco azioni che prevedano l’utilizzo contemporaneo di tutte le dita per impastare, fare serpentini e palline di pongo etc..; strappare la carta e appallottolarla, togliere i tappi ai colori (levare i coperchi dalle varie confezioni), interagire con pulsanti da premere per attivare giochi causa effetto.
CAPITOLO 7: DISCUSSIONE DEI RISULTATI
La Sindrome di Angelman presenta caratteristiche peculiari sotto numerosi aspetti e uno sviluppo neuropsicomotorio determinato da un ritardo globale in tutte le aree: emotivo-relazionale, comunicativo-linguistica, motoria e cognitiva. Come già citato in precedenza, tuttavia, non sono presenti numerosi studi sulla definizione di un profilo sensoriale specifico della sindrome, pur presentando tratti sensoriali specifici e singolari, come la fascinazione per l’acqua e l’attrazione per le superfici riflettenti. Questo studio, dunque, si vuole inserire all’interno di una cornice di ricerca che possa permettere una descrizione più accurata possibile delle peculiarità del bambino con Sindrome di Angelman, in modo da risultare utile nella comprensione del suo funzionamento e dunque, nella possibilità di individuare migliori strategie d’intervento e di riabilitazione.
L’obiettivo del terapista della neuropsicomotricità dell’età evolutiva è quello di osservare e valutare le competenze del bambino, in modo da poterle sostenere attraverso strategie e modalità funzionali allo sviluppo. Il progetto messo in atto dal terapista ha il compito di ottenere le migliori risposte adattive che il bambino può dare, in modo da rinforzarle e generalizzarle poi nella vita quotidiana dello stesso. Come cita Vygotskij, esiste una zona di sviluppo prossimale, che definisce un’area di competenze che il bambino riesce a raggiungere solo con l’aiuto dell’adulto o di un pari più esperto, sono competenze che il bambino non ha ancora appreso in autonomia ma per cui ha le capacità per farlo in un futuro prossimo (Grussu, 2016). All’interno di questa cornice teorica si inserisce l’intervento del terapista della neuro e psicomotricità che agisce con il fine di sostenere il bambino nel raggiungimento delle tappe dello sviluppo, in modo da acquisire maggiori e migliori competenze e abilità.
Una strategia efficace è sicuramente legata agli aspetti sensoriali e percettivi, in quanto, lo sviluppo sensoriale è strettamente legato allo sviluppo neuropsicomotorio, influenzandolo e dando un importante contributo allo sviluppo globale del bambino. Gli aspetti sensoriali permettono al bambino di entrare in relazione con il mondo e la realtà circostante, permettendo, in questo modo, al soggetto di conoscere e comunicare con sé stesso, gli altri e il mondo.
Proprio i bambini con Sindrome di Angelman, presentando un ritardo dello sviluppo globale, possono ritrovare all’interno degli stimoli sensoriali input accattivanti e stimolanti per la promozione di nuove abilità. Il profilo cognitivo, infatti, è spesso molto compromesso e i canali sensopercettivi diventano una possibile e importante modalità di relazione e scambio con il mondo e gli altri, andando a sostenere le prime competenze cognitive quali la permanenza dell’oggetto o il meccanismo di causa e effetto primario.
Il progetto, dunque, dopo aver effettuato una prima ricerca bibliografica sulle caratteristiche legate alla particolare sindrome e sull’importanza degli aspetti sensoriali all’interno dello sviluppo neuropsicomotorio del bambino, vuole evidenziare la necessità di una scheda di osservazione del profilo sensoriale del bambino con Sindrome di Angelman. In questo modo, abbiamo svolto un approfondito studio sulle schede di osservazione già esistenti e ne abbiamo costruita una che permettesse di mettere in luce quali fossero i canali sensoriali che maggiormente permettono una risposta adattiva all’ambiente da parte del bambino.
La scheda ha permesso di raccogliere, sintetizzare e organizzare i dati osservati in relazioni neuropsicomotorie che potessero dare una descrizione completa e esaustiva sul funzionamento e sullo stadio di sviluppo di ogni bambino osservato, in modo da poter poi ricavare le migliori strategie d’intervento e gli obiettivi riabilitativi, il più possibile personalizzati per il bambino stesso.
A tal scopo verranno riportate le considerazioni fatte durante il progetto sull’efficacia e l’utilizzo della scheda di osservazione e sui risultati con essa ottenuti, in modo da evidenziare possibili somiglianze o divergenze tra i casi esaminati dallo studio e poterne trarre delle conclusioni.
7.1 La scheda di osservazione
In questo studio di tesi, l’obiettivo principale dello strumento di osservazione, ovvero la Scheda di osservazione e valutazione del profilo sensoriale del bambino con Sindrome di Angelman, è stato quello di riconoscere e individuare le caratteristiche del profilo senso-percettivo di bambini in età prescolare con Sindrome di Angelman e i canali sensoriali preferenziali alla promozione di nuove e possibili risposte adattive all’ambiente, per poter sostenere lo sviluppo neuropsicomotorio. L’uso della scheda ha permesso anche di poter condividere, con i caregiver e i servizi territoriali di appartenenza di ciascun bambino, modalità e strategie personalizzate, atte a facilitare lo sviluppo e la promozione di nuove abilità e competenze, in modo che risultassero possibili input da proporre non solo all’interno di un setting terapico ma anche nella vita quotidiana del bambino, per favorire la generalizzazione delle competenze.
La scheda si pone come uno strumento valido per il TNPEE nel momento delle sedute di osservazione e valutazione inziali del bambino, in quanto permette di organizzare e strutturare l’incontro e l’osservazione stessa del terapista del profilo funzionale del bambino con particolare attenzione agli aspetti senso-percettivi. La scheda permette di individuare più facilmente e velocemente quali possono essere i canali che coinvolgono maggiormente una risposta da parte del bambino e di poter guidare una sintesi più organizzata e strutturata dell’osservazione compiuta. Inoltre, il materiale, proposto con la scheda, permette di osservare e valutare le diverse sensorialità riducendo al minimo le interferenze che potrebbero indirizzare il bambino alla scelta dell’input seguendo altri criteri come ad esempio la forma, il colore o la dimensione. Il materiale è stato costruito e realizzato con lo scopo di poter proporre al bambino esperienze sensoriali specifiche e univoche, per poter validare l’osservazione e l’utilizzo della scheda. La scheda e il materiale proposto possono, anche, dare la possibilità al terapista di poter riproporre e ripetere l’osservazione anche a distanza di tempo, seguendo le stesse modalità e proponendo gli stessi input sensoriali, in modo da poter ricavare informazioni utili non solo sulle condizioni del bambino in un determinato tempo, ma anche del suo possibile sviluppo e andamento funzionale all’interno di una cornice temporale. L’ipotesi di proporre questo strumento di osservazione in un tempo zero e in un tempo T1 può far emergere numerose e diverse considerazioni sulle capacità del bambino e sulle sue potenzialità nel tempo, osservando e valutando i possibili miglioramenti delle diverse aree dello sviluppo. Inoltre, la scheda permette di essere spunto importante per la condivisione di strategie e modalità di interazione con i caregiver del bambino, suggerisce infatti materiali e proposte che possono essere funzionali e d’interesse per il bambino stesso e di facile riproposizione anche all’interno di un setting domestico. La scheda può diventare quindi uno strumento dalla quale il terapista può partire per instaurare una buona relazione terapeutica con i genitori e essere strumento concreto di osservazione e valutazione, anche con quest’ultimi.
La scheda, tuttavia, se pur strutturata permette al terapista di poter adattare la proposta a seconda delle competenze e del profilo funzionale del singolo bambino. Lo strumento osservativo, infatti, descrive le modalità con cui i materiali vanno proposti ma non le singole attività, che possono spaziare e diversificarsi in base al caso da osservare. Questo permette al terapista di poter somministrare la scheda a un range maggiore di bambini, compresi nella fascia prescolare, e di poter ricavare le informazioni che necessita in modo trasversale e specifico per ogni bambino. Un limite, però, che la scheda possiede è il range cognitivo a cui si rivolge. I materiali e le modalità di proposta, se pur molto semplici e di facile adattamento a situazioni diverse, prevedono il raggiungimento o il far emergere le competenze primarie di causalità d’azione. Per questo motivo, se il bambino, pur rientrando all’interno della fascia d’età indicata dallo strumento, ha già raggiunto competenze cognitive di causa-effetto primaria, sarà in modo minore coinvolto nelle attività proposte e i materiali potrebbero risultare di un livello troppo basso e quindi non essere accattivanti per il bambino stesso. È, dunque, importante capire se e quando la scheda può essere somministrata, in modo che possa avere il giusto valore all’interno dell’osservazione neuropsicomotoria. Questo può avvenire in modo più significativo quando il bambino presenta un’età che si posiziona nella fascia alta del range d’età considerata, anche se tuttavia nella maggior parte dei casi questa competenza cognitiva non è ancora stata raggiunta neanche all’età di cinque anni.
La scheda, inoltre, è strutturata e organizzata con lo scopo di osservare se è presente o meno una competenza e con quali strategie essa maggiormente si attiva, in questo modo potrebbe essere facile constatare che si possano perdere molti aspetti qualitativi dell’osservazione, fondamentali all’interno di un setting neuropsicomotorio. La scheda, tuttavia, si vuole porre come punto di partenza per un’osservazione più accurata e possibile strumento per facilitare una sintesi maggiormente organizzata e completa, è importante, quindi, che il terapista usi la scheda come strumento di osservazione e non come sostituta della stessa, facendo dunque anche riferimento alle sue capacità osservative, per poter descrivere al meglio il funzionamento del bambino.
7.2 Discussione dei dati
I dati raccolti attraverso la scheda hanno permesso di evidenziare come la sensorialità sia un canale fondamentale per poter lavorare sulle diverse funzionalità dei bambini osservati con Sindrome di Angelman. Inoltre, hanno messo in luce caratteristiche sensoriali peculiari, da cui è stato possibile trarre delle similitudini e delle omogeneità, tra i diversi casi osservati. Vengono, dunque, di seguito riportati i dati attraverso l’utilizzo di alcuni istogrammi, per evidenziare in modo più significativo le differenze tra i diversi target e
l’importanza dei risultati ottenuti.
Grafico 1. Media della modificabilità adattiva nelle aree di sviluppo dei 5 casi osservati
Le osservazioni, attraverso lo strumento osservativo proposto, hanno presentato dei chiari risultati, riportando in tutte le aree di sviluppo un’evidente modificabilità di funzionamento adattivo in tutti i casi esaminati. Come si evince, infatti, dal grafico riportato (Grafico 1), che rappresenta la media della modificabilità adattiva suddivisa per aree e per canali sensoriali dei 5 casi studiati, quasi la metà di item di ogni area di sviluppo si è modificata e implementata attraverso proposte di tipo sensoriale. È possibile, dunque, dedurre e sottolineare l’importanza che può avere la sensorialità come canale di relazione con sé stessi, gli altri e il mondo per bambini con un importante deficit globale dello sviluppo. Per tutti i casi riportati è possibile, infatti, osservare l’efficacia dei canali sensoriali per sostenere, in ciascun caso, abilità e competenze emergenti e promuoverne di nuove, permettendo in questo modo di riconoscere e poi adattare le proposte e le modalità al singolo bambino e alle sue esigenze. Questo dato risulta importante per il terapista in quanto permette di adattare le proprie proposte e strategie d’azione non solo all’interno di un setting di osservazione ma anche per un possibile futuro trattamento ri-abilitativo.
La raccolta dei dati, tuttavia, ha permesso anche di poter riscontrare delle possibili similitudini tra i casi osservati. Infatti, come si può riscontrare dal grafico (Grafico 1), è emersa una distinzione omogenea tra i tre canali sensoriali scelti per il progetto, in tutti i bambini osservati dallo studio. I canali maggiormente coinvolti e utili nella facilitazione della comparsa di risposte adattive sono stati in modo significativo quello tattile e sonoro. Sono stati, infatti, utilizzati come strategie importanti per il raggiungimento di nuove competenze e per il consolidamento di altre, in tutte le aree dello sviluppo. I target sonori e tattili sono stati fonte di interesse e di preferenza per tutti i casi riportati, evidenziando in questo modo caratteristiche sensoriali simili e una preferenza di stimoli sensoriali omogenea. Inoltre, se i canali sensoriali sonoro e tattile sono in modo comune investiti in tutte le aree, per i bambini osservati, allo stesso modo il canale visivo è stato, se pur proposto con le stesse modalità degli altri target, poco influente all’interno delle sedute di osservazione. È presente, infatti, la quasi assenza di item sostenuti da target visivi, influendo in modo minore all’interno dello studio proposto.
Considerando quindi i canali sonoro e tattile come maggiori sostenitori dello sviluppo neuropsicomotorio dei bambini osservati in questo progetto, esamineremo ora in modo più dettagliato quali sono le caratteristiche peculiari dei diversi canali che hanno favorito maggiori risposte adattive, attraverso l’analisi dei dati di particolari item della scheda che hanno permesso un miglior cambiamento di funzionamento, riportando delle modifiche significative di risposte adattive all’interno delle sedute di osservazione. Gli item sono: aumento dell’intenzionalità comunicativa, item 10 della scheda, ampliamento degli schemi d’azione di motricità fine e aumento di attuazione di passaggi posturali adeguati per età e di spostamenti pre/locomotori, rispettivamente item 19, 20 e 21, e aumento dei tempi attentivi, facente all’item 24 dello strumento di osservazione proposto. Le risposte verranno rappresentate da alcuni grafici che riportano i dati ricavati dal compilamento delle schede di osservazione per ciascun bambino. Ogni item viene rappresentato con 2 diversi grafici, rispettivamente con i target sonori e i target tattili; i target visivi non verranno rappresentati in quanto per ciascun item non hanno avuto valore significativo nell’osservazione in questo studio.
Grafico 2. Risposte del canale sonoro all’item 10 “Aumento dell’intento comunicativo”
Grafico 3. Risposte del canale tattile all’item 10 “Aumento dell’intento comunicativo”
Come si evince dai grafici (Grafico 2 e Grafico 3), per i bambini osservati sia gli aspetti sonori che tattili hanno ampiamente favorito e sostenuto l’intenzionalità comunicativa all’interno delle sedute di osservazione. Per questo item, i 5 bambini hanno risposto in modo ampiamente significativo ai target dalle caratteristiche sonore, dove poco è stato rilevante il livello di frequenza utilizzato; gli input sonori hanno portato tutti i bambini a utilizzare la propria voce, attraverso vocalizzi modulati, o il canale gestuale per comunicare all’interlocutore la ripetizione di un’azione o la meraviglia per un target d’interesse. In tutti i casi, il canale sonoro ha portato a uno scambio relazionale e comunicativo significativo, sostenendo abilità ancora molto fragili nella maggior parte dei casi osservati. Come il canale sonoro, anche il canale tattile, per la maggior parte dei bambini, quattro su cinque, è risultato efficace per favorire tale competenza. In questo caso, tuttavia, è evidente però una distinzione tra i target all’interno della stessa categoria: al contrario di quanto atteso dalla letteratura gli stimoli ruvidi, rispetto a quelli morbidi che sono stati irrilevanti, hanno influito in modo significativo, venendo preferiti e ricercati, come i target caldi, che in parte, hanno avuto lo stesso peso di quelli ruvidi, come ci si aspettava dagli studi in letteratura. Sia i target freddi che morbidi non hanno invece riscontrato alcuna rilevanza all’interno di questo item, in modo omogeneo per tutti
i casi osservati.
Grafico 4. Risposte del canale sonoro all’item 19 “Amplia i suoi schemi di azione di motricità fine (es. girare, lanciare, infilare, mettere dentro/tirare fuori)”
Grafico 5. Risposte del canale tattile all’item 19 “Amplia i suoi schemi di azione di motricità fine (es. girare, lanciare, infilare, mettere dentro/tirare fuori)”
Grafico 6. Risposte del canale sonoro agli item 20 e 21 “Attua i passaggi posturali in modo funzionale e adeguato per età” e “Attua spostamenti pre/locomotori”
Grafico 7. Risposte del canale tattile agli item 20 e 21 “Attua i passaggi posturali in modo funzionale e adeguato per età” e “Attua spostamenti pre/locomotori
Anche sul piano motorio è stato possibile evidenziare cambiamenti significativi attraverso l’uso di canali sensoriali differenti. Per quanto riguarda la motricità fine è stato possibile osservare in modo rilevante l’emergere di nuovi schemi d’azione grazie all’utilizzo di target sensoriali adattati. In questo caso, gli aspetti sonori sono meno rilevanti di quelli tattili, come dimostrano i grafici riportati (Grafico 4 e 5), in quanto solo 3 bambini su 5 hanno riportato un possibile ampliamento degli schemi motori della motricità fine, non dimostrando particolari differenze tra le frequenze proposte. Mentre, d’altra parte, il canale tattile è stato il maggior fautore del cambiamento della motricità fine all’interno del progetto. Tutti i casi hanno presentato un maggior coinvolgimento degli arti superiori e della motricità con target di tipo tattile, in particolare ha dato una risposta univoca il target dalla caratteristica ruvida, che ha permesso ai bambini osservati di esplorare e manipolare in modo differente i diversi input proposti, dando la possibilità di sperimentare nuove abilità come mettere dentro e tirare fuori, girare, infilare e lanciare. I target dalle caratteristiche ruvide hanno permesso di adattare la presa ai diversi oggetti modificati sensorialmente e di poter rendere funzionale dei movimenti, inserendoli all’interno di una cornice di gioco o di scambio relazionale, per tutti i bambini dello studio. In questo modo il canale sensoriale tattile ha permesso di sostenere non solo la motricità fine, ma anche i tempi attentivi, gli aspetti cognitivi, la pianificazione e l’imitazione, attraverso la riproposizione di azioni da parte della terapista. Queste competenze sono abilità emergenti che i bambini hanno presentano in stanza di terapia perché sostenuti da una forte motivazione e coinvolgimento, sottolineando ancora una volta l’efficacia riscontrata con proposte sensoriali. Anche i target caldi e morbidi hanno contribuito, per alcuni bambini, all’ampliamento di schemi d’azione, sottolineando l’importanza del canale tattile nello sviluppo neuropsicomotorio e in particolare per gli aspetti prassico-manipolativi.
Per quanto riguarda, invece, gli aspetti di motricità globale il profilo risulta ancora più omogeneo e simile tra i diversi bambini osservati con Sindrome di Angelman. Si evince in modo chiaro dai grafici (Grafico 6 e 7), una risposta netta e evidente: gli spostamenti e i passaggi posturali sono stati favoriti e facilitati dalla presenza di target sonori a bassa frequenza, che per tutti e 5 i casi osservati sono stati fonte di motivazione per il raggiungimento e dunque lo spostamento nello spazio. I bambini dello studio presentano sviluppi motori differenti e non hanno acquisito tutti le stesse competenze, tuttavia i target sonori dalle basse frequenze hanno permesso di raggiungere passaggi posturali instabili e ancora non del tutto acquisiti e hanno sostenuto lo spostamento di tipo prelocomotorio o locomotorio a seconda delle competenze di ciascun bambino. Oltre agli aspetti sonori, anche il canale tattile ha contribuito, infatti, 4 bambini su 5 hanno migliorato le proprie competenze motorie anche con target di tipo prevalentemente ruvido, e in parte dalle caratteristiche calde. In modo particolare la motivazione al raggiungimento di determinati stimoli ha permesso per la maggior parte dei bambini il raggiungimento della stazione eretta, tappa non per tutti acquisita in autonomia, e la determinazione nella scelta di alcuni particolari target rispetto ad altri ha permesso lo spostamento in navigazione costiera laterale per poter raggiungere l’oggetto d’interesse. In modo particolare, possiamo riportare il caso di Enea, per cui il target dalle caratteristiche calde ha permesso di poter svolgere i primi passi senza sostegno proprio all’interno della stanza neuropsicomotoria. Questo a dimostrare in modo concreto quanto sia importante conoscere, scegliere e proporre i giusti stimoli, in modo da poter motivare e sostenere in modo significativo lo sviluppo del
bambino.
Grafico 8. Risposte del canale sonoro all’item 24 “Mantiene l’attenzione per una lunga durata”
Grafico 9. Risposte del canale tattile all’item 24 “Mantiene l’attenzione per una lunga durata”
Uno degli aspetti che più ha dimostrato in modo chiaro l’importanza delle proposte sensoriali per bambini con Sindrome di Angelman è stato quello dell’aumento dei tempi attentivi. La sindrome, da descrizione, prevede una grande difficoltà da parte del bambino a orientare e a mantenere l’attenzione su un singolo target per tempi duraturi; i bambini affetti da Sindrome di Angelman, infatti, spesso sono caratterizzati da un’importante labilità attentiva associata a frenesia e instabilità motoria. È stato, dunque, significativo poter osservare all’interno delle sedute il cambiamento dei bambini di fronte a target sensoriali, che hanno permesso in tutti i casi dello studio un prolungamento notevole dei tempi di attenzione e di interesse verso uno stesso stimolo. Questo è avvenuto in modo particolare, nei bambini osservati, per il target caldo, che ha catturato la loro attenzione, come si evince dal grafico riportato (Grafico 8), e ha permesso di svolgere attività diversificate pur mantenendo l’attenzione su uno stesso stimolo, senza cambiare o perdere il focus. In quasi egual modo, anche il canale sonoro ha influito nel miglioramento dei tempi attentivi da parte dei bambini considerati, come viene riportato dal grafico (Grafico 9), preferendo i target a bassa frequenza in modo più significativo. Alcuni dei casi osservati oltre agli aspetti sonori e caldi, hanno dimostrato un aumento considerevole dei tempi attentivi anche con target ruvidi, per due bambini, e morbidi, solo per un bambino. Anche in questo caso, è stato possibile osservare delle caratteristiche sensoriali omogenee e una preferenza di target simile tra i diversi casi osservati, come per l’assenza, ancora una volta di investimento per il target dalle sensazioni fredde, che nuovamente non promuove alcuna risposta adattiva. Infatti, se pur presentando le stesse caratteristiche di forma, dimensione, colore e modalità di proposta, i target dalle caratteristiche fredde e visive non hanno portato a un aumento dei tempi attentivi, anzi si sono dimostrati target che una volta esaurita l’attenzione iniziale di novità, della durata di pochi secondi, hanno completamente perso d’interesse.
Sintetizzando, dunque, i dati analizzati è stato possibile evidenziare in modo significativo l’importanza degli aspetti sensoriali per sostenere e ampliare le risposte adattive in tutte le aree coinvolte. Lo strumento della scheda risulta quindi importante per poter capire quali stimoli e quali target maggiormente coinvolgono ciascun bambino, in modo da poter poi adattare le attività e le modalità d’interazione. Inoltre, è stato possibile osservare anche un’omogeneità nelle risposte ai diversi target sensoriali proposti. Lo studio, infatti, se pur condotto su un numero limitato di casi, ha evidenziato caratteristiche sensoriali peculiari simili tra i bambini osservati con un maggiore investimento attraverso i canali di tipo sonoro e tattile, e in particolare dalle caratteristiche tattili ruvide e calde, e, in modo ancora più omogeneo, un disinvestimento di interesse nei confronti di target dalle caratteristiche visive e fredde. Il dato, tuttavia, più rilevante è stato che tutti i bambini hanno presentato un cambiamento positivo nel proprio funzionamento globale, grazie all’introduzione di materiali adattati sensorialmente. Per questo motivo, dunque, sono stati poi frutto di condivisione sia con la famiglia che con il territorio di provenienza di ogni bambino, in modo da poter sfruttare e investire i risultati osservati e ottenere un miglioramento e adattamento all’ambiente generalizzato.
È importante, tuttavia, sottolineare l’importanza di un trattamento trasversale e con un approccio multisensoriale, che possa incentivare e sostenere tutte le sensorialità del bambino. Le osservazioni ricavate da questo studio permettono, infatti, di poter attuare un possibile adattamento dell’ambiente e una condivisione di strategie utili, in modo da facilitare e sostenere, adattando i diversi materiali, il funzionamento neuropsicomotorio del bambino con Sindrome di Angelman, riconoscendo una sua modificabilità attraverso l’uso del canale sensoriale, che va indagato e analizzato in ciascun bambino.
All’interno di questa cornice, si inseriscono anche i caregiver che possono influire sul miglioramento del bambino, sostenendolo nel suo sviluppo. Più volte abbiamo parlato dell’importanza di generalizzare e dunque di proporre e consigliare ai genitori modalità, strategie e giochi adattati che permettessero, anche in un ambiente domestico, l’emergere di determinate competenze e abilità. Risulta, tuttavia, importante che i caregiver si dimostrino attenti e collaboranti con il terapista, in modo da poter avviare uno scambio di condivisione e ascolto reciproco atto a creare rete intorno al bambino. La scheda, e il progetto, hanno permesso di dedicare un tempo importante alla consegna dell’osservazione svolta in stanza e dunque al confronto diretto con i caregiver, che ha permesso una maggiore condivisione e possibilità di compliance da parte dei genitori. Poter mostrare direttamente a quest’ultimi il cambiamento del funzionamento del bambino attraverso proposte sensoriali, che facilmente sono riproducibili anche in ambiente domestico, ha sostenuto i genitori nella fiducia con il terapista e nell’autoefficacia nei propri confronti, permettendo in questo modo una possibile generalizzazione delle strategie e degli obiettivi, fine ultimo del lavoro del terapista.
CONCLUSIONI
Sempre più importanza, negli ultimi anni, sta prendendo lo studio delle diverse sensorialità e di come quest’ultime si sviluppano in età fetale e post-uterina. Lo sviluppo sensoriale, infatti, influisce in modo importante nello sviluppo e nel funzionamento neuropsicomotorio del bambino, promuovendo e sostenendo diverse risposte adattive e competenze in tutte le aree. Risulta, dunque, significativo poter conoscere il profilo sensoriale di bambini con difficoltà adattive e del neurosviluppo, in modo da poter attuare strategie e modalità che considerino questi aspetti e che promuovano lo sviluppo neuropsicomotorio attraverso il canale sensoriale.
La sindrome di Angelman è una patologia che presenta in modo importante difficoltà in tutti gli aspetti e ambiti dello sviluppo; questi bambini riportano deficit emotivo-relazionali, comunicativo-linguistici, motori e cognitivi, andando a descrivere un quadro con serie difficoltà di interazione e relazione con il mondo. Inoltre, pur presentando evidenti peculiarità sensoriali è ancora limitato in letteratura lo studio del profilo sensoriale di questa sindrome. È risultato, quindi, importante poter approfondire e analizzare quali fossero i canali sensoriali che maggiormente attivano i diversi bambini con Sindrome di Angelman, in modo tale da poter modificare e adattare il proprio intervento riabilitativo e setting neuropsicomotorio per sostenere al meglio le competenze di ciascun caso osservato.
Da questa cornice nasce la necessità di costruire una scheda di osservazione specifica per individuare i canali e i target sensoriali peculiari che possono migliorare il funzionamento adattivo in bambini in età prescolare con Sindrome di Angelman. Lo strumento costruito è stato quindi sottoposto a 5 diversi bambini nelle sedute dedicate di osservazione e valutazione iniziale. In questo modo, la scheda permette di poter sistematizzare e valorizzare le osservazioni qualitative svolte dal terapista, con il fine di indirizzare e facilitare poi la stesura di un progetto riabilitativo che possa considerare e utilizzare strategie e modalità il più possibile personalizzate.
I dati raccolti dalle osservazioni, grazie all’utilizzo della scheda, hanno permesso di evidenziare l’efficacia e l’importanza dei canali sensoriali nello sviluppo di nuove competenze dei bambini osservati, inoltre ha evidenziato caratteristiche sensoriali simili tra i diversi casi riportati, come ci aspettavamo dalle premesse teoriche iniziali. L’analisi dei dati ha evidenziato un importante miglioramento del funzionamento adattivo, in tutte le aree, attraverso l’utilizzo di target sensoriali, presentando in particolare nei bambini descritti dal progetto una preferenza per materiali dalle caratteristiche sonore e tattili: ruvide e calde e la quasi totale assenza di risposte adattive con target dalle caratteristiche fredde e visive. Da questi dati è possibile, dunque, comprendere il peso e l’influenza che il canale sensoriale può avere all’interno delle sedute neuropsicomotorie di questi bambini. Questo permette in modo significativo al terapista di poter organizzare le proprie sedute di riabilitazione adattando le proposte, il setting e i materiali attraverso quanto ricavato dall’uso della scheda, in modo tale da poter incentivare sempre più risposte adattive attraverso i giusti target sensoriali.
È importante sottolineare che i seguenti dati sono stati raccolti solamente attraverso l’osservazione di 5 casi. Lo studio necessiterebbe un ulteriore approfondimento e analisi su un campione più vasto per poter definire in modo certo un possibile profilo sensoriale della sindrome. Risultano tuttavia di interesse i dati ricavati, in quanto omogenei tra di loro.
In conclusione, il canale sensoriale si dimostra un ottimo strumento di intervento all’interno del setting neuropsicomotorio con bambini con difficoltà di sviluppo globale. Individuare, infatti, il profilo sensoriale di questi bambini permette al terapista e ai caregiver di poter conoscere ulteriormente le caratteristiche di funzionamento del bambino stesso e dunque poter stendere un progetto riabilitativo che possa essere il più personalizzato possibile. Inoltre, l’uso di uno strumento di osservazione specifico per l’osservazione diretta in ambito sensoriale permette di validare il lavoro del terapista all’interno della propria stanza di neuropsicomotricità e di poter sistematizzare e ordinare le sedute e la sintesi.
Sperimentare e comprendere, quindi, quali canali sensoriali attivano maggiormente il bambino con Sindrome di Angelman permette al terapista e ai caregiver di attuare strategie e facilitazioni che permettano a questi bambini di poter entrare in relazione con loro stessi, gli altri e il mondo, sostenendo in questo modo lo sviluppo neuropsicomotorio e le tappe evolutive in tutte le aree di crescita e permettendo, quindi, di migliorare e acquisire nuove abilità e competenze.
BIBLIOGRAFIA
- Abelenda AJ & Rodríguez Armendariz E (2020), Evidencia científica de integración sensorial como abordaje de terapia ocupacional en autismo [Scientific evidence of sensory integration as an approach to occupational therapy in autism]. Medicina (B Aires). 80 Suppl 2:41-46.
- Abrunzo R, Cortese S, Della Corte G & Zecchi B (2020), Il terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva in Italia, in Europa e nel mondo: nascita, evoluzione e diffusione della figura professionale, Il TNPEE, Vol 2, No 1, Ed. Erickson.
- Angelman H (1965), ‘Puppet’ children. A report on three cases. Dev Med Child Neurol; 7: 681–88.
- ANUPI (n.d.) (a), Il terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva. Disponibile on-line all’indirizzo: https://www.anupitnpee.it/il-tnpee/la-professione.html
- ANUPI (n.d.) (b), “Il progetto personalizzato per il bambino con disabilità alla luce della classificazione ICF e ICF-CY”. Disponibile on-line all’inidirizzo: https://www.anupitnpee.it/documenti-di-cornice/216-il-progetto-personalizzato-per-il-bambino-con-disabilita-alla-luce-della-classificazione-icf-e-icf-cy.html
- Beckung E, Steffenburg S & Kyllerman M (2004), Motor impairments, neurological signs, and developmental level in individuals with Angelman syndrome. Dev Med Child Neurol. 46(4):239-43.
- Berti E, Comunello F & Savini P (2015), Il contratto terapeutico in terapia psicomotoria, dall’osservazione al progetto, Ed. junior srl.
- Bird LM (2014), Angelman syndrome: review of clinical and molecular aspects. Appl Clin Genet. 7:93-104.
- Birnholz JC & Benacerraf BR (1983), The development of human fetal hearing. Science. 222(4623):516-8.
- Blasi F (2015), Disturbi visivi associati alle Paralisi Cerebrali Infantili ed intervento riabilitativo di tipo neuropsicomotorio, Università Sapienza di Roma.
- Bonavolonta G (2012), Approccio psicomotorio integrato: possibili applicazioni in un caso di medulloblastoma, Tesi di laurea in Terapia della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva, Università di Padova.
- Boscaini F, Gobbi G, Malesani P G, & Mazzara G (1992). Iter psicomotorio. Libreria Universitaria Editrice.
- Bower BD & Jeavons PM (1967), The "happy puppet" syndrome. Arch Dis Child;42(223):298-302.
- Bremner AJ & Spence C (2017), The Development of Tactile Perception. Adv Child Dev Behav. 52:227-268.
- Burbi C (2016), “Ipotesi di individuazione di linee guida per l’utilizzo di Strumenti di Osservazione e Valutazione del Terapista della Neuro e Psicomotricità dell’Età Evolutiva”, Tesi di Laurea in Terapia della neuro e Psicomotricità dell’Età Evolutiva, Università degli Studi di Milano-Bicocca.
- Calculator SN (2013), Parents’ reports of patterns of use and exposure to practices associated with AAC acceptance by individuals with Angelman syndrome. Augment Altern Commun; 29, 146–58.
- Camaioni L & Di Blasio P (2007), Psicologia dello sviluppo, Il Mulino, Bologna.
- Camarata S, Miller LJ & Wallace MT (2020). Evaluating Sensory Integration/Sensory Processing Treatment: Issues and Analysis. Front Integr Neurosci. 14:556660.
- Capobianco M (2014), Lo sviluppo percettivo, Università Lumsa di Roma Dipartimento di Scienze Umane. Disponibile on-line all’indirizzo: https://www.lumsa.it/sites/default/files/UTENTI/u431/sviluppo.percettivo-2014.pdf.
- Cascio CJ, Moore D & McGlone F (2018), Social touch and human development. Dev Cogn Neurosci. 35, 5-11.
- Clarke DJ & Marston G (2000), Problem behaviors associated with 15q-Angelman syndrome. American Journal on Mental Retardation, 105, 25–31.
- Clark-Gambelunghe MB & Clark DA (2015), Sensory development. Pediatr Clin North Am. 62(2), 367-84.
- Clayton-Smith J & Pembrey ME (1992), Angelman syndrome. J Med Genet; 29(6):412-5.
- Costantino M A (2021), Sindrome di Angelman e difficoltà nella comunicazione e nel linguaggio, in Fast, La Sindrome di Angelman.
- Dagli AI, Mathews J & Williams CA (2021), Angelman Syndrome. In: Adam MP, Mirzaa GM, Pagon RA, et al., editors. GeneReviews® [Internet]. Seattle (WA): University of Washington, Seattle.
- Decreto Legge 17 gennaio 1997, n. 56 Regolamento concernente la individuazione della figura e relativo profilo professionale del terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva. disponibile on-line all’indirizzo: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1997/03/14/097G0084/sg.
- Dunn W (2007), Supporting Children to Participate Successfully in Everyday Life by Using Sensory Processing Knowledge, Infants & Young Children Vol. 20, No. 2, pp. 84–101.
- Eeles AL, Spittle AJ, Anderson PJ, Brown N, Lee KJ, Boyd RN & Doyle LW (2012), Assessments of sensory processing in infants: a systematic review. Dev Med Child Neurol;55(4):314-26.
- Fantz R L (1958), Pattern vision in young infants. The Psychological Record, 8(2), 43–47.
- Fantz R L (1963), Pattern Vision in Newborn Infants. Science, 140(3564), 296–29.
- Fedrizzi E (2009), I disordini dello sviluppo motorio. Fisiopatologia. Valutazione diagnostica. Quadri clinici. Riabilitazione, Piccin.
- Fraiberg S (1977), Insights from the blind: comparative studies of blind and sighted infants. New York, Plenum Press.
- Fuchs JC & Tucker AS (2015), Development and Integration of the Ear. Curr Top Dev Biol.115:213-32.
- Giunti Psychometrics (n.d.) (a), Winnie Dunn. Disponibile on-line all’indirizzo: https://www.giuntipsy.it/autori/Winnie-Dunn.
- Giunti psychometrics (n.d.) (b), Sensory profile 2, Lo strumento ideale per identificare il profilo sensoriale di bambini e adolescenti. Disponibile on-line all’indirizzo https://www.giuntipsy.it/media/74677003.brochure-sensory-profile-2-1-.pdf.
- Gomes Fuchs E (2017), L’efficacia dell’intervento ergoterapico attraverso il metodo dell’integrazione sensoriale, come beneficio per aumentare l’autonomia nelle attività della vita quotidiana (BADL) nei bambini affetti da autismo. Una revisione della letteratura, Tesi in Ergoterapia, Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana.
- Grieco JC, Bahr RH, Schoenberg MR, Conover L, Mackie LN & Weeber EJ (2018), Quantitative Measurement of Communication Ability in Children with Angelman Syndrome. J Appl Res Intellect Disabil. 31(1):e49-e58.
- Griffin Occupational Therapy (2020), What is Sensory Processing Disorder (SPD)?. Disponibile on-line all’indirizzo https://www.griffinot.com/sensory-processing-disorder/.
- Grussu A (2016), L’esperienza culturale e relazionale nell’apprendimento nella prospettiva teorica di l. S. Vygotskij. Disponibile on-line all’indirizzo: https://www.alessandrogrussu.it/txt/Vygotskij.pdf.
- Harlow H F (1959), Love in Infant. Monkeys., 200(6), 68–74.
- Heald M, Adams D & Oliver C (2019), Profiles of atypical sensory processing in Angelman, Cornelia de Lange and Fragile X syndromes. J Intellect Disabil Res. 64(2):117-130.
- Heald M, Adams D, Walls E & Oliver C (2021), Refining the Behavioral Phenotype of Angelman Syndrome: Examining Differences in Motivation for Social Contact Between Genetic Subgroups. Front Behav Neurosci; 15:618271.
- IAPB Italia Onlus (2022), Lo sviluppo degli occhi nell’utero materno, Disponibile on-line all’indirizzo: https://iapb.it/lo-sviluppo-degli-occhi-nellutero-materno/.
- ICD-11 (2023), LD90.0 Angelman syndrome. Disponibile on-line all’indirizzo: https://icd.who.int/browse11/l-m/en#/http://id.who.int/icd/entity/1106558408 Consultato il 26/07/23.
- Jorquera-Cabrera S, Romero-Ayuso D, Rodriguez-Gil G & Triviño-Juárez JM (2017), Assessment of Sensory Processing Characteristics in Children between 3 and 11 Years Old: A Systematic Review. Front Pediatr; 5:57.
- Krishnan K N & Travnik A., (n.d), Guide to Sensory Processing. Disponibile on-line all’indirizzo https://hospital.uillinois.edu/a/6955.
- Lanciano T (2022), Slide Power Point della lezione “Sensazione e percezione”, del corso Psicologia generale, Università degli studi di Bari Aldo Moro. Disponibile on-line all’indirizzo: https://www.uniba.it/it/ricerca/dipartimenti/scienze-politiche/docenti/lanciano-tiziana/slides/.
- Lane SJ, Mailloux Z, Schoen S, Bundy A, May-Benson TA, Parham LD, Smith Roley S & Schaaf RC (2019), Neural Foundations of Ayres Sensory Integration®. Brain Sci; 9(7):153.
- Litovsky R (2015), Development of the auditory system. Handb Clin Neurol; 129:55-72.
- Magli A & Esposito F (2012), Lo sviluppo delle funzioni visive nei primi tre anni di vita: impatto con la patologia, Società italiana di medicina preventiva e sociale corso: la prevenzione in oftalmologia pediatrica. Disponibile on-line all’indirizzo: https://www.sipps.it/pdf/1caserta2012/esposito.pdf.
- Margolis SS, Sell GL, Zbinden MA & Bird LM (2015), Angelman Syndrome. Neurotherapeutics; 12(3):641-50.
- Martini F H, Tallitsch R B & NathJ L (2019), Sistema nervoso: sensibilità generale e specifica. In Cocco L, Gaudio E, Manzoli L, Zummo G, Anatomia umana, EdiSES Università, Napoli
- Marx V & Nagy E (2017), Fetal behavioral responses to the touch of the mother's abdomen: A Frame-by-frame analysis. Infant Behav Dev; 47:83-91.
- Medline (2022), UBE3A gene. Disponibile on-line all’indirizzo: https://medlineplus.gov/genetics/gene/ube3a/#:~:text=Normal%20Function&text=The%20UBE3A%20gene%20provides%20instructions,proteins%20that%20should%20be%20degraded. Consultato il 26/07/2023.
- Mercuri E, Cioni G & Fazzi E (2005), Cosa vede il mio bambino. Consigli per lo sviluppo delle capacitàvisive nel primo anno di vita. Fondazione Pierfranco e Luisa Mariani, Milano.
- Metz AE, Boling D, DeVore A, Holladay H, Liao JF & Vlutch KV (2019), Dunn's Model of Sensory Processing: An Investigation of the Axes of the Four-Quadrant Model in Healthy Adults. Brain Sci; 9(2):35.
- Micheletti S, Palestra F, Martelli P, Accorsi P, Galli J, Giordano L, Trebeschi V & Fazzi E (2016), Neurodevelopmental profile in Angelman syndrome: more than low intelligence quotient. Ital J Pediatr; 42(1):91.
- Michieletto P, Bonanni P & Pensiero S (2011), Ophthalmic findings in Angelman syndrome. J AAPOS. 158-61.
- Miller LJ, Nielsen DM, Schoen SA & Brett-Green BA (2009), Perspectives on sensory processing disorder: a call for translational research. Front Integr Neurosci; 3:22.
- Miller LJ, Schoen SA, James K & Schaaf RC (2007), Lessons learned: a pilot study on occupational therapy effectiveness for children with sensory modulation disorder. Am J Occup Ther; 61(2):161-9.
- Ministero della Salute (2017), Organizzazione Mondiale Sanità. Disponibile on-line all’indirizzo: https://www.salute.gov.it/portale/rapportiInternazionali/dettaglioContenutiRapportiInternazionali.jsp?area=rapporti&id=1784&lingua=italiano&menu=mondiale#:~:text=Secondo%20la%20Costituzione%20dell'OMS,assenza%20di%20malattie%20o%20infermit%C3%A0%E2%80%9D.
- Montagu A (2015), Il linguaggio della pelle. Il senso del tatto nello sviluppo fisico e comportamentale del bambino. Verdechiaro
- Morelli De Rossi R (2020), slide Power Point del corso Psicologia generale dell’età evolutiva, Università di Padova.
- Murgia M (n.d.), Slide Power Point della lezione “Percezione”, del corso Psicologia generale, Università degli Studi di Trieste. Disponibile on-line all’indirizzo: file:///C:/Users/Utente/Downloads/2_Psi_gen_percezione.pdf.
- Orphanet (n.d.), Sindrome di Angelman. Disponibile on-line all’indirizzo: https://www.orpha.net/consor4.01/www/cgi-bin/Disease_Search.php?lng=IT&data_id=90&Disease_Disease_Search_diseaseGroup=angelman&Disease_Disease_Search_diseaseType=Pat&Malattia(e)/%20gruppo%20di%20malattie=Sindrome-di-Angelman&title=Sindrome%20di%20Angelman&search=Disease_Search_Simple Consultato il 26/07/2023
- Pearson E, Wilde L, Heald M, Royston R & Oliver C (2019), Communication in Angelman syndrome: a scoping review. Dev Med Child Neurol; 61(11):1266-1274.
- Peters SU, Horowitz L, Barbieri-Welge R, Taylor JL &Hundley RJ (2011), Longitudinal follow-up of autism spectrum features and sensory behaviors in Angelman syndrome by deletion class. J Child Psychol Psychiatry; 53(2):152-9.
- Pfeiffer BA, Koenig K, Kinnealey M, Sheppard M & Henderson L (2011), Effectiveness of sensory integration interventions in children with autism spectrum disorders: a pilot study. Am J Occup Ther; 65(1):76-85.
- Poma S (2016), Modelli di analisi per l’integrazione multisensoriale, Progetto di tesi in ingegneria biomedica, Alma Mater Studiorum - Università di Bologna.
- Presidio della rete Regionale Malattie rare della Regione Campania (n.d.), Cosa sono le malattie rare. Disponibile on-line all’indirizzo: https://www.policlinico.unina.it/siti/MR/cosasono.html#:~:text=L'Unione%20Europea%20definisce%20tale,si%20attiene%20a%20tale%20definizione Consultato il 26/07/2023.
- Purpura G & Tinelli F (2020), The development of vision between nature and nurture: clinical implications from visual neuroscience. Childs Nerv Syst; 36(5):911-917.
- Rizzo R (2020), Imprinting Genomico, Corso di Biotecnologie mediche, Università di Ferrara. Disponibile on-line all’indirizzo: https://www.unife.it/medicina/biotecnologie-mediche/insegnamenti/Microbiologia-e-Genetica/materiale-didattico/genetica-umana-e-medica-lezioni-2020
- Roley S S, Mailloux Z, Miller-Kuhaneck H & Glennon T (2007). Understanding Ayres’ Sensory Integration. Disponibile on-line all’indirizzo: https://works.bepress.com/heather_kuhaneck/7/.
- Ruotolo F (2021), slide di Power Point della prima lezione “Percezione”, del corso di psicologia generale, Università degli studi della Campania Luigi Vanvitelli. Disponibile on-line all’indirizzo: https://www.psicologia.unicampania.it/didattica/fit-percorso-24-cfu#psicologia-generale-2.
- Russo R C (2018), Il significato dell’intervento psicomotorio. In Russo R C “Psicomotricità. Nuovo approccio valutativo e intervento globale: terapia psicomotoria, sostegno genitoriale, collaborazione sociale”. C.E.A., Milano.
- Russo S (2021), Integrazione sensoriale ed elaborazione sensoriale. Disponibile on-line all’indirizzo: https://www.psicologiapediatrica.it/integrazione-sensoriale-ed-elaborazione-sensoriale%E2%80%A8/.
- Samanta D (2021), Epilepsy in Angelman syndrome: A scoping review. Brain Dev; 43(1):32-44.
- Saviani A (2020), Slide di Power Point “Lo sviluppo percettivo”, dal corso di Psicologia dello Sviluppo, Università Milano-Bicocca. Disponibile on-line all’indirizzo: https://www.studocu.com/it/document/universita-degli-studi-di-milano-bicocca/psicologia-dello-sviluppo/12-lo-sviluppo-percettivo/8499913.
- Savini P (2021), Slide del corso di “Osservazione e valutazione psicomotoria”, lezione “F) setting”, del corso “Terapia psicomotoria”, Università di Padova.
- Savini P (2022), Slide Power Point “Categorie Analogiche”, del Corso “Osservazione e valutazione psicomotoria”, Università degli Studi di Padova.
- Schaaf RC & Davies PL (2010), Evolution of the sensory integration frame of reference. Am J Occup Ther; 64(3):363-7.
- Schaaf RC & Miller LJ (2005), Occupational therapy using a sensory integrative approach for children with developmental disabilities. Ment Retard Dev Disabil Res; 11(2):143-8.
- Summers J A & Feldman M A (1999), Distinctive pattern of behavioral functioning in Angelman syndrome. American Journal of Mental Retardation, 104, 376–384.
- Takaesu Y, Komada Y & Inoue Y (2012), Melatonin profile and its relation to circadian rhythm sleep disorders in Angelman syndrome patients. Sleep Med; 13(9):1164–1170.
- Tan WH, Bacino CA, Skinner SA, Anselm I, Barbieri-Welge R, Bauer-Carlin A, Beaudet AL, Bichell TJ, Gentile JK, Glaze DG, Horowitz LT, Kothare SV, Lee HS, Nespeca MP, Peters SU, Sahoo T, Sarco D, Waisbren SE & Bird LM (2011), Angelman syndrome: Mutations influence features in early childhood. Am J Med Genet A; 155A(1):81-90.
- Telethon (2021), Sindrome di Angelman. Disponibile on-line all’indirizzo: https://www.telethon.it/cosa-facciamo/ricerca/malattie-studiate/sindrome-di-angelman. Consultato in data 26/07/2023.
- Treccani (2010), Percezione. Disponibile on-line all’indirizzo: https://www.treccani.it/enciclopedia/percezione_%28Dizionario-di-Medicina%29/.
- Treccani (n.d.), Sensazione. Disponibile on-line all’indirizzo: https://www.treccani.it/enciclopedia/sensazione/.
- Università degli studi della Basilicata (2021), L’ICF come modello bio-psico-sociale, Dipartimento di Scienze Umane, Programma d’insegnamento: Pedagogia e didattica speciale Percorso CFU 24.
- Viri M (2021), Quadro clinico e aspetti neurologici, in Fast, La Sindrome di Angelman.
- Walz N C & Benson B A (2002), Behavioral phenotypes in children with Down syndrome, Prader-Willi syndrome, Angelman syndrome, or nonspecific mental retardation. Journal of Developmental and Physical Disabilities, 14, 307– 321.
- Walz NC & Baranek GT (2006), Sensory processing patterns in persons with Angelman syndrome. Am J Occup Ther; 60(4):472-9.
- Wille A & Ambrosini C (2010), Manuale di terapia psicomotoria dell’età evolutiva. Cuzzolin.
- Williams CA, Beaudet AL, Clayton-Smith J, Knoll JH, Kyllerman M, Laan LA, Magenis RE, Moncla A, Schinzel AA, Summers JA & Wagstaff J (2006), Angelman syndrome 2005: updated consensus for diagnostic criteria. Am J Med Genet A; 140:413–18.
- Zori RT, Hendrickson J, Woolven S, Whidden EM, Gray B & Williams CA (1992), Angelman syndrome: clinical profile. J Child Neurol; 7(3):270-80.
- Zumiani R (2014), Lo sviluppo nel non vedente, Una bussola per orientarsi, Giornale UICI. Disponibile on-line all’indirizzo: https://giornale.uici.it/una-bussola-per-orientarsi-sviluppo-nel-non-vedente-di-roberta-zumiani/.
ALLEGATI
Allegato 1
SCHEDA DI OSSERVAZIONE E VALUTAZIONE SENSORIALE DEL BAMBINO CON SINDROME DI ANGELMAN
Nome_____________________________________________________________ Cognome__________________________________________________________
Data di nascita___/____/_____
Anamnesi__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Nome del terapista della neuro e psicomotricità____________________________
Data dell’osservazione___/____/____
Note da allegare____________________________________________________
_________________________________________________________________
MATERIALI
|
Adattamento visivo |
Adattamento uditivo |
Adattamento tattile |
|
|
Ventose |
Ventosa con pattern bianchi e neri Ventosa con volto stilizzato |
Ventosa con sonaglio |
Ventosa morbida Ventosa ruvida |
|
Riccio |
Aculei a forte contrasto |
Aculei con sonaglio |
Aculei morbidi Aculei ruvidi |
|
Palline + scatola di cartone con buco centrale |
Palla con luce all’interno |
Palla con sonaglio |
Palla liscia Palla ruvida Palla fredda Palla calda |
SETTING E MODALITA’ DI PROPOSTA
Le diverse proposte vengono presentate una per volta, differenziando il setting a livello spaziale e temporale e strutturando il materiale in modalità differenti l’uno dall’altro.
Ventose: le ventose, adattate per i 3 tipi di sensorialità che la scheda indaga, vengono proposte su una superficie verticale es. specchio, in modo da favorire i passaggi posturali. L’altezza è variabile a seconda del bambino e delle sue competenze motorie. Importante dopo una prima osservazione, provare a cambiare l’ordine spaziale delle ventose per evitare che la risposta del bambino venga condizionata da altri fattori, quali: rapidità nella risposta, vicinanza del target e/o preferenza spaziale. Proporre contemporaneamente tutti i target, avendo cura che siano posizionati tutti alla stessa altezza.
L’esaminatore deve attendere la risposta del bambino e il suo orientamento verso il target, può, però, fornire una guida fisica e/o verbale, per far capire al bambino come avviare lo schema motorio. Si posiziona di lato al bambino, per poter interagire con lui, se e quando il bambino attiva risposte relazionali e emotive.
Riccio: il riccio viene proposto a tappeto, in uno spazio preferibilmente contenuto e libero da altri stimoli, che possono distrarre il bambino. Si presenta, quindi, con il bambino seduto, preferibilmente in long sitting, e con il gioco posto di fronte a lui, in modo da facilitare il movimento di prensione e l’afferramento.
L’esaminatore si posiziona di fronte al bambino, seduto a tappeto. Presenta il target e favorisce i diversi schemi di movimento attraverso la guida verbale e fisica, se necessaria, o attraverso l’imitazione. È chiamato a relazionarsi con il bambino, rispondendo ai comportamenti emotivi e sociali che il bambino mette in atto, durante l’attività.
Palline: l’attività delle palline e della scatola di cartone viene presentata in uno spazio privo di altri stimoli e vuoto, per incentivare il movimento e lo spostamento, in modo prevalente. Il bambino infatti deve essere nelle condizioni di potersi muovere liberamente nello spazio e di poter raggiungere il target che preferisce, nelle modalità a lui più consone. È importante, però, avere la possibilità di poter posizionare la scatola di cartone, con il buco per fare canestro, a diverse altezze e quindi usufruire di diversi piani dello spazio, per favorire i passaggi posturali e l’orientamento spaziale, non solo orizzontale ma anche verticale. Le palline, adattate in modo che ognuna possa rappresentare una tipologia di sensorialità diversa, vengono proposte inizialmente una alla volta, per poter osservare come il bambino si comporta e successivamente di più contemporaneamente, favorendo in questo modo l’emergere di una scelta binaria. Lo scatolone, inoltre, va proposto anche per favorire risposte cognitive, quali la permanenza dell’oggetto, e di schemi d’azione semplici, come mettere dentro e tirare fuori, è importante quindi dedicare del tempo anche a proposte di tipo cognitivo e relazionale posizionando, nello spazio, lo scatolone all’altezza del bambino, in modo tale che quest’ultimo sia capace di interagire con la scatola e di utilizzarla come canestro.
L’esaminatore deve presentare i diversi target uno alla volta, posizionandoli in un secondo momento a diverse altezze e in diversi piani dello spazio, per favorire lo spostamento e l’orientamento. Si deve porre come partner di relazione e di gioco, favorendo lo scambio relazionale e emotivo, attraverso scambi e giochi di interazione. Inoltre, deve essere un iniziale modello per il bambino, mostrando le possibilità d’azione con la scatola e la palla, come mettere dentro e tirare fuori, proporre attività di permanenza dell’oggetto o di scelta binaria, sempre incoraggiando e guidando il bambino con la voce e il proprio assetto posturale.
SCHEDA
Compilare la scheda indicando, secondo la legenda (A1, A2, A3, B1, B2, C1, C2, C3, C4, D, NV), qual è il target sensoriale che maggiormente ha attivato nel bambino una risposta. È possibile, poi, aggiungere delle considerazioni qualitative sull’osservazione, nello spazio finale dedicato alle note.
Legenda:
- Target visivo
- Pattern luminoso
- Pattern bianco/nero
- Alto contrasto
- Target uditivo
- Target a bassa frequenza
- Target ad alta frequenza
- Target tattile
- Target morbido
- Target ruvido
- Target caldo
- Target freddo
- Non significativamente rilevabile
NV. Non valutabile
|
ITEM |
A1 |
A2 |
A3 |
B1 |
B2 |
C1 |
C2 |
C3 |
C4 |
D |
NV |
|
1. Richiama l’attenzione del partner |
|||||||||||
|
2. Instaura l’attenzione condivisa |
|||||||||||
|
3. Uso protesico dell’adulto |
|||||||||||
|
4. Pointing richiestivo |
|||||||||||
|
5. Pointing dichiarativo |
|||||||||||
|
6. Modifica la mimica facciale |
|||||||||||
|
7. Attua semplici schemi di turnazione |
|||||||||||
|
8. Accenna schemi di imitazione (espressioni facciali, suoni vocalici, gesti codificati e non) |
|||||||||||
|
9. Modula il tono |
|||||||||||
|
10. Aumenta l’intento comunicativo |
|||||||||||
|
11. Aumenta la possibilità di comunicare attraverso gesti codificati e non |
|||||||||||
|
12. Aumenta la possibilità di comunicare verbalmente |
|||||||||||
|
13. Fissazione e inseguimento |
|||||||||||
|
14. Maggior investimento dell’esplorazione manipolatoria |
|||||||||||
|
15. Migliora la coordinazione occhio-mano |
|||||||||||
|
16. Migliora la coordinazione bimanuale |
|||||||||||
|
17. L’afferramento risulta più deciso, sicuro e orientato |
|||||||||||
|
18. Adatta la presa al target |
|||||||||||
|
19. Amplia i suoi schemi di azione di motricità fine (es. girare, lanciare, infilare, mettere dentro/tirare fuori) |
|||||||||||
|
20. Attua i passaggi posturali in modo funzionale e adeguato per età |
|||||||||||
|
21. Attua spostamenti pre/locomotori |
|||||||||||
|
22.Orienta la sua attenzione e le sue azioni verso il target |
|||||||||||
|
23.Localizza e raggiunge il target |
|||||||||||
|
24. Mantiene l’attenzione per una lunga durata |
|||||||||||
|
25. Riduzione dei tempi di latenza |
|||||||||||
|
26. Capacità di attesa |
|||||||||||
|
27.Riduzione dell’esplorazione orale |
|||||||||||
|
28. Permanenza dell’oggetto |
|||||||||||
|
29. Scelta binaria o tra più oggetti |
|||||||||||
|
30. Comprende la relazione di casualità tra gli oggetti |
NOTE:__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
N.B.
Per questioni di tempi, è probabile che per il momento la presente tesi sia stata inserita parzialmente o in formato immagine. Al più presto completeremo l'inserimento rispettando i canoni da noi prefissati, ovvero editando direttamente il testo nei diversi articoli del portale.
30/04/2022 - Redazione web