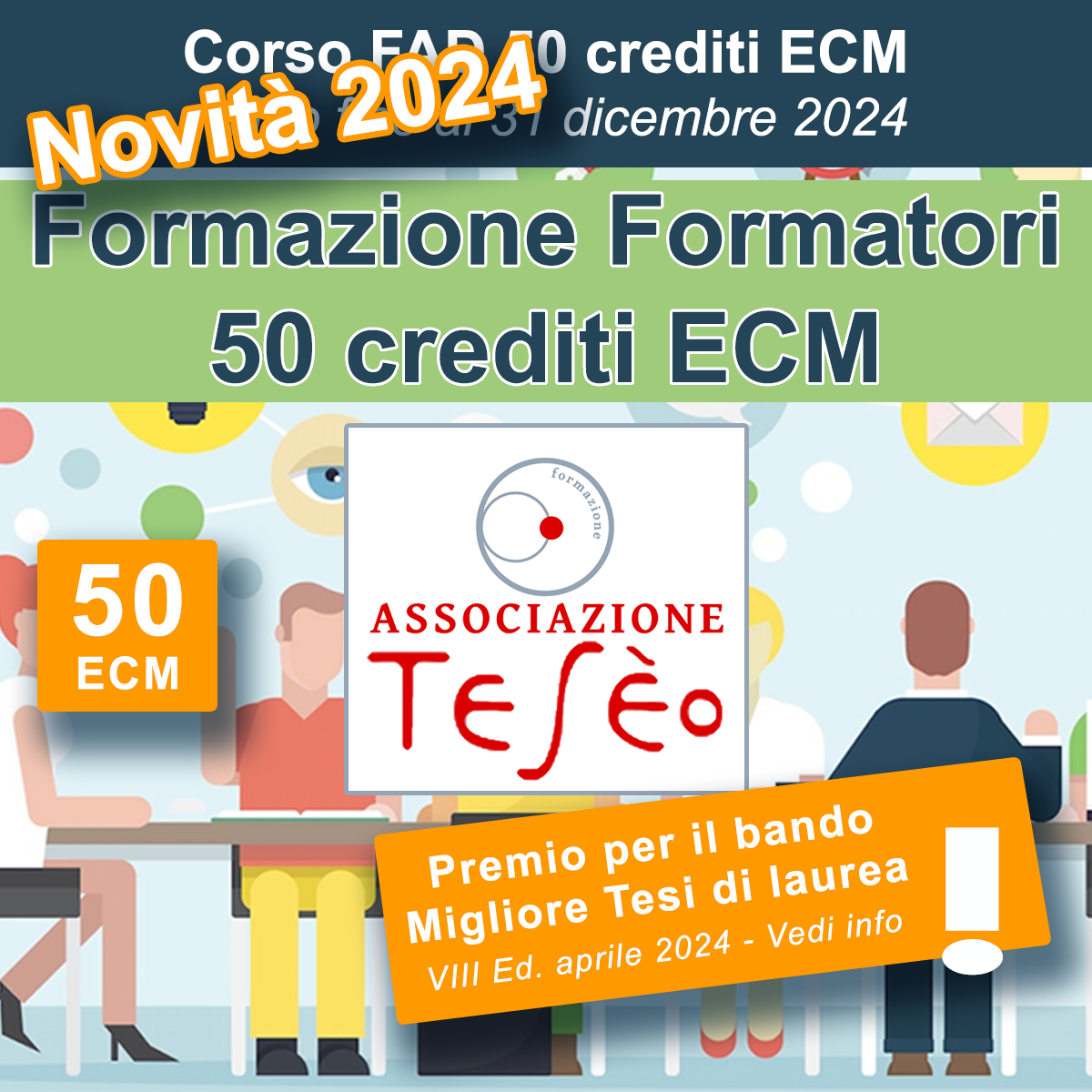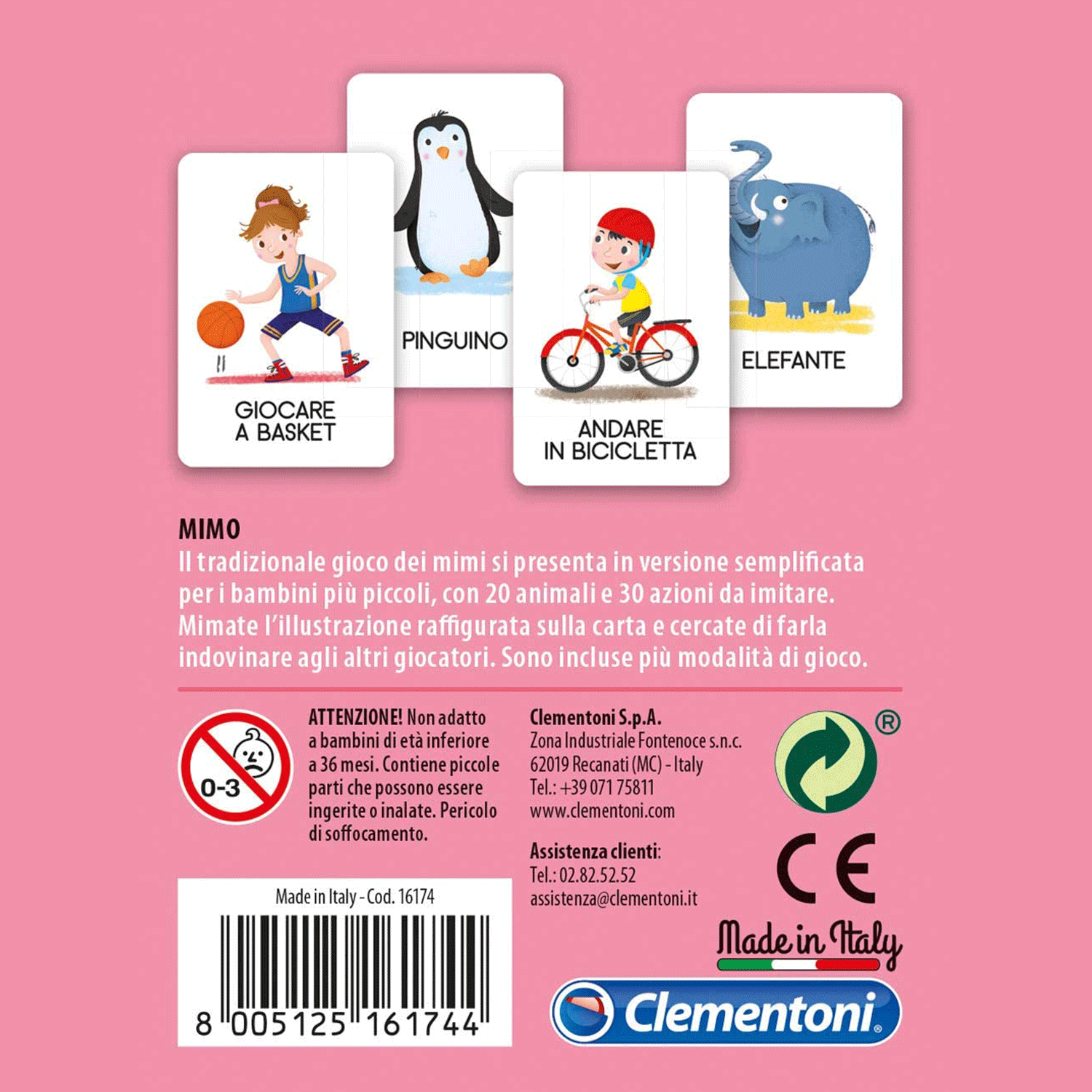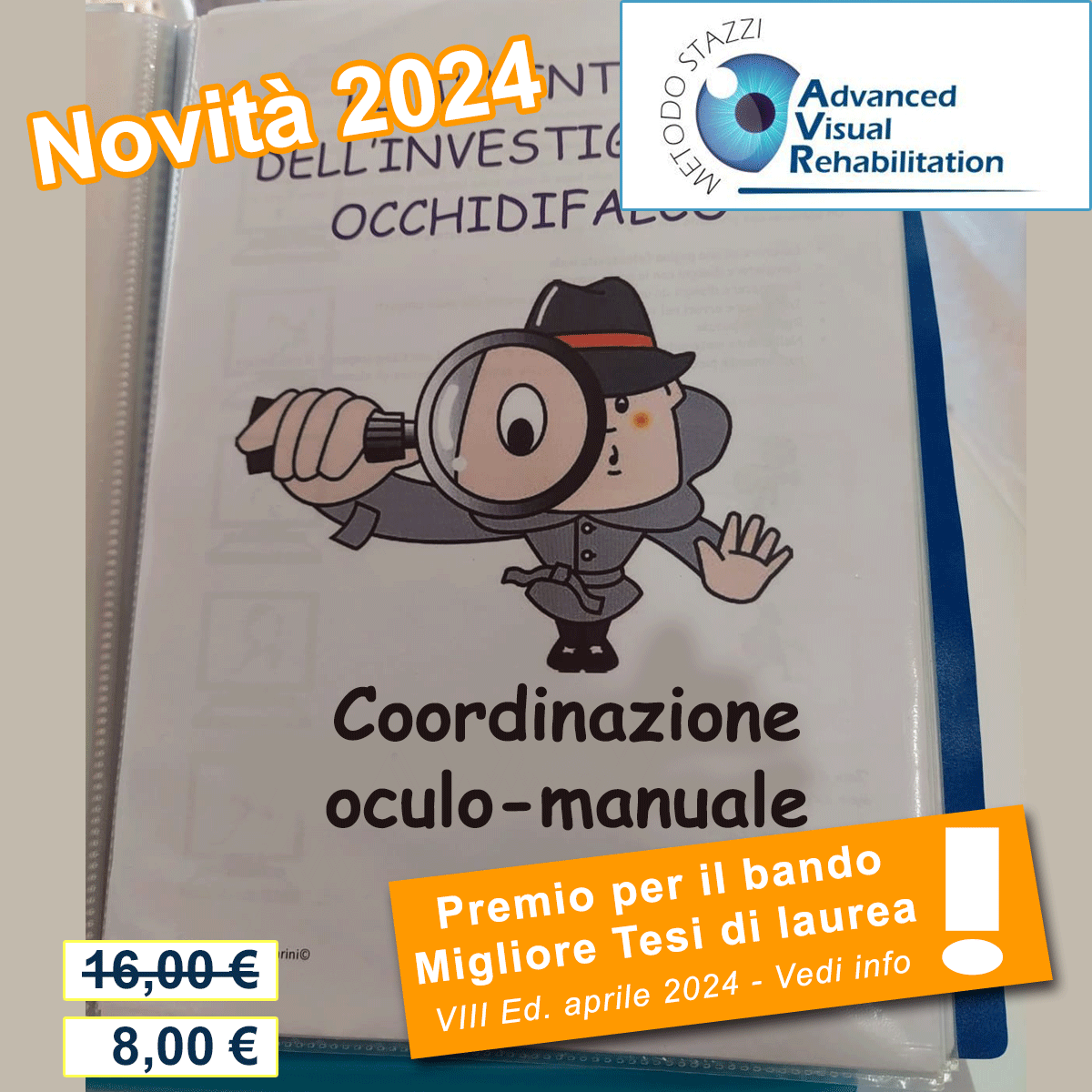CONCLUSIONI - La variazione dello stato comportamentale del bambino in risposta agli stimoli sonori in TIN
Sin dai primi rilevamenti, è possibile notare che l’inquinamento acustico, frutto di tanti fattori combinati, sia ovunque nettamente superiore a quanto consigliato da tutti gli studi riferibili alla care in TIN. Le percentuali estrapolate nella parte di studio riguardante le variazioni dello stato comportamentale del neonato, ci inducono a riflettere sulla significatività del problema.
I dati emersi permettono di identificare delle forti correlazioni tra alcuni eventi e i relativi effetti, tanto da lasciar intravedere la possibilità di porre sin da subito alcuni interventi correttivi e di sensibilizzazione, al fine di mitigare gli effetti su pazienti, operatori e genitori. Si consiglia quindi, in grande sintesi, di:
- Sensibilizzare il personale e i genitori al fine di far comprendere loro il fatto che la voce arrivi poco attenuata ai piccoli pazienti in culla e che quindi, riuscire a contenere il livello dei dialoghi, potrebbe dare un importante contributo al comfort del bambino. Al contempo, istruire il personale potrebbe favorire il contenimento di rumori impulsivi molto forti quali: la chiusura troppo energica delle porte, l’eccessiva apertura dell’acqua del rubinetto, la caduta di oggetti dalle mani, il brusco inserimento di materiale da buttare negli appositi contenitori, ecc. (legati ad errori del personale). Isabelle Milette, a tal proposito, ha pubblicato nel 2010 uno studio condotto in una TIN del Canada, avente un duplice scopo: misurare i livelli di suono presenti nella Tin e valutare l’impatto di un programma educativo di sensibilizzazione alla problematica del rumore. L’intervento educativo ha previsto due settimane di lezioni frontali giornaliere. Al termine di ogni giorno, veniva sottoposto al genitore un questionario di gradimento, attraverso il quale era possibile esporre suggerimenti personali. Inoltre, nell’unità operativa: vi erano dei poster che illustravano il programma attivato; erano stati incentivati gli operatori a posizionare i loro cercapersone sulla modalità di vibrazione; erano stati distribuiti volantini informativi a tutti coloro che avevano accesso in TIN; infine, il personale aveva indossato una spilla che riportava “Noise Aware” (consapevole del rumore). Ha partecipato al programma educativo, l’82% delle persone, indice di un certo impegno nel volersi sensibilizzare alla problematica. L’autrice riporta che, in un’analisi a lungo termine, vi sia stata una riduzione statisticamente significativa (p>0.0001) dei livelli di rumore in Tin. Infatti, una maggior presa di coscienza rispetto al problema, favorisce l’adozione di un loro nuovo modus operandi. Per concludere, se il contenimento del rumore viene affrontato come un obiettivo da raggiungere, attraverso la pianificazione di specifiche azioni di miglioramento ed il loro monitoraggio nel tempo, è possibile raggiungere livelli ragguardevoli.
- Ridurre a livello minimo la suoneria dei monitor, la quale contribuisce a creare disturbo nel bambino oltre che a generare inutilmente uno stress su operatori e genitori. La grande riflettività della stanza, infatti, renderebbe già di per sé maggiormente udibile anche l’allarme alla minima intensità. Ci si aspetta, inoltre, che in un ambiente caratterizzato da allarmi più silenziosi, ci sia anche un abbassamento dei livelli di voce.
- Introdurre un sistema di monitoraggio del livello di pressione sonora che indichi, qualora necessario, agli occupanti della stanza, che si sta entrando nella fascia d’inquinamento sonoro. Il sistema di monitoraggio si occuperebbe anche di memorizzare i livelli di pressione sonora rilevati 24 ore su 24 in modo tale da permettere l’esecuzione di analisi integrate, su periodi più lunghi, e la misura di eventuali miglioramenti ottenuti nel tempo, dopo aver introdotto nuove procedure d’intervento. (McMahon et al., 2012; Ramesh et al., 2009).
- Ridurre al minimo la rumorosità delle macchine e dei sistemi, soprattutto per quanto riguarda la distribuzione dei gas (sdoppiatori ed eventuali raccordi difettosi), gli umidificatori e simili. Soprattutto si consiglia di prestare attenzione alle fonti di rumore evitabili, come aspirazioni lasciate aperte o macchine lasciate accese malgrado non siano utilizzate. Pensare all’eventuale possibilità di effettuare un impianto di riscaldamento a pavimento, per evitare che si crei un substrato di rumore di fondo elevato, causato primariamente da questo.
- Favorire l’attenuazione dell’inquinamento acustico del corridoio, troppo contiguo alle aree di degenza e senza barriere di contenimento. Parallelamente, posizionare i lettini dei degenti ad un’adeguata distanza da questo tipo di fonti di rumore e da altre, quali i lavandini, bocchettoni del riscaldamento/aria condizionata, porte di passaggio, etc.
- Aumentare il livello di attenzione al contenimento dei rumori nelle aree in cui i piccoli pazienti sono in culla aperta, soprattutto per quanto riguarda gli allarmi, i quali non risulterebbero più filtrati dalle pareti della termoculla.
Per quanto riguarda l’allestimento delle stanze di degenza, è stato condotto uno studio di revisione della letteratura, in cui si forniscono una serie di strategie (e, parallelamente, il loro razionale) per il contenimento del rumore (Bremmer et al.,2003). Possibili strategie preventive potrebbero essere quelle di: installare del materiale fonoassorbente sui pavimenti che non ne sono stati dotati al momento della costruzione, al fine di attenuare il suono prodotto mentre si cammina; installare porte a scorrimento, per bloccare i suoni esterni; collocare i lavelli lontani dalle postazioni dei neonati, per ridurre il traffico di persone intorno ad essi; apporre dei tendaggi alle finestre, affinché aiutino ad assorbire il rumore esterno; dotare tutti gli arredi e le porte di guarnizioni/feltrini, al fine di ridurre il rumore provocato dall’apertura o chiusura di porte e sportelli e dal contatto tra arredi e pavimento; collocare i telefoni ed i citofoni all’esterno della stanza di degenza, o ancora, posizionare l’impianto di condizionamento dell’aria ed i relativi flussi ad un’adeguata distanza rispetto alla postazione del degente.
L’utilizzo dei paraorecchie o dei tappi di silicone, individuati come possibili strategie per ridurre l’esposizione all’eccessivo rumore, ha riscontrato scarse adesioni e questo potrebbe essere dovuto al fatto che, l’applicazione di questi presidi, riduce sì l’esposizione al rumore (Duran et al., 2012; Abou Turk et al., 2009), ma al contempo rappresenta una deprivazione sensoriale per il neonato (seppur parziale e limitata nel tempo). Uno dei cinque sensi, l’udito per l’appunto, verrebbe meno, il che potrebbe costituire un rischio per lo sviluppo sano del piccolo (McMahon et al., 2012).
In generale, la letteratura suggerisce l’adozione di un approccio assistenziale “care” che riduca le stimolazioni stressanti nei confronti dei neonati ricoverati in Tin e che preveda comportamenti che comprendono: il parlare ad un tono di voce basso nelle vicinanze di un neonato; il passaggio di informazioni tra i diversi operatori ad una distanza adeguata rispetto alla postazione del neonato; la condivisione e la pianificazione dei tempi e delle modalità delle manovre clinico-assistenziali per ridurre e contenere le stimolazioni stressanti; l’implementazione dei periodi silenziosi della giornata, durante i quali tutte le attività di intervento sono ridotte al minimo per permettere ai neonati di riposare (Bremmer at al., 2003; Brown, 2009; Johnson, 2003). Una delle possibili proposte assistenziali per il contenimento dello stress è il Newborn Individualized Develpmental Care and Assessment Program (NIDCAP) una metodologia basata sull’osservazione dei comportamenti del neonato, che consente di individuarne i segnali di stress e di definirne un programma di assistenza individualizzata incentrata sullo sviluppo, attraverso il coinvolgimento dei principali caregivers, i genitori. L’approccio NIDCAP, infatti, considera i neonati pretermine, quali individui particolarmente vulnerabili ed esposti ad un’eccessiva stimolazione sensoriale da parte dell’ambiente Tin e, tra gli elementi chiave per implementare un’assistenza sicura e tutelante, include la riduzione dello stress ambientale, dovuto sia alla luce sia al rumore (Vandenberg, 2007).
Indice |
| INTRODUZIONE |
|
Parte prima: inquadramento teorico: ESPERIENZA UDITIVA - LO SVILPUPPO DEL SISTEMA UDITIVO: IL FETO E IL NEONATO PREMATURO - LE FONTI DEL RUMORE - ALCUNE DEFINIZIONI FONDAMENTALI - LE CONSEGUENZE DEL RUMORE; LA TEORIA SINATTIVA DELLO SVILUPPO, Effetti a breve termine, Effetti a lungo termine - DALL’IDEA DI PREVENZIONE AL CAMBIAMENTO STRUTTURALE Parte seconda: progettazione e attuazione dello studio: SCOPO DELLO STUDIO - MATERIALI E METODI; Campione, Strumenti - DISEGNO DELLO STUDIO - RISULTATI; Studio relativo ai rumori provenienti dall’ambiente, Rilevazione dei rumori in TIN, Rilevazione dei rumori Post - TIN; Risultati relativi all’attenuazione sonora resa possibile dalla culla termica; Risultati relativi all’osservazione della variazione dello stato comportamentale del neonato - DISCUSSIONE DEI DATI - OBIETTIVI E METODI |
| CONCLUSIONI |
| BIBLIOGRAFIA |
| Tesi di Laurea di: Lisa BOLOGNESI |