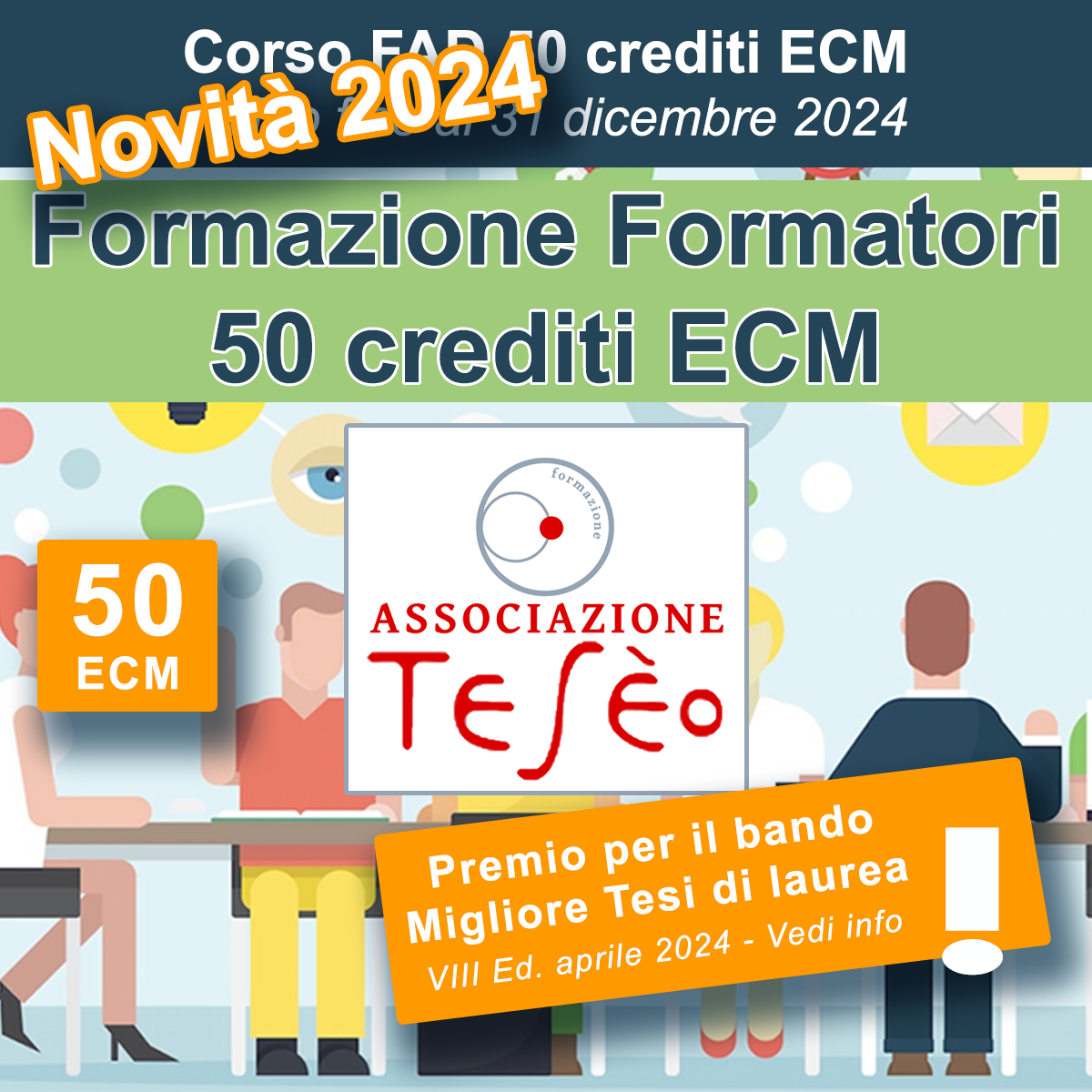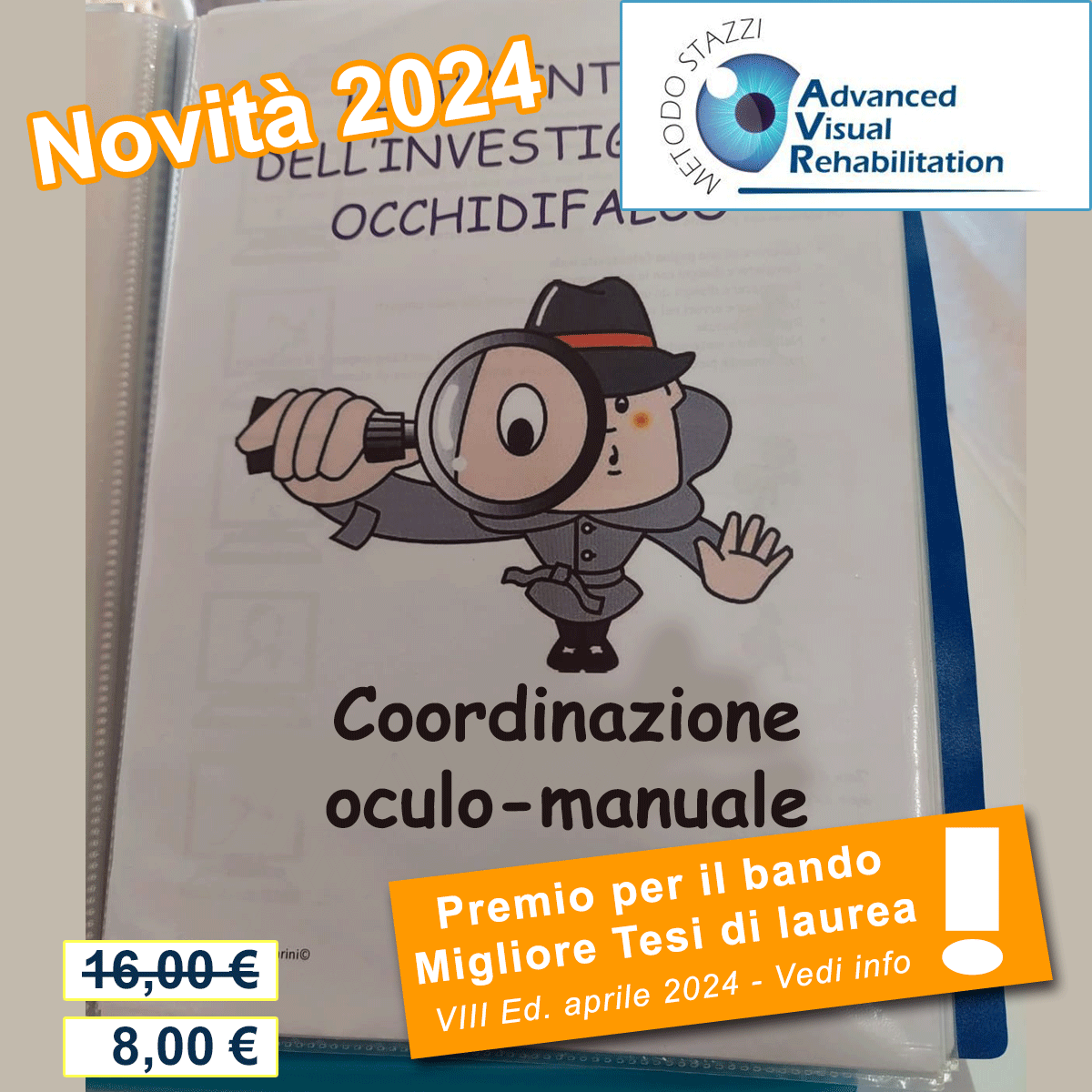Ictus e Plasticità Neuronale
Ictus
 Quando a causa di emboli e trombi il sangue non riesce ad irrorare adeguatamente il cervello, si crea un danno cerebrale dovuto all'ictus con conseguenti gradi diversi di deficit neurologici e funzionali. L'emiparesi destra o sinistra, secondo l'emisfero cerebrale danneggiato, è una frequente eventualità che si verifica perché il cervello quando è integro possiede una rappresentazione delle funzionalità del corpo, rappresentazione che viene a mancare quando il SNC è danneggiato.
Quando a causa di emboli e trombi il sangue non riesce ad irrorare adeguatamente il cervello, si crea un danno cerebrale dovuto all'ictus con conseguenti gradi diversi di deficit neurologici e funzionali. L'emiparesi destra o sinistra, secondo l'emisfero cerebrale danneggiato, è una frequente eventualità che si verifica perché il cervello quando è integro possiede una rappresentazione delle funzionalità del corpo, rappresentazione che viene a mancare quando il SNC è danneggiato.
Il fenomeno della diaschisi, rappresenta un argomento fondamentale per poter comprendere l'evoluzione di un ictus.
In seguito ad una lesione cerebrale, alcune zone del cervello vengono danneggiate direttamente dalla lesione, altre cessano di funzionare correttamente, perché coinvolte dall'edema che occupa lo spazio intorno alla lesione, mentre altre strutture, che non sono anatomicamente connesse con le zone direttamente danneggiate, vengono inibite a distanza.
Mettere a riposo il sistema è una strategia biologica di difesa, che tende ad evitare un sovraccarico delle strutture interessate dalla lesione, pertanto le aree e le strutture che non sono anatomicamente connesse con quelle lese, ma che sono ivi funzionalmente connesse, ovvero con le quali partecipano in sinergia all'interno di alcune funzioni tramite il continuo scambio di informazioni, vengono inibite.
L'inibizione avviene in quanto alcune aree del cervello non ricevono più informazioni dalle aree lese ormai rimaste "mute" a causa della lesione, e probabilmente per proteggere le stesse zone lese da un sovraccarico informativo difficilmente gestibile. All'interno della diaschisi, si ha quindi una fase acuta di shock, dove l'inibizione è molto ampia e coinvolge molte zone del cervello e dei circuiti nervosi.
È per questo motivo che in seguito ad un ictus la fase acuta è caratterizzata da una paralisi flaccida, denominata in questo modo proprio per la quasi totale impossibilità del paziente di poter muovere una metà parte del corpo, quella opposta alla lesione. Questo fenomeno prende il nome di "diaschisi", etimologicamente dal greco dia (attraverso) e schizo (divisione), "divisione attraverso", "divisione tra", la diaschisi infatti, rappresenta un processo di disconnessione e di inibizione anche a distanza tra diverse strutture cerebrali.
Non è infatti coinvolta la sola corteccia cerebrale, ma anche molte altre strutture tra cui il talamo ed il cervelletto, le cui funzioni come vedremo in seguito saranno fondamentali per l'organizzazione motoria.
La diaschisi è un fenomeno inibitorio e un fenomeno sinaptico.
Lo "sciopero" delle sinapsi rappresenta una situazione di ipoeccitabilità, ovvero una situazione in cui i processi di trasporto e mediazione delle informazioni che avviene a questo livello sono decisamente limitati.
Di fondamentale importanza per comprendere il tipo e la modalità di trattamento adeguato per un ottimale superamento della diaschisi, è che le sinapsi vengono deinibite solo attraverso stimoli semplici.
L'organismo si sta riorganizzando a livello sinaptico, c'è stato un periodo di inibizione, per evitare il sovraccarico informativo; successivamente a questo periodo di inibizione però l'organismo si trova nella necessità di fornire il terreno più fertile per la riorganizzazione e la plasticità del SNC, quindi successivamente si avrà una situazione di ipereccitabilità sinaptica, ma questa ipereccitabilità è una arma a doppio taglio.
Bisogna considerare che il problema in seguito ad un ictus non è solo motorio, il deficit motorio rappresenta solo il fenomeno visibile delle alterazioni biologiche e cognitive che il sistema nervoso centrale ha subito, infatti la stessa contrazione muscolare, rappresenta un aspetto importante del movimento, ma non l'unico.
L'organizzazione del movimento è un processo complesso alla base del quale vi è un l'attivazione dei processi mentali e cognitivi come l'attenzione, la percezione, la memoria ed altri; in molti casi sia gravi che sfumati, in seguito a lesione cerebrale ci sono delle alterazioni di questi aspetti cognitivi appena citati.
Sembra quindi ragionevole in seguito ad incidente cerebrale, coinvolgere nel trattamento riabilitativo, quelle funzioni cognitive alterate direttamente dalla lesione che indirettamente determinano le alterazioni motorie visibili.
All'interno delle varie metodiche riabilitative proposte per il paziente emiplegico e per le lesioni cerebrali in genere, l'unico approccio che prende in considerazione queste fondamentali premesse riabilitative è rappresentato dalla Riabilitazione Neurocognitiva, quella che comunemente viene definita come "Metodo Perfetti".
Spesso l'arto superiore rimane flesso, rigido e paretico, stessa cosa per l'arto inferiore rigido ed utilizzato come un "pilone" elevando l'anca per far avanzare il piede che spesso appoggerà sul suolo, non con il tallone, ma con la parte laterale ed anteriore del piede: andatura falciante. Purtroppo la causa di una motilità elementare come quella appena descritta, non è determinata solo dagli schemi elementari, ma da altri elementi cognitivi e biologici che danno forma al profilo a quella che viene definita spasticità, ovvero un fenomeno che rischia di instaurarsi se all'interno del fenomeno di diaschisi la persona viene sottoposta a stimoli e carichi eccessivi.
Cercando di tradurre quanto detto in termini riabilitativi, si può concludere dicendo che il trattamento riabilitativo deve coinvolgere i processi cognitivi, dovrà rispettare i tempi e le possibilità del malato, cercando di non strutturare la motilità elementare.
I meccanismi attraverso i quali il nostro corpo ci mette a disposizione la possibilità di poter ottenere il miglior recupero in seguito ad un danno cerebrale sono molti.
- Sinaptogenesi: creazione di nuove sinapsi
- Neurogenesi: creazione di nuovi neuroni
- Deinibizione sinaptica: superamento della diaschisi
Plasticità Neuronale
 La Plasticità è la capacità di riorganizzarsi e ristrutturarsi continuamente in funzione delle mutevoli condizioni ambientali. La plasticità è presente in tutti i vertebrati e fa del cervello l'unico organo diverso da ogni altra struttura biologica. La plasticità si riferisce al grado di flessibilità e adattabilità del cervello, ed è resa possibile dalla creazione di nuove configurazioni di connessioni sinaptiche o dalla modificazione delle connessioni esistenti, in risposta agli input provenienti dall'esterno o dall'interno del sistema (anche in seguito a lesioni).
La Plasticità è la capacità di riorganizzarsi e ristrutturarsi continuamente in funzione delle mutevoli condizioni ambientali. La plasticità è presente in tutti i vertebrati e fa del cervello l'unico organo diverso da ogni altra struttura biologica. La plasticità si riferisce al grado di flessibilità e adattabilità del cervello, ed è resa possibile dalla creazione di nuove configurazioni di connessioni sinaptiche o dalla modificazione delle connessioni esistenti, in risposta agli input provenienti dall'esterno o dall'interno del sistema (anche in seguito a lesioni).
Si ipotizzava che la plasticità neurale fosse accentuata nei primi anni di vita e scomparisse progressivamente con lo sviluppo, ma è stato dimostrato che non c'è un rapporto così lineare tra età e ampiezza della plasticità neurale.
Tuttavia, la plasticità è una proprietà che caratterizza anche il cervello dell'adulto (questa riorganizzazione è alla base del fenomeno "dell'arto fantasma": le connessioni presenti prima dell'amputazione vengono riorganizzate e riconvertite per lo svolgimento di una funzione che non avevano mai svolto in precedenza).
Gli stessi processi alla base della plasticità adattiva possono condurre, in alcuni casi, a una plasticità di tipo disadattivo e disfunzionale.
Il "periodo critico" (esistono finestre temporali nello sviluppo, durante le quali una specifica esperienza deve avvenire perché una particolare funzione si sviluppi in modo normale; es: imprinting) viene sostituito dal "periodo sensibile" (momenti nel corso dello sviluppo, durante i quali l'organismo è particolarmente sensibile a specifiche esperienze, senza escludere che queste esperienze possano continuare ad esercitare la loro influenza anche in momenti successivi dell'ontogenesi).
Meccanismi d'Azione della Plasticità
Gli effetti della deprivazione sensoriale si possono spiegare in base ai termini del principio di Hebb: questo modello di modificabilità delle sinapsi prevede che il rafforzamento delle connessioni sia dovuto alla coincidenza temporale tra le attività di scarica del neurone presinaptico e di quello postsinaptico. Ad esempio, le fibre provenienti dall'occhio aperto hanno un'attività ricca, in quanto modulata dall'esperienza visiva, che depolarizza efficacemente i neuroni corticali, mentre le fibre guidate dall'occhio deprivato hanno un'attività molto ridotta (essenzialmente costituita dall'attività spontanea della retina e del talamo), che risulta scorrelata da quella dell'altro gruppo e non è sufficiente a oltrepassare la soglia di attivazione della corteccia. Questo fa sì che un'appropriata coincidenza temporale tra l'attività afferente e quella corticale abbia luogo solo a livello delle sinapsi che veicolano l'informazione in ingresso dall'occhio aperto, determinando il conseguente potenziamento di queste ultime a scapito di quelle dell'occhio deprivato. È stato suggerito il coinvolgimento nella plasticità corticale dei fenomeni di plasticità sinaptica che vengono definiti potenziamento a lungo termine e depressione a lungo termine; questo punto, tuttavia, è ancora molto dibattuto. Alcuni esperimenti, inoltre, hanno suggerito che i sistemi di neuromodulazione a proiezione diffusa del tronco dell'encefalo, in particolare quelli dell'acetilcolina, della noradrenalina e della serotonina, esercitino un ruolo di facilitazione sulla plasticità corticale. Una volta innescati dall'attività elettrica, i processi di plasticità neuronale si attuano tramite l'attivazione di una serie di proteine intracellulari, che possono regolare localmente l'inserzione di nuovi recettori nella membrana dei neuroni postsinaptici o determinarne la rimozione, causando rispettivamente un rapido aumento o una riduzione della risposta sinaptica. L'attivazione della trascrizione genica e la sintesi di nuove proteine sono necessarie per rendere permanenti le modificazioni dell'efficacia sinaptica e per realizzare i cambiamenti morfologici alla base dei fenomeni di plasticità. Questa riorganizzazione anatomica è accompagnata dall'induzione dell'attività proteolitica di alcuni enzimi, finalizzata a degradare alcune componenti della matrice extracellulare, che, esercitando la loro funzione di supporto e ancoraggio dei neuroni, fungono da fattori inibitori per la dinamicità sinaptica.
Plasticità in seguito ad una Lesione
Uno dei fenomeni della plasticità neuronale è conosciuto come sprouting, tradotto come gemmazione o germogliazione, ed il termine rende l'idea di quello che accade al neurone, infatti se interrotto in prossimità dei suoi collegamenti al muscolo è in grado di germogliare nuovi terminali su di esso o addirittura creare dei collaterali per collegarsi ai neuroni adiacenti che subiscono una degenerazione.
Sembrerebbe che la perfezione del nostro organismo abbia definito che sia la stessa lesione o degenerazione a creare il microambiente favorevole per stimolare lo sprouting, ed è lo stesso microambiente che in recenti studi sembra stimolare anche la neurogenesi, ovvero la creazione di nuovi neuroni.
Plasticità a Distanza della Lesione
La plasticità neuronale avviene in prossimità della lesione, ma nel corso degli anni gli studi sulla plasticità sono stati molti ed hanno dimostrato che la plasticità avviene anche a distanza dalla lesione. Il nostro corpo gode di un territorio di rappresentazione nel nostro cervello, proprio come le informazioni visive vengono elaborate nei lobi occipitali, le informazioni del corpo vengono processate nelle aree dei lobi parietali.
Anche queste aree cerebrali sono plastiche e si modificano sulla base delle esperienze. Un esempio banale è quando perdiamo l'uso della vista, è risaputo che tutti gli altri sensi vengono amplificati, ma questo avviene su base biologica, ovvero la struttura del nostro cervello si riorganizza offrendo maggiore spazio e collegamenti alle abilità residue necessarie per la vita, e nel caso della cecità sono le informazioni del corpo (somestesiche) e quelle acustiche.
Un famoso studio condotto da Merzenich e Kaas, ha dimostrato che una lesione di uno dei nervi periferici dell'arto superiore della scimmia, determinava una riorganizzazione delle aree del cervello deputate all'analisi delle informazioni relative alle zone del corpo innervate dal nervo, si accorsero infatti che mancando stimoli dalle aree rimaste prive del collegamento nervoso, queste rispondevano agli stimoli provenienti dal territorio innervato dai nervi adiacenti. Questo fenomeno neuroplastico è molto importante perché ci fa comprendere, come il nostro organismo sia "attaccato alla vita" e difenda le nostre funzioni con la neuroplasticità, un'arma tra le più raffinate ed affascinanti.
Più recentemente l'eminente neurologo, Ramachandran, si rese conto che i pazienti amputati potevano percepire sensazioni di contatto sulla mano mancante se gli veniva toccato il viso. Tale fenomeno è spiegabile dalla vicinanza di alcune aree del cervello che corrispondono ad alcune funzioni della mano con quelle che invece rispondono al volto che si allargano negli spazi circostanti resi "disponibili" dalla mancanza di informazioni provenienti dalla mano stessa.
La modificabilità delle connessioni corticali in risposta all'esperienza si riduce progressivamente e, dopo la fine del periodo critico, è molto limitata, se non del tutto assente. Sono stati condotti numerosi studi per identificare i meccanismi molecolari responsabili del declino della plasticità neuronale che accompagna il completamento dello sviluppo del sistema nervoso. Il primo fattore che regola la chiusura dei periodi critici è l'esperienza stessa. La mancanza di una stimolazione ambientale appropriata, infatti, prolunga la durata dei periodi critici; ancora una volta è paradigmatico l'esempio del sistema visivo: è stato dimostrato che la corteccia di animali allevati al buio dalla nascita permane in uno stato di immaturità fino all'età adulta e la deprivazione monoculare rimane efficace nel modificare le proprietà di dominanza oculare dei neuroni corticali molto più a lungo di quanto accade negli animali vissuti in normali condizioni di luce. Questo suggerisce che l'esperienza regola l'espressione di alcuni fattori molecolari, la cui maturazione è responsabile della chiusura del periodo critico. I fattori neurotrofici sono stati il primo gruppo di molecole per cui è stata stabilita una relazione causale tra la loro azione e la durata del periodo critico di plasticità della corteccia visiva: è stato osservato, infatti, che l'allevamento al buio riduce l'espressione corticale di tali fattori e che il blocco della loro azione, indotto dalla somministrazione di anticorpi specifici, ritarda la chiusura del periodo critico, mentre l'incremento dell'espressione di BDNF in animali transgenici la accelera. Analogamente, l'allevamento al buio ritarda la maturazione dei circuiti inibitori della corteccia visiva, mentre un'anticipazione dello sviluppo della trasmissione GABAergica determina una precoce chiusura del periodo critico della plasticità di dominanza oculare. Il ruolo centrale esercitato dal tono inibitorio nella regolazione del decorso del periodo critico è stato recentemente consolidato dall'osservazione che la riduzione farmacologica del bilancio inibizione/eccitazione nella corteccia visiva di animali adulti ripristina completamente i fenomeni di plasticità indotti dalla deprivazione monoculare. Infine, è stato documentato che la maturazione della matrice extracellulare e la mielinizzazione determinano la stabilizzazione delle connessioni neurali, sopprimendo la plasticità neuronale nel cervello maturo.
Plasticità del Cervello nel Recupero Post Ictus
Come già detto, le alterazioni del movimento sono dovute alle alterazioni delle funzioni cognitive ed è quindi evidente che l'ictus è un danno subito dal cervello e non dai muscoli. In tale senso la riabilitazione dopo l'ictus deve essere mirata: si tratta infatti di recuperare i processi cognitivi che rendono possibile le funzioni. Dopo essere stati colpiti da ictus la plasticità cerebrale rappresenta un importante occasione di recupero.
Non solo l'emisfero cerebrale sano svolge un'azione che tende a compensare il danno subito dall'altro emisfero ma attraverso la riabilitazione viene stimolato il tessuto che crea le condizioni per l'apprendimento di nuove capacità motorie poiché i neuroni danno vita a nuovi percorsi. Avviene così una riorganizzazione delle funzioni cognitive attuata con meccanismi specifici attraverso la neuroplasticità : apprendere nuove capacità motorie per chi non è affetto da alcun danno cerebrale e recuperare abilità perse a causa di un danno hanno meccanismi simili. Si tratta cioè avviare un processo di apprendimento basato sulla capacità plastica del cervello grazie alla quale possono essere compensate le carenze funzionali. Il trattamento riabilitativo deve essere mirato: il nuovo apprendimento si basa sull'esperienza che stimolando la plasticità migliora funzionalità motoria e comunicazionale.
Plasticità Crossmodale
È stato dimostrato come la riorganizzazione delle connessioni del sistema nervoso, che si verifica in seguito alla deprivazione di un canale sensoriale, non interessi solo le aree cerebrali della modalità deprivata, ma si estenda anche ad altri sistemi sensoriali. È stato documentato, per es., che i soggetti ciechi hanno capacità tattili e acustiche superiori rispetto ai normovedenti e che l'esecuzione di compiti tattili raffinati, come la lettura Braille, o prove di localizzazione di una sorgente sonora, inducono l'attivazione della corteccia visiva di entrambi gli emisferi, in aggiunta, rispettivamente, alla corteccia somatosensoriale e a quella acustica. È interessante sottolineare, però, che informazioni sensoriali di natura diversa attivano aree differenti della corteccia visiva. Questa attivazione, non riscontrabile nella corteccia degli individui vedenti, è il segno della plasticità crossmodale e ha un preciso ruolo funzionale nell'elaborazione degli stimoli non visivi, che si riflette nelle migliori prestazioni percettive. La plasticità crossmodale non è limitata ai casi di deprivazione della modalità visiva, ma è presente anche nei soggetti con sordità congenita o diventati sordi nei primi anni di vita, che mostrano migliori abilità tattili e di visione periferica, correlate all'attivazione della corteccia uditiva, rispetto ai soggetti normoudenti.
Non è ancora del tutto chiaro, tuttavia, a quale livello agiscano questi processi. Una possibilità è che ingressi sensoriali diversi competano in maniera attività-dipendente per il controllo dei neuroni corticali delle aree associative polimodali: le afferenze più attive, ovvero quelle provenienti dalle modalità sensoriali intatte, rafforzerebbero le loro connessioni a scapito dell'ingresso deprivato, meno attivo, e la conseguente modifica delle proprietà dei neuroni polimodali sarebbe responsabile dell'attivazione della corteccia sensoriale deprivata in risposta a stimoli non specifici. Una seconda ipotesi, che non esclude la prima, prevede la presenza di connessioni ridondanti tra le diverse regioni del sistema nervoso: in caso di deprivazione del canale dominante di una corteccia sensoriale, le afferenze che veicolano le informazioni degli altri ingressi si potrebbero espandere, determinando il cambiamento delle proprietà di risposta dei neuroni corticali. Il risultato di questa competizione intermodale è un rimodellamento delle connessioni neurali, che ha l'effetto di compensare la deprivazione di un canale sensoriale con migliori prestazioni nei compiti che coinvolgono altre modalità.
| Indice |
| INTRODUZIONE |
|
| CONCLUSIONI |
| BIBLIOGRAFIA |
| Tesi di Laurea di: Dèsirée FRAGNELLI |