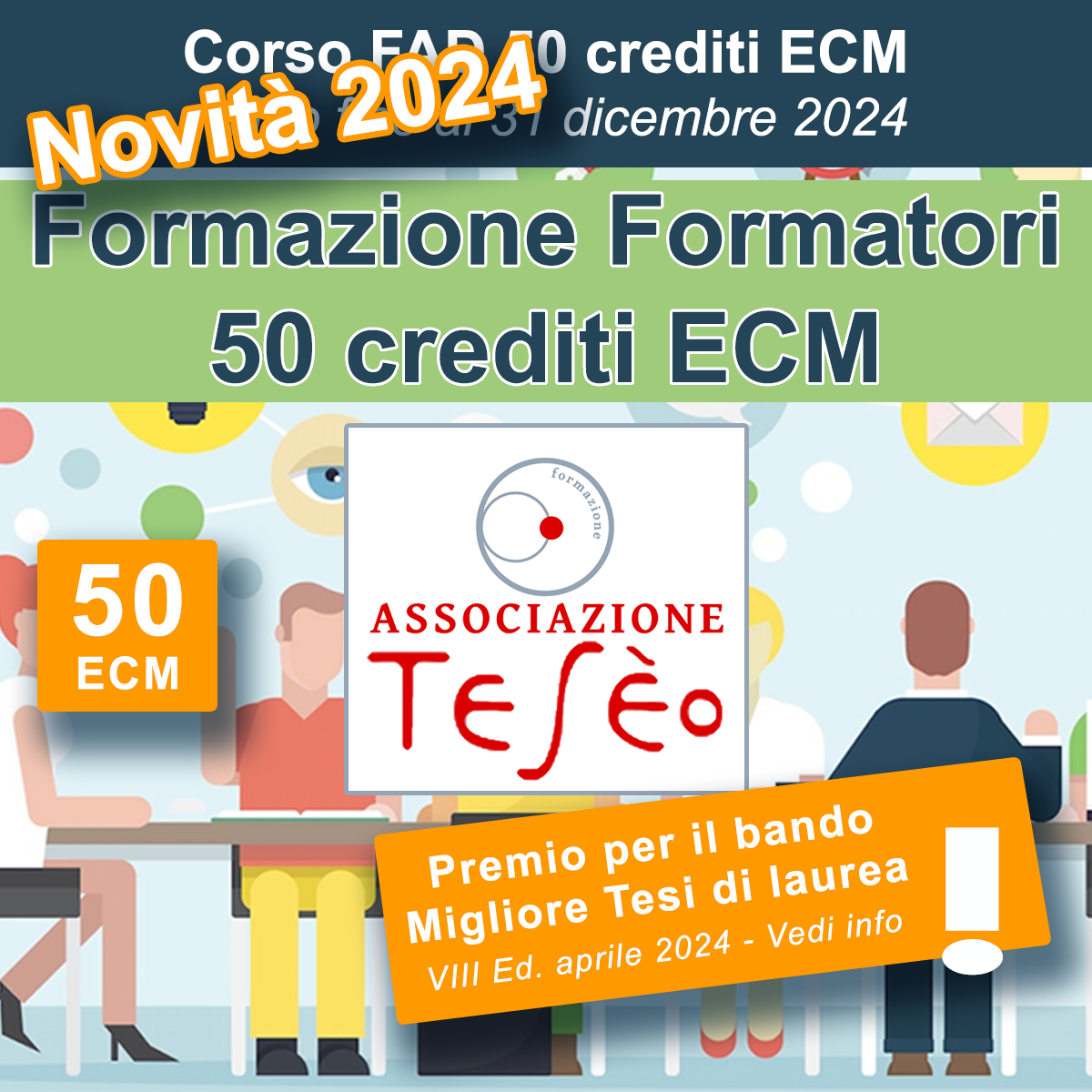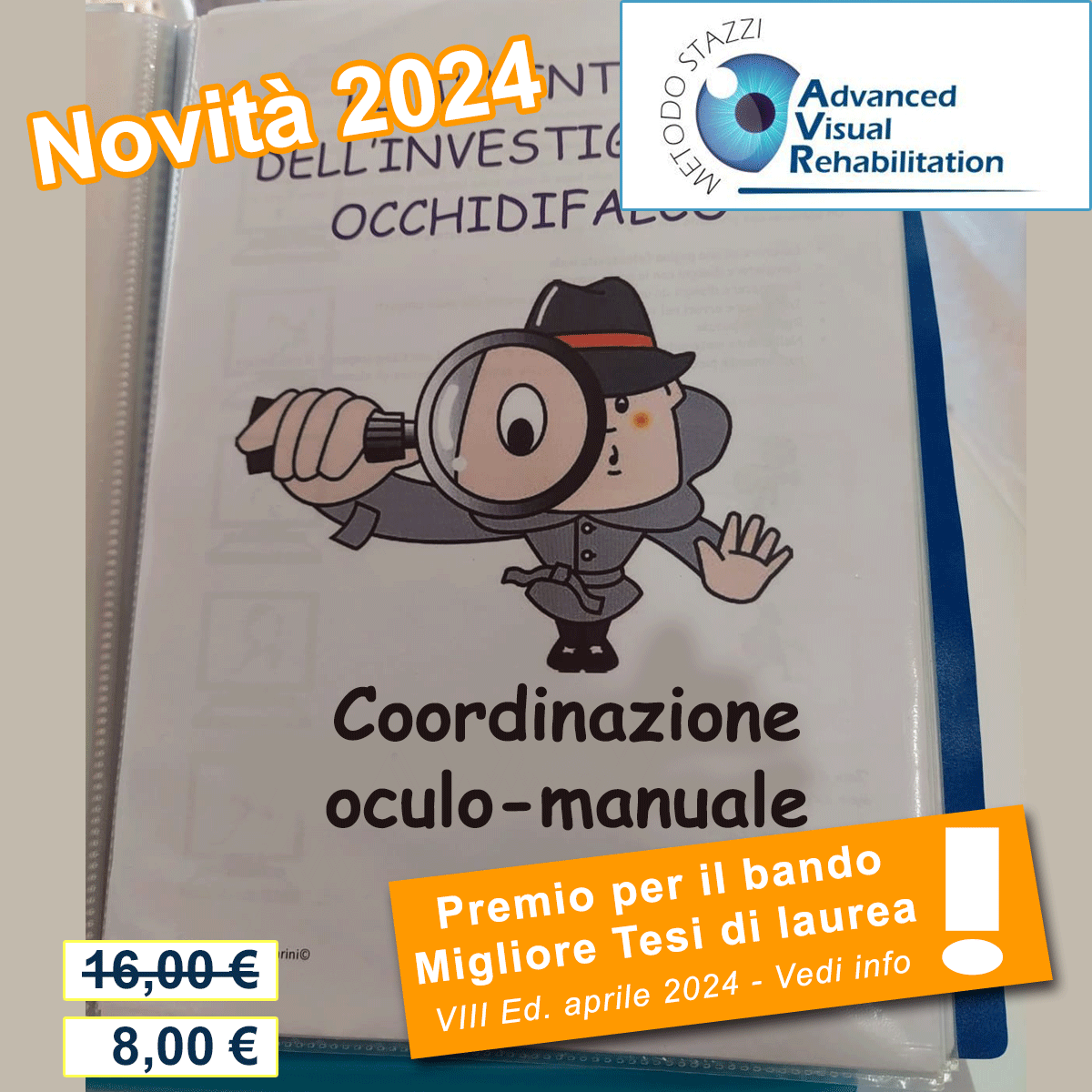IL VISSUTO CORPOREO - Concetto di "schema" e di "immagine"
La comparsa della malattia o l'esperienza di essa fa emergere, in tutte le persone, sentimenti e pensieri non sempre consapevoli che modificano il rapporto individuale sia con il mondo esterno che con se stessi.
La persona umana quando è ammalata lo è nella sua totalità, pertanto reagisce anche affettivamente a qualunque modificazione del suo stato fisiologico di base: la malattia colpisce sia il piano fisico che quello psicologico. Talvolta le persone si ammalano proprio a causa di difficoltà psichiche che incontrano nel corso della loro esistenza.
Qualsiasi evento morboso, sia esso benigno come una influenza o maligno come il cancro oppure qualsiasi altra malattia che colpisce la persona, produce importanti reazioni emotive, psicologiche e sociali.
La perdita o la mancanza di una funzione producono nell’individuo una importante modificazione dell'immagine di sè e dello schema corporeo. Questa “ferita” all'immagine di sè è generalmente associata ad un vissuto di angoscia e di dolore e, sul piano affettivo, equivale ad una vera e propria esperienza di lutto: l’ammalato “non è uguale agli altri” perché “manca di qualcosa per essere completo”.
Il sentimento di lutto, analogamente a qualsiasi altro lutto, se non elaborato, può precipitare la persona in uno stato di dolore e di depressione, anche di una certa gravità.
Per chiarire quanto detto nel paragrafo precedente a proposito della percezione del proprio corpo e dell’influenza dei fattori psicologici e sociali nell’immagine corporea, vale la pena osservare più da vicino quella che può essere la condizione di un soggetto cerebroleso, affetto, per esempio, da una forma grave di Paralisi Cerebrale Infantile quale è la tetraparesi spastica oppure da una delle altre forme.
In rapporto alla tetraparesi, la scienza medica non contempla un’analoga patologia che coinvolga contemporaneamente tutte le funzioni motorie, sensoriali e viscerali del corpo umano. Si tratta di un evento lesivo che comporta una gravissima alterazione dell’equilibrio psicofisico della persona: viene compromessa l’armonica relazione che esiste tra i diversi sistemi funzionali dell’uomo con conseguenti traumi non solo del Sé corporeo, ma anche di quello psichico e sociale.
Nel linguaggio comune il tetraplegico è, genericamente, una persona che non è più in grado di muovere gli arti, che sta in carrozzina, che ha più o meno gravi difficoltà di mobilità. Ma questo significa cogliere solo la disabilità più visibile. In realtà ci sono altre disabilità ancora più gravi ed invalidanti e tra esse, importantissima, la compromissione delle funzioni genito-sfinteriche e viscerali.
Prendendo in esame forme meno gravi osserviamo che per questi soggetti muoversi autonomamente in carrozzina non significa solo incontrare numerose e spesso invalicabili barriere architettoniche, avere difficoltà di inserimento nella vita lavorativa e sociale, ma è soprattutto dover fare i conti con l’alterazione della propria identità ed unità psicofisica, con la compromissione dello schema e dell’immagine corporea, con l’angoscia per la mancanza di parti di sé intesa come “senso di frammentazione”, e non ultimo bisogna fare i conti con i rapporti affettivi.
Abbiamo ampiamente detto che lo schema corporeo è il quadro mentale della nostra fisicità, vale a dire il modo in cui percepiamo di esistere come corpo, ma il corpo è anche ciò che trasforma gli eventi nelle immagini della nostra vita, che forma l’essenza del nostro vissuto: il significato delle mie mani non è solo nella loro struttura muscolare e nervosa, ma negli oggetti che riesco ad afferrare e in quelli che mi sfuggono; così anche per le gambe, il cui significato sta nelle cose che voglio raggiungere o fuggire. E’ nella relazione col mondo che il corpo può esprimersi con un senso. E’ chiaro che un corpo isolato dal mondo diventa oggetto, perché viene a mancare quel dialogo grazie al quale le cose si caricano delle intenzioni del corpo. Il corpo del cerebroleso grave è trasformato da “corpo d’intenzione” in “oggetto d’attenzione”, le potenzialità sono ridotte al minimo, il pensiero e l’azione sono separati: un tetraplegico non può pensare e fare simultaneamente, l’azione è progettata e configurata mentalmente nei dettagli prima di essere compiuta; è alterata la percezione dello spazio e del tempo: una persona in carrozzina guarda il mondo circostante e gli altri dal basso verso l’alto. Inoltre, dal momento che gli atti quotidiani richiedono molto più tempo e fatica e devono seguire un preciso rituale, non è infrequente percepire come lunghissimo un istante ed attribuire ad una intera giornata la durata di sole due o tre ore: basti pensare che il gesto della normale minzione può richiedere anche più di mezz’ora per un cateterismo o un cambio di pannolino o di raccoglitore, e non può essere effettuato in un luogo qualsiasi. E alzarsi dal letto e passare in carrozzina può richiedere parecchi minuti. E’ inevitabile un sentimento di mancanza, di impedimento e d’inferiorità.
Altro discorso riguarda quei bambini per cui si richiede terapia psicomotoria per “Disturbi dello schema corporeo”: non cè lesione cerebrale, non c’è danno organico e i sintomi che si osservano non sono altro che una manifestazione del disagio che il soggetto sente nel vivere, nel comunicare. All’esame psicomotorio i deficit riguardano la goffaggine, l’imprecisione degli atti, la disorganizzazione spazio-temporale, quadri di disprassia, lateralità non ben acquisita, difficoltà di coordinazione.
Questi bambini hanno difficoltà a stabilire una buona sintonia col proprio corpo, lo usano in modo deficitario o si rifiutano di usarlo, e questo rimanda ad una difficoltà più generale di riconoscersi, di accettarsi, di comunicare con gli altri e con il mondo: in primo piano ci sono problemi di investimento del corpo, di identificazione, c’è la storia del soggetto, il suo vissuto.
Nella rieducazione la domanda che si pone è: come raggiungere il problema principale? Pur procedendo attraverso tecniche ed esercizi che portano il bambino a conoscere ed usare il proprio corpo, non possiamo sapere fino a che punto egli integrerà queste conoscenze. Non ci si può dimenticare delle esperienze affettive, della storia del bambino, del suo vissuto, anche se questo è un aspetto difficile da afferrare.
Allora le basi della integrazione psico-motoria vanno trovate non solo nell’azione ma anche nella costruzione di un clima relazionale che permetta di assimilare l’azione: “E’ necessario il ritorno ad esperienze piuttosto lontane, in un clima particolarmente rassicurante e comprensivo” (H.Bucher, 1974).
Il bambino deve superare certe tappe del suo passato, e questo avviene necessariamente attraverso la rassicurazione sul piano affettivo; poi i risultati che si otterranno negli esercizi, con la scoperta delle proprie possibilità e il superamento di difficoltà sempre maggiori costituiranno quella nuova fonte di motivazioni che supera il piano prettamente relazionale.
Infine, occorre che il soggetto trasporti e utilizzi le sue nuove capacità anche fuori dall’ambito terapeutico e quindi in altre relazioni, per cui è meglio continuare il trattamento per un po’ anche se le difficoltà sono superate.
Indice |
|
| Capitolo 1 | 1 CONCETTO DI "SCHEMA" E DI "IMMAGINE" |
| 1.1. CENNI STORICI | |
| 1.2. ALCUNE DEFINIZIONI | |
| 1.3. IN SINTESI | |
| 1.4. ALTRI TERMINI DA DEFINIRE | |
| 1.5. IL VISSUTO CORPOREO | |
| Capitolo 2 | 2 EVOLUZIONE DELLO SCHEMA CORPOREO |
| 2.1. NEUROANATOMIA | |
| 2.2. PSICOLOGIA | |
| 2.3. LE FASI DELLA STRUTTURAZIONE | |
| 2.4. ALCUNI ASPETTI DELL’ EVOLUZIONE | |
| 2.5. LATERALITA’ E LATERALIZZAZIONE | |
| 2.6. STUDI SULLO SVILUPPO DELLO SCHEMA CORPOREO | |
| Capitolo 3 | 3 I DISTURBI DELLO SCHEMA CORPOREO |
| 3.1. COME CLASSIFICARE | |
| 3.2. CHE COSA COMPORTANO TALI DISTURBI | |
| 3.3. VALUTAZIONE DELLO SCHEMA CORPOREO | |
| Capitolo 4 | 4 SCHEMA CORPOREO : TRATTAMENTO |
| 4.1. DIVERSI APPROCCI TERAPEUTICI | |
| 4.2. TERAPIA PSICOMOTORIA | |
| 4.3. CONCLUSIONE | |
| BIBLIOGRAFIA e RIFERIMENTI LINKS | |
| Tesi di Laurea di: Luciano MONTEFUSCO | |