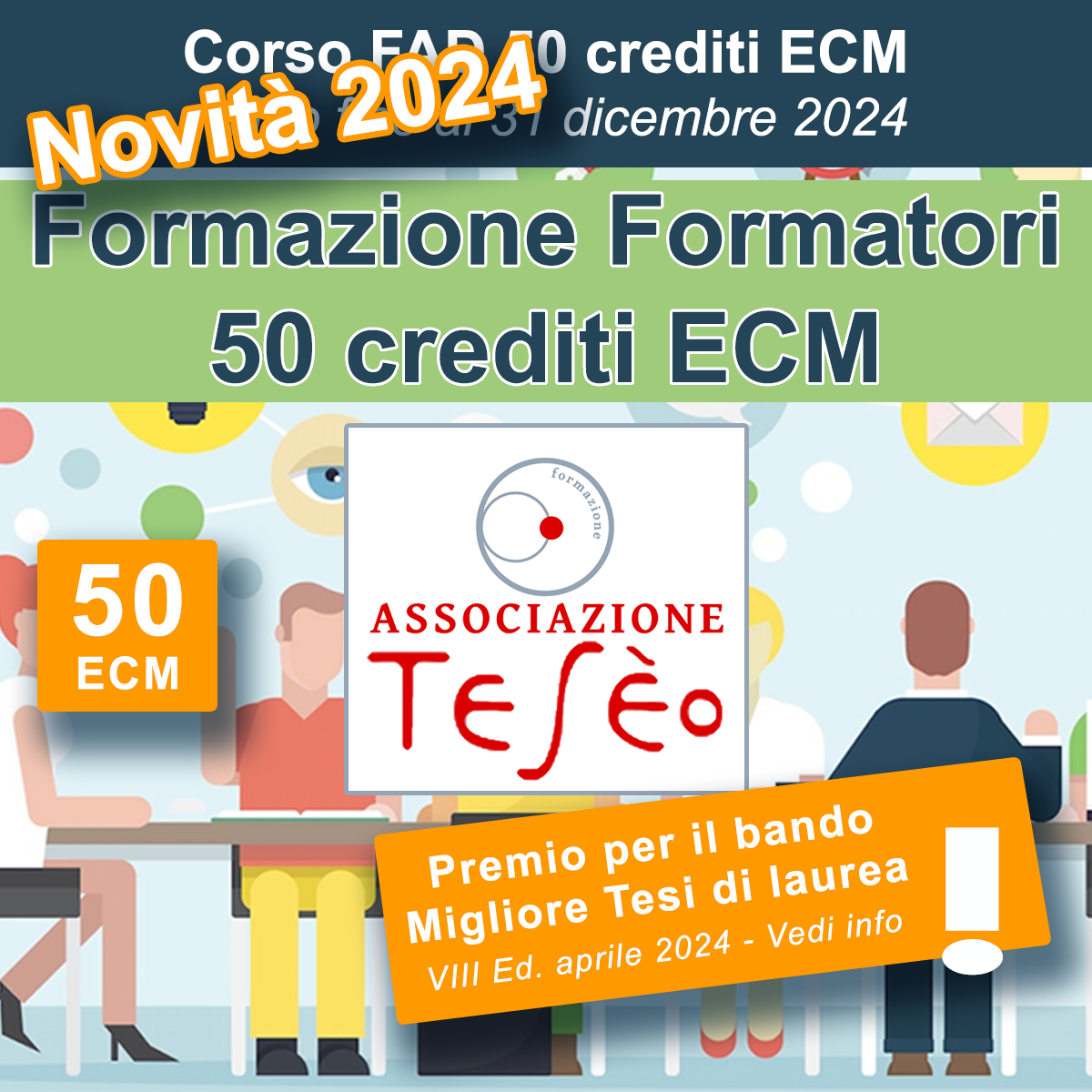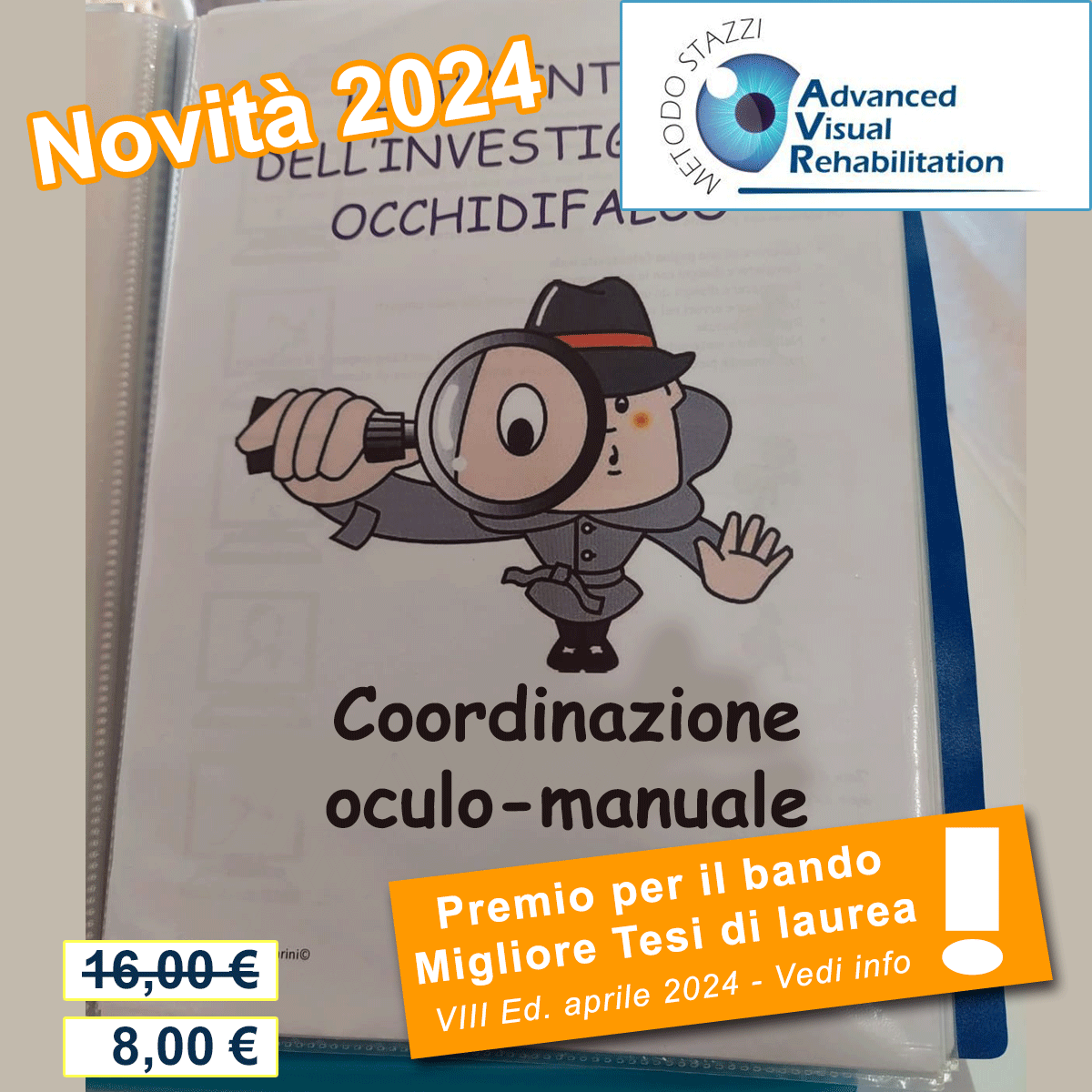LA SINDROME DI MOEBIUS: epidemiologia, classificazione ed eziopatogenesi
Definizione
La Sindrome di Moebius, anche detta “diplegia facciale congenita” o “paralisi del VI e VII paio di nervi cranici” o “paralisi oculo-facciale congenita”, è una malattia congenita non-progressiva rara, caratterizzata da una paralisi completa o parziale del VI e del VII nervo cranico, sia unilaterale che bilaterale, frequentemente accompagnata dalla disfunzione di altri nervi cranici e da diversi tipi di malformazioni.
Fu descritta per la prima volta da Von Graefe nel 1880, tramite il contributo di Harlon e Chisolm che presentarono alcuni casi. Più tardi, nel 1888, Paul Julius Moebius (Lipsia, 24 Gennaio 1853-8 Gennaio 1907) studiò e classifico i pazienti affetti dalla sindrome, ampliando ulteriormente i segni e i sintomi descritti da Von Graefe e conquistando, così, distinzione eponimica.
Caratteristica peculiare dei pazienti affetti dalla sindrome di Moebius è la completa o parziale assenza della mimica facciale, si parla infatti di “bambini senza sorriso”, che presentano molteplici problemi estetici (assenza della mimica facciale), funzionali (suzione, competenza orale, pronuncia di alcuni fonemi) e psico-sociali (impossibilità di comunicare le proprie emozioni, stigmatismo sociale, emarginazione, depressione).
Epidemiologia
La Sindrome di Moebius ha un’incidenza nel mondo di circa un caso ogni 100.000 nati, ragion per cui è possibile annoverarla fra le patologie definite rare. In Italia si stima che nascano cinque o sei casi all'anno e le persone affette siano circa 500-600. Il 50% dei casi di sindrome di Moebius è caratterizzato dalla presenza di paralisi bilaterale o unilaterale, totale o parziale, dei nervi cranici VI e VII associata a deformità multiple degli arti (Baraitser, 1977; Salmon, 1978; Potparic e Gibson, 1995).
Tale patologia si presenta fin dalla nascita, colpendo maschi e femmine in uguale misura e sembra che ci sia, in alcuni casi, un rischio maggiore di trasmissione della malattia da genitori affetti ai loro bambini: ci sono alcune famiglie segnalate in cui è presente più di un membro affetto (Haslam e Lowry, 1990; Thoene e Smith, 1992; Sherer e Spafford, 1994;. Kremer et al, 1996) oppure in cui uno dei genitori possiede una debolezza facciale o un difetto alle estremità degli arti (Collins e Schimke, 1982; Mitter e Chudley, 1983;. MacDermot et al, 1990); questo dal punto di vista genetico sembra essere legato alla presenza di un parente del probando con parziale manifestazione della malattia o alla presenza di eredità mendeliana di un disordine che imiti le sindromi oromandibolari-ipogenesie degli arti, pur differenziandosi nettamente da loro (Gorlin et al., 1990 ). È stato riportato, inoltre, che l’aumento della frequenza dei matrimoni tra consanguinei predisponga a una maggiore insorgenza della malattia. In presenza di malformazioni scheletriche associate, il rischio di trasmissione alla prole è circa del 2%, mentre nel caso di diplegia facciale, con o senza coinvolgimento della muscolatura oculare, la predisposizione ereditaria diventa maggiore. Le caratteristiche che possono indicare un rischio di ricorrenza del 25%-30% sono l'assenza di difetti scheletrici, paralisi facciale isolata, sordità, oftalmoplegia e contratture digitali (MacDermot et al., 1990).
Classificazione
Nel corso degli anni i tentativi di classificazione delle varie forme di sindrome di Moebius sono stati vari. Dal punto di vista patogenetico, la classificazione più recente è quella di Towfighi et al. (1979), che suddivisero la malattia in quattro principali categorie: a)I Categoria, comprende i casi con aplasia/ipoplasia dei nuclei dei nervi cranici; b) II Categoria, comprende i casi con un coinvolgimento periferico dei nervi cranici; c) III Categoria comprende i casi che dimostrano la necrosi o la distruzione dei nuclei dei nervi cranici; d) IV Categoria, comprende i casi con un deficit primitivo miopatico. Le analisi cliniche, l'esame patologico e gli studi elettromiografici hanno fornito prove di tutte queste lesioni nervose a livello sopranucleare, nucleare e periferico, oltre che fibrosi e disturbi miopatici o assenza del muscolo (Van Allen e Blodi, 1960; Hanson e Rowland, 1971) .
Dal punto di vista clinico sono stati elaborati 2 tipi di classificazione, di cui la più recente è anche quella maggiormente utilizzata:
- Tentamy e McKusick (1978) distinsero tre principali entità cliniche, che consistevano in a) paralisi isolata del VI e del VII nervo cranico; b) paralisi dei nervi cranici VI e VII con artrogriposi multipla congenita; c) paralisi dei nervi cranici VI e VII con anomalie degli arti associate.
- JK Terzis (2003) suddivide tale patologia in:
- Sindrome di Moebius, con paralisi completa bilaterale del nervo facciale e dell’abducente;
- Sindrome di Moebius incompleta, in presenza di movimenti residui in un lato del viso;
- Forme Moebius‐Like, con paralisi monolaterali associate al coinvolgimento di altri nervi cranici.
Tale suddivisione presenta implicazioni importanti anche dal punto di vista terapeutico dal momento che la presenza di unità motorie residue condiziona anche la scelta del trattamento da riservare al paziente.
Classificazione dal punto di vista delle caratteristiche cliniche oculistiche
Recentemente, il 15 Febbraio 2011, è stato pubblicato un articolo nella Gazzetta di Parma che tratta di una nuova classificazione oculistica della sindrome di Moebius redatta dall’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma (sede nazionale per la diagnosi e cura di tale malattia dal 1999) in collaborazione con l’Associazione Italiana Sindrome di Moebius onlus (AISMo). In questo lavoro sono state riportate le caratteristiche cliniche, con particolare riferimento a quelle oculistiche, di una casistica di 52 bambini provenienti da tutta Italia ed affetti dalla sindrome.
La ricerca ha descritto tre pattern di alterazione della motilità oculare causati dalla malattia:
- Pattern A (41% dei casi): assenza di strabismo con un deficit totale nel muovere gli occhi lateralmente, mimando quindi quella che è una paralisi di sguardo orizzontale. Le persone compensano questo deficit eseguendo ampi movimenti laterali con la testa per osservare un oggetto posto di lato. I movimenti oculari verticali sono normali.
- Pattern B (50% dei casi): strabismo convergente con fissazione crociata; in questo caso il bambino esplora lo spazio visivo dx con l’occhio sx, e viceversa. Movimenti oculari verticali normali.
- Pattern C (9% dei casi): strabismo orizzontale divergente al quale si associa sempre anche una deviazione verticale degli occhi.
I bambini con il Pattern A non devono essere sottoposti a nessun particolare iter riabilitativo oculistico, mentre invece nei Pattern B e C è previsto un approccio di tipo chirurgico per curare lo strabismo, oltre che un iter riabilitativo oculistico importante finalizzato ad uno sviluppo normale della loro vista.
Eziopatogenesi
Data la rarità della malattia e la sua associazione con diversi tipi di anomalie, dalla data della sua scoperta fino ad ora sono state avanzate numerose ipotesi e teorie riguardanti la sua eziologia e la sua patogenesi, ma nessuna di esse è ancora stata riconosciuta, anche se tutte insieme hanno contribuito a delineare i vari aspetti di questa patologia. Dopo la prima descrizione di Harlan (1881) di un paziente con paralisi bilaterale congenita del viso e paralisi del muscolo retto esterno, sono state pubblicate molte eccellenti recensioni sulla sindrome di Moebius, in cui sono state discusse varie teorie. Inizialmente, Moebius (1892) ritenne che le varie lesioni dei nervi cranici fossero causate da un processo degenerativo o da un agente tossico, ma autori successivi smentirono questa visione di fronte all’assenza di evidenze morfologiche di degenerazione.
Heubner (1900) descrisse un caso il cui quadro patologico mostrava l’assenza di cellule gangliari nei nuclei motori di alcuni nervi cranici e uno scarso sviluppo della formazione reticolare, dell’oliva e del tratto piramidale.
Rainy e Fowler (1903) pensarono che la patologia inizialmente colpisse i muscoli e secondariamente comportasse un’alterazione degenerativa nei nuclei motori.
Più tardi, Lennon (1910) ipotizzò che il difetto potesse essere o di tipo degenerativo o displasico e che potesse coinvolgere sia il tronco cerebrale, sia il nervo facciale a livello dell'osso temporale, sia la muscolatura del viso.
Da quel momento, come sottolineato da Richter (1960), la discussione sulla sindrome si incentrò principalmente su due punti, ovvero se il disturbo fosse principalmente degenerativo o displasico e su dove fosse localizzata la sede del difetto primario.
Riguardo al primo punto, la maggior parte delle prove sono a favore della teoria displasica. Una prova indiretta, infatti, sarebbe di per sé il decorso statico della malattia, visto che una degenerazione sarebbe destinata a continuare nella vita post-natale. Nonostante ciò, diversi risultati sullo studio di alcuni casi sono a sostegno della teoria degenerativa, come per esempio il caso di paralisi unilaterale congenita del viso, descritto da Marfan e Armand-Delille (1901), in cui erano presenti dei cambiamenti degenerativi nel tronco cerebrale; si pensa, però, che la degenerazione non sia altro che una conseguenza secondaria di un intrappolamento del nervo facciale nell’osso temporale malformato o della pressione intrauterina sul nervo facciale durante il suo sviluppo. Inoltre alterazioni degenerative non sono state segnalate da nessuno degli autori che ha esaminato un caso inequivocabile di sindrome completa.
Riguardo al sito di malformazione primaria, in letteratura sono state avanzate, principalmente, due teorie:
- Teoria Periferica, sostiene che la sindrome di Moebius sia una displasia del mesoderma che coinvolge la muscolatura derivata dagli archi branchiali (e spesso anche la muscolatura derivata dai somiti) e che eventuali modifiche trovate nel tronco cerebrale siano secondarie. I fautori di questa visione sembrano essere Lennon (1910), Richards (1953), Evans (1955), e Wallis (1960) (vedi Tabella I).
- Teoria Centrale, sostiene che la sindrome sia il risultato di una displasia ectodermica che coinvolge principalmente il sistema nervoso centrale, e che ogni anomalia muscolo-scheletrica associata sia secondaria o fortuita. Sostenitori di questa ipotesi sono Heubner (1900), Spatz e Ullrich (1931), Richter (1958, 1960), e Van Allen e Blodi (1960) (vedi Tabella I).
Tabella I - Difetti postulati nella Sindrome di Moebius
|
Tipo di difetto |
Autore e anno |
|
|
|
|
I. Degenerativo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. II displastico o aplastico |
|
|
|
|
|
|
|
Nel 1938, inoltre, O. Ullrich formulò una terza teoria, nella quale sosteneva il coinvolgimento sia del mesoderma che dell’ectoderma nella patogenesi della sindrome. Descrisse un evento chiamato “ forma asimmetrica dello stato di Bonnevie-Ullrich” che si presentava con paresi di più muscoli innervati dai nervi cranici e con deformità degli arti associate. Egli basò la sua teoria sugli esperimenti di Bonnevie[1] (1934) e, al lavoro di quest’ultimo, aggiunse l’azione della pressione sul pavimento del quarto ventricolo, causata dalla sovrapproduzione di liquido spinale, che poteva comprimere i nuclei di sviluppo del nervo facciale e dell’abducente e quindi causare diplegia facciale e paresi dello sguardo laterale, spiegando così la comparsa della paralisi dei nervi cranici e la deformità degli arti. Questa teoria, però, come sostengono Van Allen e Blodi (1960) e Adams , Denny-Brown e Pearson (1962) , manca di credibilità poiché è stata maggiormente provata sugli animali che sull’uomo, nonostante alcune parti potrebbero comunque essere applicate alla sindrome di Moebius(Evans, 1955).
Inoltre, non si può escludere la possibilità che la sindrome sia il risultato del coinvolgimento di entrambi, mesoderma ed ectoderma, da parte di un fattore sconosciuto o di fattori che operano presto nella embriogenesi.
Un anno dopo, oltretutto, Henderson (1939) cercò di mettere in evidenza le analogie tra la sindrome di Moebius e quella di Bonnevie-Ullrich (variante ereditaria della sindrome di Turner che si manifesta nei neonati con linfedema delle mani e dei piedi, al quale fa seguito lassità cutanea, anomalie facciali, nanismo, ritardo mentale) per spiegare i diffusi difetti somatici, ma non poté associare questo con l’agenesia dei nuclei dei nervi cranici.
Oltre a ciò, però, rivalutò la condizione della sindrome e descrisse in maniera dettagliata i tratti tipici della malattia: paralisi completa o incompleta, unilaterale o bilaterale, dei muscoli della faccia, soprattutto della metà superiore; paralisi del muscolo retto esterno e l’occasionale coinvolgimento dei muscoli innervati dai nervi cranici III, V e XII; piede torto ( 1/3 dei casi); difetto del muscolo gran pettorale con ipoplasia mammaria (come una delle anomalie associate più comuni); possibile scarso sviluppo della muscolatura generale; deformità di una mano o di un braccio, delle orecchie e del naso; assenza delle caruncole e delle ghiandole lacrimali; micrognazia; alto palato ogivale; disturbi vasomotori e difetti mentali.
Nel 1955, Evans sottolineò che tutti i difetti principali colpivano le strutture che andavano a differenziarsi intorno alla fine del secondo mese di vita intrauterina e considerò che la patologia primaria fosse probabilmente nel muscolo.
Sprofkin e Hillman (1956) discussero la somiglianza con le malattie di Werdnig Hoffman[2] e di Oppenheim[3].
Patricia G. Wallis (1959), in alcuni neonati con sindrome di Moebius, ritrovò alti livelli di creatinuria, che sembravano indicare che la debolezza muscolare fosse dovuta ad una miopatia piuttosto che ad un’agenesia nucleare. Inoltre, l'occasionale ritrovamento di un’incidenza familiare sembrò sostenere l’ipotesi che l’eziologia della sindrome era costituita da una singola mutazione genetica che produceva un difetto enzimatico ed un’anomalia negli organizzatori del secondo mese di vita intrauterina.
Samuel E. Pitner, James E. Edwards and William F. Mccormick, nel 1965, descrissero i risultati della necroscopia di un paziente con la sindrome di Moebius (si pensa sia il primo caso segnalato in cui il cervello, i nervi facciali e i muscoli coinvolti siano stati tutti esaminati) e, partendo dall’ipotesi che la sindrome fosse dovuta ad una displasia di tutti i muscoli coinvolti o dei nuclei motori del tronco cerebrale, arrivarono alla conclusione che in quel caso la causa fosse una displasia dei muscoli facciali, ma, per analogia con l’artrogriposi, venne ritenuto probabile che entrambe le forme, miopatica e neurogena, della sindrome potessero esistere (poiché arrivarono a considerare tale patologia come una sorta di “artrogriposi bulbare”, in quanto, avendo più di una eziologia, poteva coinvolgere il tronco cerebrale e/o la muscolatura derivata dagli archi branchiali proprio come, allo stesso modo, l’artrogriposi poteva coinvolgere il midollo spinale e/o la muscolatura derivata dai somiti). Ma questa affermazione risultò solo di natura provvisoria, in quanto, in accordo con quanto affermavano Hamburger e Levi-Montalcini (1950), ritennero che bisognasse adottare molta cautela nell’assegnare il ruolo primario ad uno o ad un altro sito visto che le relazioni tra le strutture nervose ed i loro campi periferici, in un embrione, risultavano estremamente complesse e non comprese del tutto.
Thakkar et al. (1977) e, più tardi, Sudarshan e Goldie (1985) avanzarono nuove ipotesi sulle possibili cause, come ad esempio una disgenesi dei nuclei dei nervi cranici, un infarto o un’emorragia del tronco cerebrale, un’ infezione congenita e dei traumi durante il parto, ma nessun singola ipotesi risultò sufficiente per tutti gli aspetti fisiopatologici della sindrome.
Bouwes-Bavinck e Weaver, nel 1986, con i loro risultati dimostrarono che la sindrome di Moebius era causata da un’interruzione delle forniture di sangue embrionale e che la portata e la natura dei difetti associati dipendesse dalle località specifiche di insufficienza vascolare.
Ipotizzarono che la prematura regressione, ostruzione, o rottura delle arterie primitive del trigemino (prima della costituzione di scorte di sangue sufficienti dalle arterie vertebrali per il tronco cerebrale) o l’ostruzione delle arterie vertebrali e basilare, portando ad ischemia con necrosi dei nuclei dei nervi cranici VI e VII, potessero essere quindi la causa della sindrome.
Thakkar et al. (1977)e, successivamente, D'Cruz et al. (1993) concordarono che l'eziologia primaria, di tipo vascolare, si manifestasse nei nuclei del tronco encefalico durante il periodo prenatale. A sostegno di ciò (D'Cruz et al., 1993) vi sono reperti radiologici come l’ipoplasia e la calcificazione del tronco cerebrale, insieme con la presenza di depositi mineralizzati non progressivi nella distribuzione vascolare.
Questi eventi tendono a verificarsi durante lo sviluppo della circolazione posteriore, intorno alla quarta-ottava settimana di gestazione, portando a difetti multipli dei sistemi e degli organi (Rogers et al, 1977;. Bouwes Bavinck e Weaver, 1986; D'Cruz et al, 1993. ; San Carlo et al, 1993). I fattori ambientali che potrebbero aggravare questo difetto vascolare comprendono: (1) infezioni (rosolia), (2) ipertermia, (3) ipossia generalizzata, e (4) farmaci (Van Allen, 1981). Benzodiazepine, cocaina, talidomide[4], metaqualone e misoprostolo[5] sono tutti nomi di farmaci potenzialmente teratogeni se assunti durante il primo trimestre di gravidanza. Anche il diabete gestazionale è stato associato alla sindrome di Moebius (Nardelli et al, 1982;. Sudarshan e Goldie , 1985; Courtens et al, 1992;. Kankirawatana et al, 1993;. Shepard, 1995; Preis et al, 1996).
Kankirawatana et al. (1993) intuirono, invece, che la sindattilia / brachidattilia delle dita dei piedi del bambino derivasse da un effetto combinato di alcol e cocaina. Inoltre, furono segnalati anche casi in cui la malattia fosse dovuta a precedenti interventi chirurgici all'utero, a minacce d’aborto, a scosse elettriche o ad abuso di alcool (Potparic e Gibson, 1995).
Come già accennato all’inizio, l’eziologia e la patogenesi della sindrome di Moebius sono tuttora incerte. E’ probabile che il sito, la natura e l’estensione della lesione siano diversi nei vari casi. Attualmente vengono date due principali spiegazioni per tale malattia:
- causa genetica primaria, un difetto metamerico primario a livello dei nuclei del cervello nella regione del tegmento.
- causa ischemica primaria, il processo ischemico risultante dall’interruzione dell’apporto vascolare del cervello durante le prime fasi dello sviluppo fetale.
Un importante fattore eziologico che può intervenire in entrambe queste ipotesi è la teratogenicità.
In particolare, negli ultimi anni, grazie anche ai progressi compiuti nel campo della genetica, sembra emergere una compartecipazione di fattori genetici ed ambientali che portano a disfunzioni durante lo sviluppo fetale responsabili del verificarsi del quadro patologico. Tra i vari fattori di rischio abbiamo la rottura prolungata delle membrane, l’assunzione durante la gravidanza di farmaci con effetto teratogeno e tutte le altre cause riportate dalla letteratura a partire da Bouwes-Bavinck e Weaver.
Il meccanismo patogenetico comune sembra essere una diminuzione del flusso di sangue nei vasi uterini con danni al feto a causa di emorragia dai vasi e di ipossia dei tessuti fetali associati. L’ipotesi di una causa genetica si è fatta strada negli anni per la rilevanza di sempre più famiglie affette da tale malattia, anche se non mancano casi sporadici di sindrome di Moebius. I vari studi di genetica che sono stati condotti hanno messo in evidenza come diversi loci genetici siano implicati nella Sindrome di Moebius. Si è osservato, in special modo, che esistono 4 diverse regioni, localizzate su 4 diversi cromosomi[6], che possono essere sede frequente di alterazioni genetiche nella sindrome.
A seconda della regione colpita dall’alterazione è stato possibile classificare la sindrome di Moebius in 4 sottotipi: MBS 1, 2, 3 e 4. Si è ipotizzato che una delle sedi più frequentemente alterata nella Sindrome potesse risiedere a livello di una regione del cromosoma 13, ed in particolare a livello della regione identificata con il nome 13q 12.2-q13 (MBS1). Attraverso studi di biologia molecolare, nel 1996, Kremer ha escluso che il cromosoma 13 potesse essere la regione interessata dalle alterazioni genetiche durante lo sviluppo di tale malattia.
Contemporaneamente, egli è riuscito a localizzare un nuovo gene responsabile della paralisi facciale, posizionato questa volta sul cromosoma 3 (nella regione definita tecnicamente 3q 21-22). La scoperta di tale gene, che viene anche ereditato con modalità autosomica dominante, ha portato all’identificazione di un nuovo sottogruppo, definito MBS 2. Negli anni successivi, sempre attraverso analisi di biologia molecolare, è stato possibile identificare un nuovo locus coinvolto: 10q21.3-22.1 (Verzijl et al.,1999) (MBS3). I dati emersi da quest’ultimo lavoro hanno dimostrato, inoltre, come la patologia abbia una penetranza più bassa rispetto a quella riferita da Kremer nel 1996, il quale affermava che il gene/i coinvolto/i venivano trasmessi con modalità dominante (per cui se un individuo aveva 2 copie di uno stesso gene ereditate ognuna da un genitore e 1 copia sola era sana, la copia malata prendeva il sopravvento).
Infatti, hanno considerato anche la possibilità che il gene malato non dovesse per forza prendere il sopravvento, ragion per cui l’individuo poteva risultare anche portatore sano della malattia. Questo dato è fondamentale per meglio interpretare i casi sporadici descritti in letteratura, i quali potrebbero essere in realtà l’espressione di una malattia ereditaria a bassa penetranza, influenzata da altri fattori. In letteratura (Donhoue et al. 1993) (Nishikawa et al. 1997) sono state riportate, inoltre, altre prove di alterazioni geniche, riscontrate, in particolare, in due casi sporadici di sindrome di Moebius, che hanno portato ad ipotizzare che un altro gene per la malattia fosse localizzato all’interno o vicino alla banda definita p22 del cromosoma 1 (1p22) (MBS4).
Una volta individuate quali sono le regioni dei cromosomi che possono andare incontro ad alterazioni, si è cercato di andare ancora più a fondo nella conoscenza di questa malattia. In particolare, poiché ogni regione cromosomica contiene diversi geni, sono stati analizzati nel dettaglio tutti i geni che potevano essere alterati, ma nessuno di quelli visti è risultato effettivamente alterato in tutti i casi della sindrome analizzati.
Il dato fondamentale che comunque emerge da tutti questi lavori è costituito dall’identificazione di una eterogeneità genetica per questa rara malattia, per cui ci sono più cromosomi e più geni coinvolti nel suo sviluppo. Ancora, però, non è nemmeno chiaro il meccanismo con cui viene trasmessa dai genitori ai figli, in quanto sono stati proposti 3 diversi meccanismi di trasmissione:
- eredità autosomica dominante (come accennato prima).
- eredità autosomica recessiva (in questo caso tutte e 2 le copie del gene devono essere malate per sviluppare la malattia).
- eredità legata all’X, quindi legata al sesso (i maschi o sono sani o sono malati, mentre le femmine possono essere anche portatrici sane).
Nonostante tutto, nessuno degli studi sopra menzionati ha riportato prove attendibili sulla eziopatogenesi di questa malattia. Questi studi possono solo supporre una relazione tra la causa e la presenza della sindrome di Moebius.
- [1] Studiò l’evoluzione di deformità geneticamente determinate in una famiglia di topi, ipotizzando che alcune cisti, sviluppatesi nel mielencefalo a causa di una sovrapproduzione di liquido spinale, potevano migrare negli abbozzi degli arti e dell’occhio e, a causa della pressione, portare a deformità, che solo negli arti andavano a corrispondere con le anomalie della sindrome di Moebius, mentre nell’occhio ne causavano altre di tutt’altro genere; inoltre la muscolatura del viso o quella extraoculare non venivano coinvolte.
- [2] La più grave forma di atrofia muscolare spinale; può iniziare prima della nascita o poco dopo ed i bambini colpiti sono raramente in grado di sollevare la testa o sviluppare un movimento normale; la deglutizione, la respirazione e l’alimentazione possono essere difficili.
- [3] Detta anche amiotonia congenita, è una rara malattia che colpisce i bambini già alla nascita e che si esprime con una spiccatissima diminuzione del tono muscolare, senza però accompagnarsi ad atrofia o a paralisi.
- [4] Farmaco utilizzato nella cura delle leucemie, che ha determinato tra l’altro la nascita di molti bambini focomelici.
- [5] Analogo sintetico delle prostaglandine, utilizzato per disturbi gastrici come antisecretivo e citoprotettore.
- [6] Queste regioni sono dette loci.
Indice |
| INTRODUZIONE |
|
CAPITOLO I LA SINDROME DI MOEBIUS: epidemiologia, classificazione ed eziopatogenesi
CAPITOLO II
CAPITOLO III LA SINDROME DI MOEBIUS: prognosi, diagnosi e terapia
CAPITOLO IV Progetto Riabilitativo nella Sindrome di Moebius
|
| CONCLUSIONI |
| BIBLIOGRAFIA e SITOGRAFIA |
| Tesi di Laurea di: Alessandra MURRU |